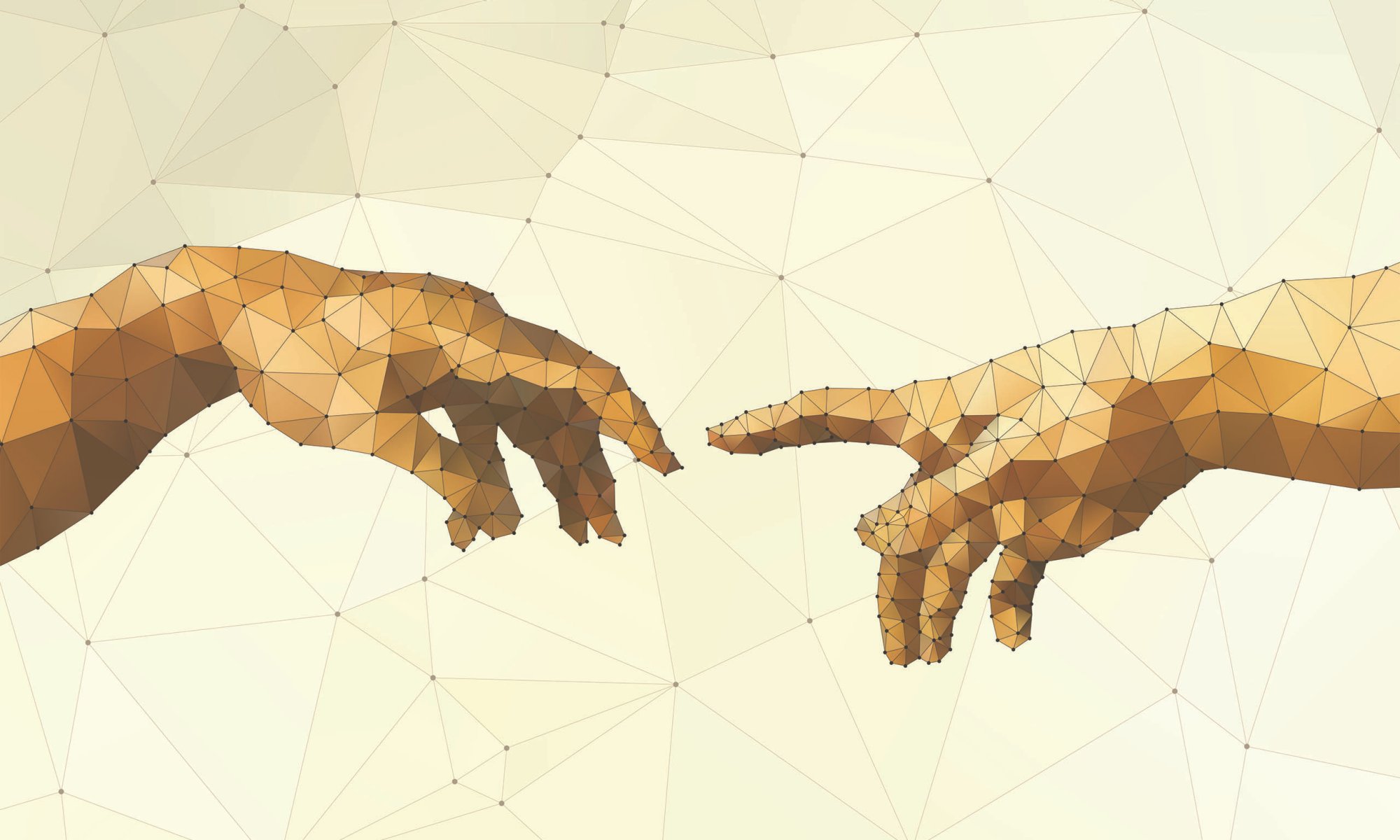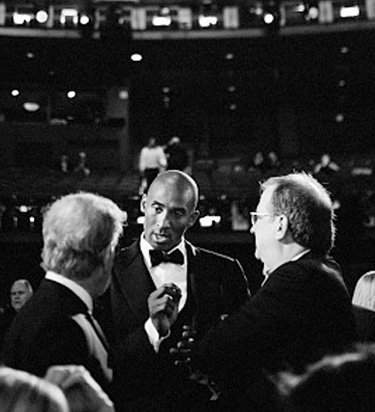Da quando si è ritirato Bill Gates sembra un altro. Il fondatore di Microsoft oggi è convinto che debba essere la società a governare la tecnologia e non viceversa. Da giovane imprenditore rampante, impegnato nel promuovere i guadagni di produttività di Windows, non avrebbe mai proposto - come ha fatto recentemente - di tassare i robot “che portano via il posto a schiere di lavoratori”. L’idea di usare la leva scale in senso punitivo o dissuasivo - non priva di una sua logica - è però qualcosa che appartiene all’armamentario novecentesco della politica, non al linguaggio dei guru della Silicon Valley. Gli over the top, come Facebook o Google, sono maestri riconosciuti nell’arte del fiscal planning. Refrattari per loro natura a pagare le tasse ovunque nel mondo. Ma così simpatici e, soprattutto, così influenti sui governi di qualunque latitudine, da non suscitare alcun movimento di opinione pubblica contrario. Le difficoltà nell’imporre una web tax si spiegano soprattutto in questo modo. Qualsiasi forma di imposizione sulla Rete, che nessun singolo stato può decidere autonomamente (la Tobin tax insegna), sarebbe giudicata dal pubblico come una moderna tassa sul macinato.
La politica oggi, in democrazie liberali in crisi di identità, nel tramonto dei partiti e delle ideologie, è ancella affannosa dei grandi imprenditori digitali. Insegue la loro benevolenza, ne subisce il fascino profetico.
Non sappiamo come la penserà quando andrà in pensione (per modo di dire), se mai vi andrà, Jeff Bezos. L’ideatore di Amazon nel frattempo è diventato, anche se momentaneamente, l’uomo più ricco del mondo, superando proprio Bill Gates, con un patrimonio stimato in oltre 90 miliardi di dollari. Non riusciamo a immaginare se si porrà, per esempio, il problema dell’eccesso delle quote di mercato. Il suo successo Bezos lo deve alla neutralità della Rete, agli investimenti pubblici che l’hanno resa possibile, alle regole antitrust che hanno impedito alle società di telecomunicazione di occuparla. Amazon ha il 74% del segmento degli e-book. Google ha una quota dell’88% del search advertising. Non sappiamo se un anziano Bezos proporrà una misura che riequilibri lo straordinario potere di mercato che le società della Rete avranno nell’Internet of things rispetto ai produttori dei beni di cui gli oggetti intelligenti delle nostre case avvertiranno la necessità. Un gigantesco monopolio in grado di fare qualsiasi prezzo. Ma sono solo alcuni dei tanti esempi sui quali, in una nuova stagione di regole antitrust, si dovrebbe riflettere. “In una società democratica l’esistenza di grandi centri di potere privati è una minaccia per la vitalità di un popolo libero”. La frase è di Melvin Urofsky, biografo di Louis Brandeis che all’inizio del Ventesimo secolo, prima di essere nominato alla Corte Suprema da Woodrow Wilson, cominciò la battaglia contro l’invadenza dei grandi monopolisti. Senza lo scorporo di alcune attività dell’At&t nelle telecomunicazioni, le regole antitrust e le disposizioni sulla durata dei brevetti - come ha scritto Jonathan Taplin su Repubblica - non avremmo avuto né Texas Instrument né Motorola. Se non vi fossero state opportune regolamentazioni dei monopoli naturali, la tendenza a privilegiare i profitti agli investimenti avrebbe frenato crescita e innovazione. Il fatto che Apple oggi abbia oltre 250 miliardi di riserve pari al prodotto interno lordo di un Paese come la Finlandia, testimonia del suo enorme successo, ma anche di una evidente distorsione monopolistica. Purtroppo - ed è questa un’amara considerazione - la politica oggi, in democrazie liberali in crisi di identità, nel tramonto dei partiti e delle ideologie, è ancella affannosa dei grandi imprenditori digitali. Insegue la loro benevolenza, ne subisce il fascino profetico.

Non sappiamo poi se Bezos ipotizzerà qualche forma di sostegno alle librerie di cui la sua società ha fatto strage. A quelle poche che saranno rimaste. Ma colpisce che Amazon abbia sentito la necessità di aprirne una, sul modello di quelle che ha efficacemente combattuto, perché forse il contatto fisico con i libri, seppur acquistabili con il proprio smartphone, è una esperienza alla quale anche il più digitale dei propri clienti non saprebbe rinunciare.
Del resto, il lettore ordina sul web un libro che vuole possedere, sfogliare, persino accarezzare. Certo, lo può leggere anche come e-book, ma è un’altra cosa.
L’algoritmo più so sticato non riuscirà mai a raggiungere la bellezza espressiva di una poesia di Montale, il guizzo sapido di un articolo di Montanelli o la carica emotiva della prosa della Fallaci.
Amazon ha recentemente rilevato la catena Whole Foods e si appresta a fare concorrenza al gigante Walmart - che ha un milione e mezzo di dipendenti solo negli Stati Uniti - sferrando così il suo attacco ai giganti della grande distribuzione. Ma con Amazon Go propone ai clienti di entrare in un negozio, scegliere i prodotti, guardandoli, toccandoli, per poi comprarli senza il bisogno di passare da una cassa. E già qui si può immaginare quanti posti di lavoro verranno sacrificati alle nuove abitudini d’acquisto.
Questa lunga introduzione ci porta al tema centrale di questo articolo, che riguarda il rapporto tra la carta e il web nel mondo dell’informazione. Mi è servita per sostenere una tesi, certo minoritaria, ma non troppo eccentrica. Il futuro è nel virtuale, nell’intelligenza artificiale, nella completa digitalizzazione delle transazioni, nella robotica. Inutile pensare di opporsi. Di tassare per deviare investimenti e consumi, di porre inutili barriere protezioniste. L’innovazione va promossa con la curiosità che muoveva l’esploratore, mai sazio di scoperte e sempre conscio del sottile confine che esiste tra l’avventura del sapere e la sfida temeraria. L’homo sapiens saprà, lo speriamo, trovare il giusto equilibrio. Lo saprà trovare nella misura in cui la cultura e l’informazione preserveranno e svilupperanno il suo pensiero critico. Il virtuale non avrà il sopravvento totale sul reale. Non verrà meno il desiderio del contatto fisico, del possesso individuale, dell’esperienza sensoriale diretta. Un robot sarà un perfetto assistente, ma non potrà mai trasmettere la dolcezza e la profondità di una carezza o di uno sguardo.

Indro Montanelli mentre valuta la prova di stampa della prima pagina de Il Giornale
L’algoritmo più sofisticato non riuscirà mai a raggiungere la bellezza espressiva di una poesia di Montale, il guizzo sapido di un articolo di Montanelli o la carica emotiva della prosa della Fallaci.
Mark Thompson, Ceo del New York Times è autore de La fine del dibattito pubblico (Feltrinelli), un libro assai importante sulla perdita di valore sociale della verità, sul trionfo delle fake news, reso possibile anche da monopolisti, come Facebook, privi di responsabilità editoriale per i contenuti che diffondono. Thompson invita a distinguere tra “intelligenza artificiale e artificio dell’intelligenza”. Il motto attuale del New York Times è “la verità è difficile da trovare ma è più facile che la trovino mille giornalisti tra i più bravi al mondo”. Ed è quello che sta facendo anche l’editore Jeff Bezos da quando ha rilevato dalla famiglia Graham il controllo del Washington Post per 250 milioni di dollari.
Con la vecchia e gloriosa proprietà - quella resa celebre anche dallo scandalo Watergate - il Post perdeva a bocca di barile, gli incassi pubblicitari si erano dimezzati. Bezos non si è limitato a investire nelle tecnologie digitali più sofisticate, come peraltro era normale attendersi. La velocità di scarico delle notizie su smartphone è stata una delle componenti della ripresa di mercato del giornale. Ma c’è stato di più, molto di più. Bezos si è comportato da vero editore. Ha investito sulla qualità. Ha assunto non solo web master ma anche e soprattutto i migliori cronisti, le firme emergenti. Ha puntato sul giornalismo d’inchiesta che oggi, nell’era Trump, conosce una nuova e fiorente stagione. Nel 2016 gli abbonati all’edizione digitale sono cresciuti del 75%. “La carta scomparirà?” è stato chiesto al ridanciano Bezos nel corso del convegno "The future of newspaper", organizzato a Torino per il 150 anni de La Stampa. Il tycoon americano ha detto di no. “Sarà come un oggetto di lusso, sarà come comprare un cavallo che nessuno più usa come mezzo di trasporto”. Ma il giornalismo non è né uno splendido purosangue, refrattario al morso, né il ronzino piegato dalla fatica. Casomai è il fantino. Non va mai confuso con il mezzo. Anzi, il paradosso è che oggi, di fronte a una Rete che teoricamente provvede a informare tutto su tutti, in presenza di algoritmi che sostituiscono i cronisti, a utenti che si improvvisano reporter, la sua funzione è ancora più indispensabile. Decisiva per difendere lo stato di salute delle democrazie. Il New York Times è tornato in utile nel secondo trimestre del 2017. Ha quasi due milioni di abbonati on line. Deve ringraziare Trump, certo. Ma quale sarebbe il futuro della più grande democrazia del mondo se non ci fosse un giornalismo scomodo e indipendente a risvegliare gli anticorpi repubblicani e a rinvigorire un’ opinione pubblica stordita dalle troppe post verità? E’ passata pressoché inosservata, la scorsa estate, una piccola notizia. All’apparenza irrilevante. La vedova di Steve Jobs ha comprato The Atlantic, storica rivista di cultura e politica, celebre per le sue inchieste e per aver pubblicato racconti di James, Twain, Martin Luther King. E forse l’avrebbe fatto anche il suo compianto e celebrato marito.
“La carta scomparirà?” è stato chiesto al ridanciano Bezos nel corso del convegno The future of newspaper, organizzato a Torino per il 150 anni de La Stampa. Il tycoon americano ha detto di no. “Sarà come un oggetto di lusso, sarà come comprare un cavallo che nessuno più usa come mezzo di trasporto”.