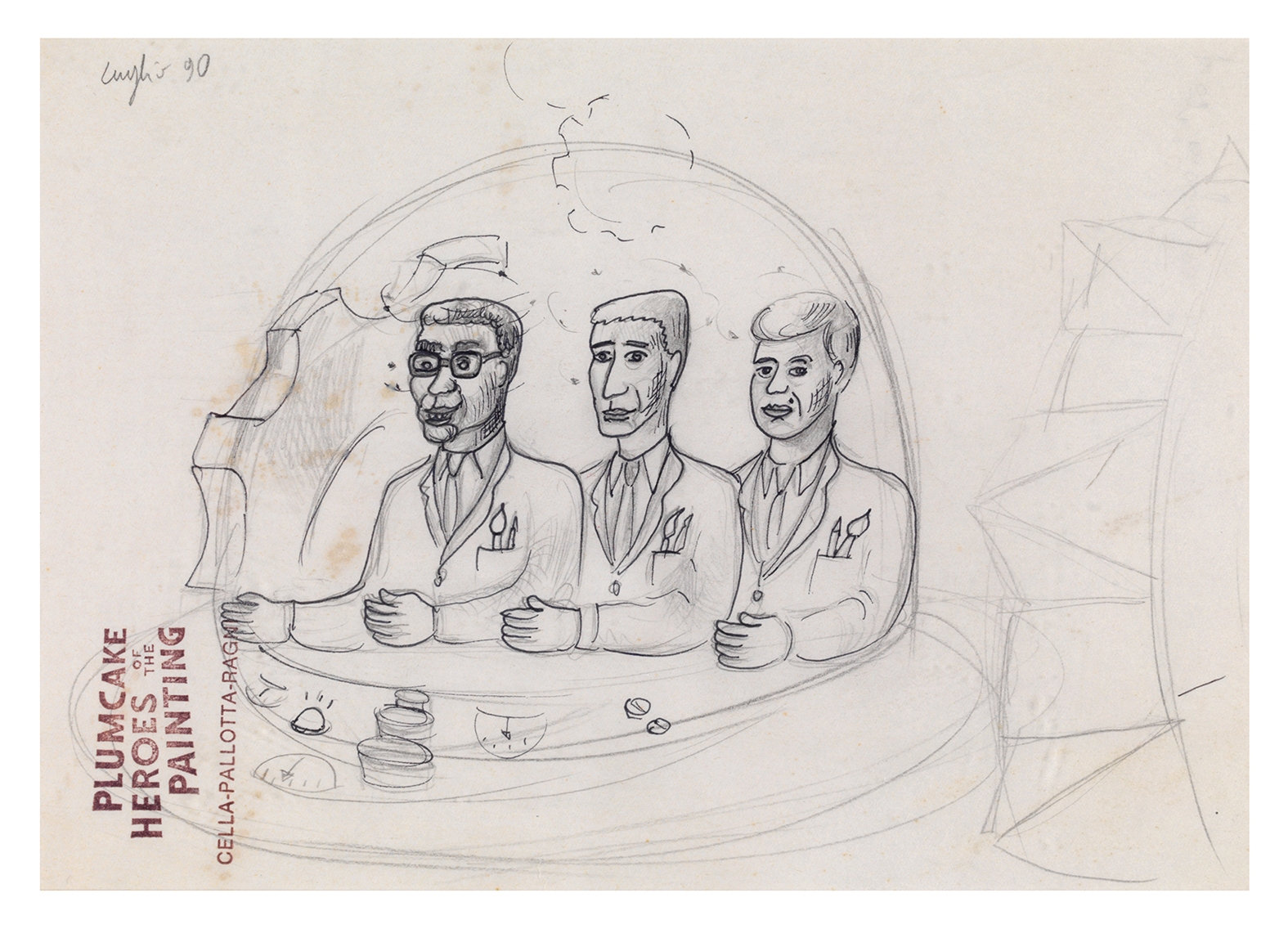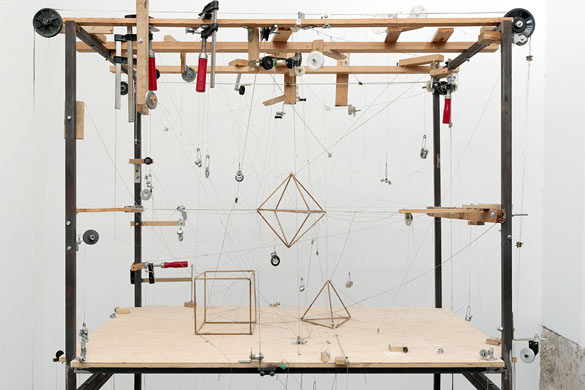Quando ho visto le opere di Simone Fattal per la prima volta, anni fa, mi resi conto di essermi macchiato di un grave delitto culturale di omissione selettiva. Simone Fattal parlava al cuore, all’occhio e alla pancia dell’uomo, e lo faceva con alcuni elementi così semplici da apparire come veri e propri pezzi di terra o sabbia scagliati, come bambini sul bagnasciuga, sul terreno delle nostre vite. Anni dopo arrivai al MoMA PS1 e trovai di nuovo il suo lavoro, in una mostra esplorativa (aggettivo quanto mai indicato) e piuttosto ampia. Sui muri bianchi del PS1 campeggiava la sua biografia, che è modestamente impressionante come i suoi piccoli totem di terracotta. Simone Fattal è nata a Damasco, in Siria, e cresciuta in Libano, dove ha studiato filosofia all'École des Lettres di Beirut. Si è trasferita poi a Parigi, dove ha proseguito i suoi studi filosofici alla Sorbona. Nel 1969 è tornata a Beirut, ed ha iniziato a lavorare come artista visiva, esponendo i suoi manufatti a livello locale fino all'inizio della guerra civile libanese. È fuggita dal Libano nel 1980 e si è stabilita in California, dove ha fondato la «Post-Apollo Press», una casa editrice dedicata a letteratura più innovativa, radicale e sperimentale. Nel 1988 si iscrive ad un corso presso l'Art Institute di San Francisco, che le induce un pervicace ritorno alla pratica artistica e le fa ritrovare l’antica vocazione per la scultura e la ceramica. Simone Fattal attualmente vive a Parigi. Il lavoro di Simone Fattal è costituito essenzialmente da sculture, spesso in ceramica, gres o terracotta, che parlano di una storia antica, di spostamenti, diaspore. Sono modeste figure umane che sembrano arrivarci dal suo tocco, per dirci qualcosa che non possiamo afferrare nell’immediato. Un po’ come quegli incontri rivelatori e talvolta bizzarri che solo nel corso del tempo riusciamo a tradurre in qualcosa di utile per la nostra vita. In queste immagini esiste sicuramente un accenno alla fragilità umana, ma anche un aspetto archeologico, anche speleologico, profondamente terreno e tellurico; eppure, tutto questo ha anche un’eco che rimane nelle profondità dell’osservatore e che nelle ore seguenti torna a risuonare. Il tempo, in definitiva, è il grande orizzonte mobile su cui si muove l’opera di Simone Fattal: un tempo antico su cui esiste l’opera, il nostro tempo interno che disperatamente cerchiamo di accorare al primo. Le figure sembrano vecchie come la Terra su cui camminiamo eppure sono davanti a noi, come un reperto, ma anche come uno spirito guida. E proprio sul sito dell’artista, come epigrafe v’è scritto un verso di Etel Adnan tratto da «The Beirut-Hell Express», «Vi annuncio la vostra resurrezione e la vostra morte». È questo l’eterno ritorno e l’eterno doppio temporale cui sembra riferimento tutta l’opera dell’artista in cui la terra, sotto i nostri piedi, assume valore di medium e anche di universo di riferimento. Tutto questo echeggia anche nelle struggenti parole di Negar Azimi, «Anche i morti ci parlano: una volta ero un guerriero. Una volta ero padre. Una volta ero padrone di questa terra. Una volta ero io una volta ero echi ancora e ancora. La loro magniloquenza è squallida. Ma poi, non sono mai veramente morti, vero? La storia di Fattal è un miscuglio temporale, un continuum spericolato in cui tempo e luogo sono livellati e gli antichi si mescolano ai moderni. Anche nei suoi lavori di collage il miscuglio è evidente. Giorno dopo giorno, ritaglia piccoli pezzi di riviste, giornali o pubblicità che catturano la sua attenzione e li scaccia via. Tornano, sì, come dai morti, quando ha senso che lo facciano. […] La sua è una visione di un mondo in cui non c'è "puro" e non c'è nemmeno originale. Nella vita reale, dopo tutto, prendiamo in prestito da qua e da là. Le tracce delle guerre, degli amori e delle bugie di altre persone sono incise sui nostri corpi e nelle nostre menti. Come i prodotti di tutto ciò che è venuto prima di noi». Simone Fattal, o terra, uomini e spiriti, passato e presente dell’essere.
Image Courtesy, Simone Fattal, Galleria Kaufmann Repetto ©, Milano