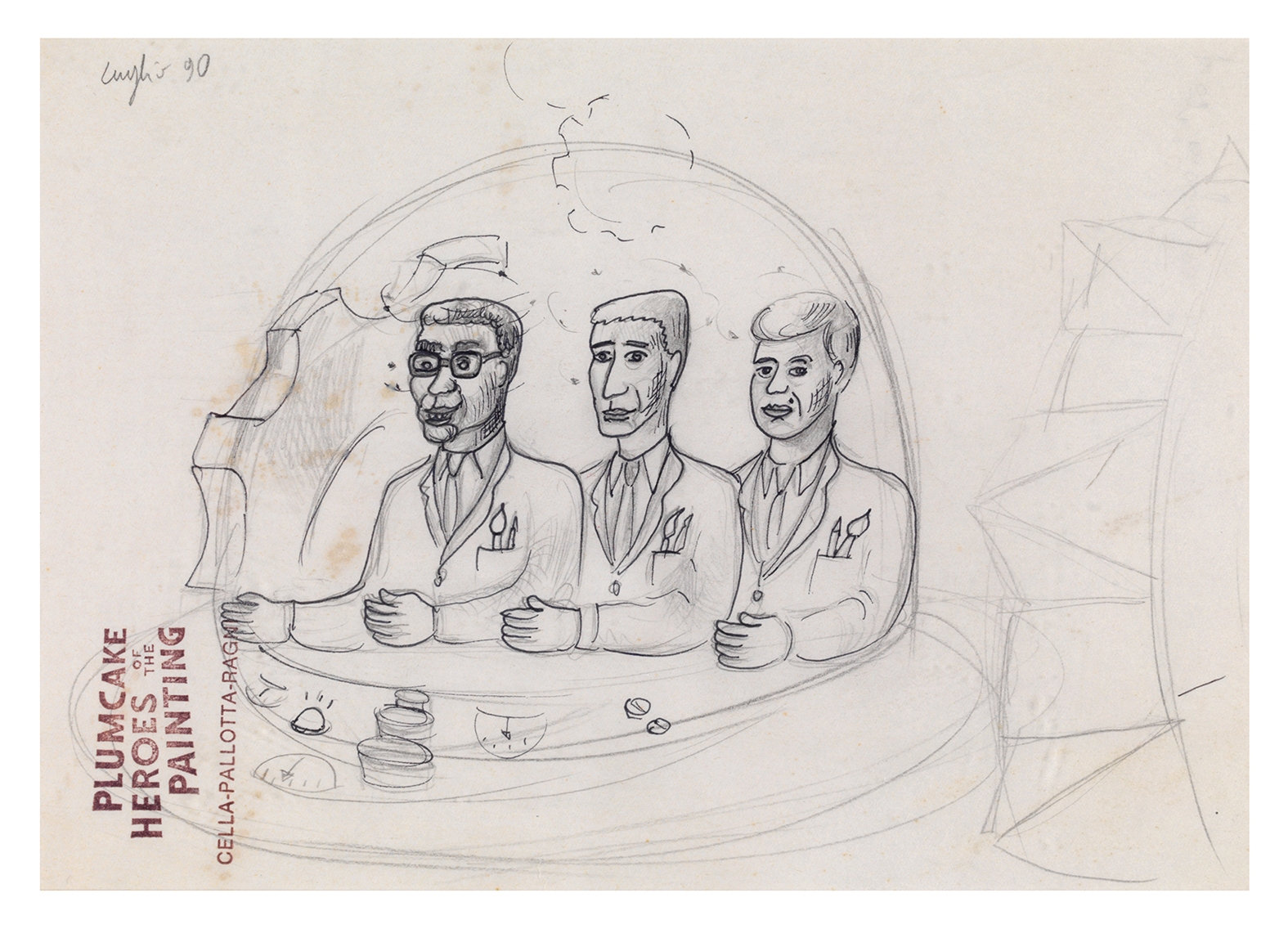Piero Manzoni stava sempre lì al Bar Jamaica, e beveva. Molti dei “poveristi” non immaginavano di poter diventare i giganti (del mercato) di oggi, e, anzi, una volta chi immaginava che ci sarebbe stato qualcuno disposto a pagarle, quelle opere. Kurt Cobain voleva solo «suonare e registrare qualche buona traccia[1]». L’arte è sempre stata un grande laboratorio in movimento a cielo aperto, dove molto spesso l’idea stessa di profitto era vista come antitetica se non inautentica, un senso di responsabilità, talvolta, sulle spalle di chi voleva solo sentirsi libero di fare quello che voleva. Oggi non è più così. La consapevolezza di essere artisti e al tempo stesso prodotti della finanza contemporanea, oggetti del desiderio da lista d’attesa (provate a telefonare ad Hauser&Wirth per un Mark Bradford), liberi ma non troppo, agende fitte come manager e aspettative da CEO di Spotify. Da quando l’arte è diventata questa lussuosa e glitterata forma di diversificazione patrimoniale e finanziaria, emancipata da quella sua eterna vena anticonformista (che cosa doveva significare a livello sociale avere un disegno di un organo genitale femminile di Carol Rama o un fallo in bronzo di Louise Bourgeois appeso in casa negli anni Sessanta?), tutti quanti desideriamo entrare a farne parte. E se da un lato sale la domanda, fondi d’investimento concepiscono prodotti, sugli asset artistici si inizia a fare credito e presto si andrà a leva, dall’altro sale l’offerta, così come il prezzo. Perché per ogni Bradford da due milioni di dollari deve esserci un Griffa da centomila euro e un Aricò da cinquantamila. È la legge del mercato. Per ogni Pagani Zonda quante Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio e quanti Porsche Macan S ci saranno?
Su tutto questo si innesta poi quello che la notevole ricerca di Federica Codignola[2] ha definito come “il Pinault Effect”, il quale evidenzia come gli artisti migliorino con estrema evidenza la loro posizione di classifica (Artfacts Ranking Position), nonché il numero totale delle mostre che li hanno esposti, nel periodo oggetto di studio (dal 1996 al 2014), in base alla loro presenza nella collezione e nelle mostre by Francois Pinault. Per quanto riguarda la posizione in classifica, il 71,2% degli artisti è influenzato positivamente dall'effetto Pinault, avendo sensibilmente migliorato la propria posizione dopo la prima partecipazione a uno suo show. Lo stesso si può dire per quanto riguarda il numero di mostre. Il 94,4% degli artisti vede aumentare notevolmente il numero delle esposizioni dopo la loro prima presenza in uno show all’interno di uno degli spazi ascrivibili al tycoon. E questo vale ovviamente per Arnault, Miuccia Prada, e molti altri. Tutto intuibile.
Allo scenario, tuttavia, va aggiunto un tassello: tra il 1998 e il 1999 in piena espansione del gruppo LVMH, Pinault acquista prima una quota di maggioranza in Christie’s e poi il controllo della casa d’aste Phillips de Pury & Company (partecipazione poi dismessa nel 2003). È quindi molto chiaro l’interesse non solo di colonizzare il mondo dell’arte e della cultura per creare un ponte creativo tra questi due universi spesso contigui, ma quello di controllare un mercato e di generare valore a cavallo dei due mediante l’utilizzo incrociato di contenuti creativi e marchi: negozi che si riempiono d’arte, artisti che aumentano il loro valore dopo essere stati esposti e collezionati, artisti che firmano collezioni, sono solo alcuni dei trasferimenti di valore di cui si beneficia quando si ha la possibilità di muovere lo scacchiere potendo fare leva sia da una parte che dall’altra del modello.
E quando nel 2014 Pinault trasferisce Patricia Barbizet (poi avvicendata da Guillaume Cerutti nel 2017), sua vicepresidente nel CdA di Kering, a CEO di Christie’s, l’unione diviene totale: dalla moda all’arte è insomma possibile creare valore culturale (quello che si propongono musei come Punta della Dogana a Venezia, per esempio) e valore finanziario (quello sviluppato dalla casa d’aste), contemporaneamente. Anche questo era scontato, ed avviene giornalmente con artisti che forse la Storia non premierà ma che, come ogni buona azione di borsa, avranno potuto arricchire molte persone nel frattempo. Quello che talvolta di tutto questo impressiona non è tanto il meccanismo, bensì la sproporzione: la moda è un’industria miliardaria che entra nelle case di tutti, l’arte no. Quando qualcuno mette a fuoco tutto questo si può infatti avere l’impressione che l’arte sia (solo) la spilla sublime sul bavero del cappotto di chi ne detiene il controllo, con buona pace di chi ancora immagina scene da Bar Jamaica. Non è passatismo o rimpianto di un mondo che non c’è più (ammesso sia mai esistito anche quello), ma deve essere la pragmatica lettura di chi entra a Punta della Dogana (museo che espone le opere della collezione di Francois Pinault, ndr) a Venezia e vede Peter Dreher al muro, e si chiede come mai abbia subito un incremento dei prezzi di circa l’800% in due anni, dopo circa quarant’anni di semi-anonimato commerciale, o di chi si comprerà la prossima costosissima borsa firmata Yayoi Kusama o Takashi Murakami senza mai essere entrato prima in un museo.
[1]«We just want to play, and put out what we consider good records».
[2] “Arts, Cultural and Creative Industries Symposium ‘Marketing of arts, cultural and creative industries in the digital era”, Torino, 23-24 settembre 2016. Federica Codignola, Università degli Studi di Milano – Bicocca