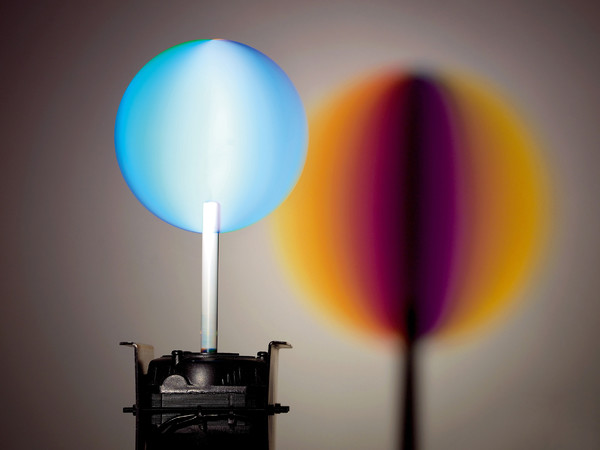Marco Atripaldi's view
Eterno secondo, con siderale distacco dal calcio, il basket italiano vive un momento di riflessione con più di qualche preoccupazione per il futuro.
Al vertice, ormai lontana l'epoca dei grandi investitori (Ferruzzi, Benetton, Scavolini, Seragnoli, Cazzola) il solo Armani sta garantendo una continuità per provare ad essere competitivi a livello europeo, la base cerca nuove strade per reclutare e valorizzare i giovani sentendo sul collo il fiato di discipline come il volley o il rugby, in mezzo c'è il corpaccione di un movimento che fatica a darsi regole chiare e condivise, articolato tra professionismo, semiprofessionismo, falso dilettantismo e attività amatoriale. I deludenti risultati della Nazionale, nonostante la presenza di giocatori che militano in Nba e del miglior coach tricolore in attività, certo non hanno aiutato lo sviluppo di uno sport “geneticamente nano”, come lo definiva l'avvocato Palumbi, storico vicepresidente della Fortitudo Bologna, perché sovrastato dal calcio e perché attecchisce soprattutto in provincia.
L'annosa diatriba tra Federazione che vorrebbe più giocatori italiani in campo nell'interesse della Nazionale, e Lega di serie A (la Confindustria dei canestri) che invece punta a utilizzare più stranieri, “c'è una maggiore scelta e costano meno”, per avere maggiore competitività sia in Italia che all'estero, ha creato uno stato di impasse da cui oggi non si vede una via di uscita che rappresenti sul serio una svolta. A tutto questo va aggiunta la crisi economica che ha investito il Paese nell'ultimo decennio e privato il basket di risorse importanti, con la conseguenza di un generale abbassamento del livello tecnico dei campionati mentre il taglio, operato dai più, sugli investimenti nei settori giovanili ha ridotto quantità e qualità del reclutamento impoverendo la formazione di nuovi giocatori italiani di buon livello. Insomma, il gatto che si morde la coda.
In questo quadro pensare a come gestire un progetto sportivo che dia risultati e al contempo sia economicamente sostenibile senza far svenare i proprietari, a tutti i livelli, è tutt'altro che semplice. I principi fondamentali, a mio modesto parere, sono tre: identità, programmazione e pazienza. Concetti divenuti abbastanza desueti in un movimento che spesso, con le dovute e meritevoli eccezioni, vive all'insegna del tutto e subito oppure alla giornata sfruttando in minima parte la spettacolarità, anche molto televisiva, di uno sport appassionante dove ogni minuto succede qualcosa.
Innanzitutto, l'identità di obbiettivi: cosa vuoi fare, vincere l'Eurolega? Il campionato? Vivere dignitosamente in serie A o Legadue o serie B e toglierti ogni tanto una soddisfazione? Essere la bandiera del tuo territorio e curare e lanciare i giovani? Non tutti possono fare tutto, morto il mecenatismo e in epoca di scarse risorse bisogna in primis aver chiaro dove si vuole andare e spiegarlo in maniera trasparente a tutte le componenti esterne, sponsor, pubblico, media che poi svolgono in vario modo una funzione di pressione sull'attività della società.
Da questo ne discende l'identità tecnica, con la scelta del coach, dei giocatori, dello staff che siano funzionali all'obbiettivo. E anche qui massima chiarezza. Inutile prendere un grande allenatore abituato all'alto livello se poi gli metti a disposizione tanti giocatori magari talentuosi ma inesperti o per contro firmare un coach di belle speranze per farlo “mangiare” da un gruppo in cui comanda qualche senatore che ha smesso di correre ma non di parlare. Lo staff, inteso come coach e assistenti, preparatore atletico, medico, fisioterapista, osteopata e personale organizzativo (team manager, marketing, segreteria, ufficio stampa, social media), è centrale nel buon andamento di un club. Purtroppo, negli ultimi è il settore su cui sono stati effettuati pesanti tagli economici. Scelta che non condivido. A parte il general manager che ormai è una razza in via d'estinzione, non si può pensare di avere un futuro senza buoni allenatori, siano essi la guida della squadra del massimo livello o gli istruttori di minibasket o i coach delle squadre giovanili: risparmiare troppo li vuol dire tagliarsi le gambe.
E lo stesso vale per le altre componenti prima citate. Una struttura efficiente aiuta in maniera decisiva a prevenire i problemi o a risolverli in tempi brevi (quando spesso tempo davvero non ce n'è) e ad ottimizzare il rendimento dei giocatori. Poi, per carità, si possono raggiungere gli obbiettivi anche con atleti che aspettano per settimane casa e macchina, curati superficialmente, cui viene fornito materiale scadente e pagati in ritardo, ma vuol dire affidarsi allo stellone e non al lavoro, può mandare bene una volta, magari due ...
Una struttura tecnico/organizzativa efficiente significa affidabilità (altro indice in sensibile calo negli ultimi anni) che può consentire di assicurarsi le prestazioni di giocatori di talento e competitivi anche avendo a disposizione risorse limitate o comunque inferiori rispetto ai competitors, e costituisce un elemento di peso nelle trattative con gli atleti e soprattutto con chi li aiuta a decidere: la famiglia, se sono giovani oppure, se sono già affermati, i procuratori che di fatto con l'avvento della legge Bosman e dello svincolo sono diventati protagonisti assoluti, e spesso comproprietari occulti, del giochino. Programmazione e pazienza vanno a braccetto. Per raggiungere obbiettivi concreti e duraturi ci vuole tempo. Un progetto serio guarda almeno a tre anni, se non cinque. Possibilmente senza terremoti in corso d'opera. Le scelte prima si fanno e poi si difendono. Ogni inizio stagione, che sia la partenza di un nuovo progetto sportivo oppure una tappa, prevede lunghe discussioni e confronti tra i vari attori all'interno di club. Quello è il momento di mettere le varte in tavola: la proprietà che ha un budget da rispettare e un obbiettivo da raggiungere, l'allenatore che chiede giocatori o caratteristiche di giocatori e pensa legittimamente anche al proprio futuro, il manager che deve trovare la sintesi delle varie esigenze per trasformarle in una storia che possa funzionare. Poi basta, in campo devono entrare solo giocatori e pazienza, in particolare in quelle situazioni dove si punta per necessità o virtù ad una crescita graduale.
Ovviamente tutto questo bel discorso, parlando di sport, deve fare i conti con un convitato di pietra, i risultati. Di solito se si lavora bene arrivano, magari però non subito. E qui spesso casca l'asino, mettendo in discussione quanto era stato deciso anche solo qualche settimana o mese prima.
Non sempre si hanno il coraggio e la forza di resistere alle pressioni esterne, all'ansia che assale guardando la classifica e le prossime partite, alle sirene tentatrici di un mercato sempre aperto (che dovrebbe servire ad aggiustare o rinforzare, non a rivoluzionare e che raramente a stagione in corso offre opzioni miracolistiche) o semplicemente al gusto di cambiare tanto per fare qualcosa o darne l'impressione. E quindi si apre una fase pericolosissima dove rischia di scendere sotto il livello di guardia la fiducia reciproca che sta alla base della buona riuscita di qualunque sport non individuale, dove l'indice puntato verso i presunti errori altrui, siano essi dirigenti, allenatori, giocatori, diventa il manifesto programmatico di un probabile fallimento. Intanto all'esterno sono gia pronti i patiboli per i capri espiatori di turno, a cominciare dall'allenatore. Bisogna tenere duro, almeno fino a quando è possibile, soprattutto se si è convinti delle proprie scelte e consentire a tutti di lavorare con la massima serenità: ci sono più probabilità che i risultati arrivino e con essi gli obbiettivi, rispetto ad entrare nel tunnel di continue ed estenuanti riunioni, faccia a faccia, chiarimenti, liste di allenatori o giocatori e magari qualche bella intervista dove qualcuno prende le distanze.
Credo che un club che voglia garantirsi un futuro oggi non possa prescindere dal dedicare risorse sensibili, non inferiori al 20 per cento (ma sarebbe meglio il 30) del budget a disposizione ad investimenti sul settore giovanile. Risorse su istruttori e allenatori anzitutto, che devono essere pagati e non destinatari di mance e vaghe promesse, organizzazione (in particolare sotto il profilo medico, della preparazione atletica e della riabilitazione) per puntare ad avere negli anni un sempre maggior numero di atleti “fatti in casa” che, divenuti senior, costeranno meno e comunque garantiranno una rendita costante grazie alla premialita in denaro della Federazione. Senza dimenticare l'importanza del legame piu stretto che si crea con il proprio territorio e il sogno che si alimenta tra tifosi e appassionati nel vedere il ragazzo della porta accanto o l'amico del figlio essere protagonista accanto agli americani di turno. Il che implica poter lavorare su una massa critica in crescita con la possibilitò di aumentare gli spettatori paganti e di coinvolgere nel progetto nuovi soci, inserzionisti pubblicitari, sponsor. Quello sul giovanile non è un investimento a fondo perduto, come spesso ho sentito dire in questi anni, o peggio soldi butatti, è una polizza sul futuro. Anche la qualità della struttura deve avere molta attenzione, come ho scritto sopra, senza necessariamente dover spendere quote particolarmente sensibili del budget: la strada è quella, esattamente come per giocatori e allenatori, di far crescere figure professionali al proprio interno, formandole e facendo leva non solo sulle capacità ma anche sulla passione e lo spirito di sacrificio che sono indispensabili per chi vuole lavorare nel mondo del basket (e non solo ovviamente).
Inevitabilmente la maggior parte delle risorse va poi sulla squadra che all'interno del club gioca il campionato di piu alto livello e la cui costruzione è figlia di tutti gli elementi illustrati finora. In questo quadro francamente mi appassiona poco il perenne dibattito sulla cosiddetta eleggibilità dei giocatori, ossia il numero di stranieri tesserabili e italiani da schierare nei roster dei primi due campionati, in particolare la serie A che è il traino di tutto il movimento.
Negli anni ho visto diminuire sensibilmente la qualità degli stranieri, soprattutto di scuola americana, giunti a giocare in Italia e aumentare l'età (ma non i minuti di utilizzo) degi italiani. Ho partecipato a decine di riunioni, tavoli, commissioni dove ho sentito dire sempre le stesse cose: gli stranieri sono troppi e portano via spazio alla crescita degli italiani; si ma gli italiani sono pochi e costano troppo. Sistema malato e avvitato su sé stesso, evidentemente, ma per cambiarlo davvero non si comincia mai. La Federazione ha in mano il potente strumento della premialità economica, a tutti i livelli, per chi forma e utilizza giocatori italiani: coi tempi che corrono mi pare sia più efficace di paletti e divieti. I club, soprattutto quelli con meno risorse, dovrebbero abbandonare luoghi comuni ormai stantii.
Personalmente penso che in un buon rupppo sia meglio avere al massimo 3 o 4 giocatori di scuola americana della più alta qualità possibile di cui un paio con una consolidata esperienza europea alle spalle, e poi un mix di italiani giovani ed esperti, almeno per le squadre che non giocano in Coppa. Ma è solo una mia convinzione.
Dimenticavo la variabile impazzita, è proprio il caso di dirlo: quando arriva la partita, le teorie restano a casa e si diventa tutti matti...
Marco Martelli's view
Identità, programmazione e pazienza, infusi nella costruzione e nella gestione del Club, sono elementi di profonda funzionalità non solo nel raggiungimento di risultati, ma soprattutto nel trasmettere linfa vitale ai due principali attori-sostenitori di questa affascinante industria sportiva: gli sponsor e il pubblico. Il terzo potenziale fattore, quello dei diritti televisivi, trave portante dell’industria calcistica e dello sport professionistico americano, nel basket nostrano è da considerarsi marginale (pur con l’ingresso, in Serie A, del gruppo Discovery ad affiancare Rai). Per questo motivo, l’attuale manager sportivo deve essere in grado non solo di bilanciare emotivamente la struttura sportivo-societaria, ma anche di renderla viva e “responsive” alle logiche richieste sul mercato dagli attori di cui sopra.
Se la miglior organizzazione sportiva, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi, è la mission quando si entra in palestra (o “al Palazzo”, come si dice in slang cestistico), in ufficio le domande che il manager deve oggi porsi sono altre e fanno capo, senza soluzione di continuità, a sponsor e fan-base. “Perché investire in una sponsorizzazione?” “Perché acquistare un biglietto?” Personalmente, ritengo che ogni attività del Club debba rispondere in modo esaustivo – e contemporaneo – ad una di queste domande.
Oggi, sul mercato, le centinaia di input disponibili, sia in termini di visibilità per i potenziali partner, che di svago per il pubblico appassionato, e a maggior ragione per quello ancora ai margini del nostro sport, danno al movimento basket un imperativo categorico: interpretarne un bisogno e soddisfarlo, guidando così la decisione di investire denaro nel Club.
Come già detto, la recessione economica ha portato la pessima abitudine di tagliare in aree di supporto all’attività sportiva della Prima Squadra: non solo staff tecnico, fisico-fisioterapico o settore giovanile, ma anche marketing, comunicazione e ticketing. E si rivela, nei numeri, un errore madornale. Queste tre aree, infatti, gestiscono direttamente il rapporto, fisico o virtuale, con il 100% degli introiti del Club: investire personale e azioni in queste tre aree diventa imprescindibile.
NETWORKING: RACCONTARE UNA STORIA
Riconoscere la “modalità contemporanea” di comunicazione e di azione è il primo passo per poter essere efficaci nel costruire, e poi vendere, il prodotto-basket. Terminato ormai ovunque il tempo dei mecenati, pur con qualche gradita e benefica eccezione, il sistema sponsor – che ancora regge, dati alla mano, il 65-70% degli introiti – necessita di una forte connessione con il Club, dove identità e programmazione sono elementi chiave. Nessuna azienda investirebbe in un Club di cui non riconosce l’identità e di cui non percepisce la programmazione: il timore di un riflesso d’immagine negativo pesa di più di qualsiasi cifra investita. Per questo motivo il Club dev’essere in grado, oggi, di raccontare una storia, di proporre ai propri supporter, siano aziende o pubblico pagante, una sorta di storytelling sportivo che soddisfi un bisogno primario dell’uomo: emozionarsi. Tale e quale al tifoso che sogna una grande giocata, anche l’azienda deve provare un’emozione: quella puramente interiore, nell’associazione a un brand che ricalca i propri pillar aziendali, o nell’unione a un Club che rappresenta un territorio, così come quella business-oriented, ovvero nell’appartenere a un Club che si comporta come vera e propria Squadra, che crea – per i propri partner – un vero e proprio network di business. L’intera struttura societaria deve percepire, costantemente, la responsabilità di supportare queste emozioni, certamente trainate da un fattore sportivo decisivo, fatto di risultati e ci si augura vittorie, ma da non limitare alle 30 partite di un anno: perché gli altri 300 giorni sono strategici nel creare fiducia, fidelizzazione e soddisfazione. La creazione di un network interno al Club, in cui le aziende parlano alle aziende, in cui creare contatti diventa la vera vittoria, dove i CEO delle Aziende escono rafforzati e perché no ancor più formati, costa fatica, costa tempo, costa denaro, ma getta le basi per un progetto forte e duraturo. Saper raccontare cosa si è e cosa si vuol fare, trasmettendo come un Club sportivo, di qualsiasi livello, può soddisfare un bisogno, significa fare un passo verso la vittoria. Che nello sport non si chiama necessariamente Coppa o Campionato: ma, innanzitutto, continuità e crescita.
FAN-RESPONSIVE
Jon Spoelstra, professore universitario americano, legato a filo doppio con la pallacanestro per carriera e famiglia (il figlio, Erik, è head-coach dei Miami Heat e ha vinto 2 titoli NBA), in uno dei suoi libri scrive una frase chiave nello sport-business: “La vittoria non è una strategia di marketing”. Aggiunge anche che “i biglietti non si vendono da soli”, e ciò basta per ribaltare l’abitudine tutta italiana di attendere i tifosi al varco quando le cose vanno bene. Il problema è che un Club, per quanto (tanto) possa investire e per quanto bene possa lavorare, non potrà mai controllare il risultato sportivo. Può controllare, invece, tutto ciò che riguarda l’esperienza del tifoso: ovvero la storia che si vuole raccontare, i canali di comunicazione, la fruibilità e la comodità dell’impianto, il rapporto qualità-prezzo nella partecipazione all’evento sportivo.
L’area che ha l’obiettivo di sintetizzare tutto questo a livello di introito è il ticketing, materia in Italia ancora molto sottovalutata. Pensateci: non è più né meno di ciò che fa un’azienda standard. Ovvero conoscere il proprio cliente, comprenderne le necessità, realizzare il prodotto migliore possibile per la soddisfazione della necessità, anche a seconda delle fasce di età o reddito, e fissare il pricing corretto. Nello sport non è diverso, e in Italia ci siamo pericolosamente fermati: impiantistica, modalità di vendita e comunicazione, creazione di contenuti, oggi sono alla base delle fortune delle principali Leghe europee, anche quelle – come Germania, Belgio e Francia – che fino ad inizio anni 2000 venivano da noi a studiare come si fa.