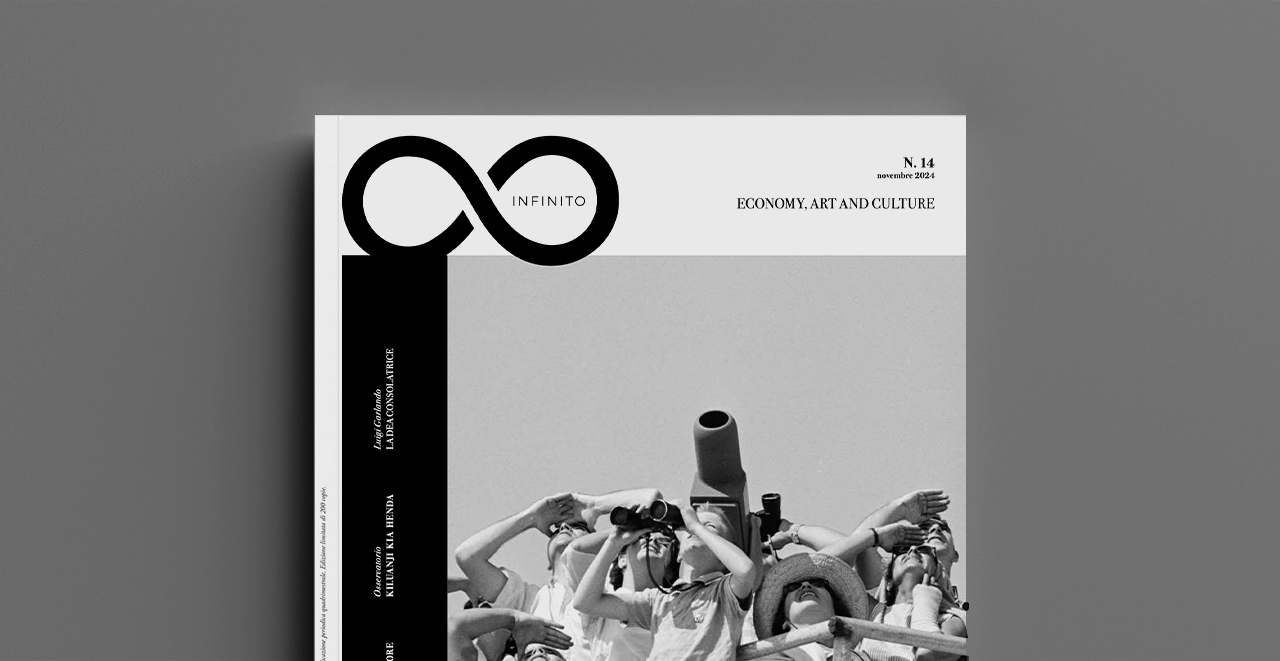Quando questa cosa è iniziata Philippe Daverio era ancora vivo e il mondo dell’arte un po’ diverso – anche se non molto. Dovevamo vedere la Covid, il profluvio delle inutili ma ormai necessarie latitudini digitali del mercato, le virtual room, e poi il crollo delle compravendite del biennio 2023-2024. L’arte nel 2019, quando è iniziata questa rubrica su Infinito, era già il feticcio di lusso che è oggi, iniziava a serpeggiare nei social, ed era preda della moda, tra fondazioni private muscolari proprietà o emanazione dei grandi gruppi e logiche mercantili sempre più simili alle Birkin di Hermes o ai Nautilus di Patek Philippe. In questo onesto e più che legittimo scenario ho diligentemente scritto le mie microbe recensioni con l’idea di offrire uno sguardo su artisti di un qualche interesse. Tutti loro sono parte del mercato e nessuno di loro ne è immune. Alcuni sono morti, altri ci sono piuttosto vicini, la maggioranza ha comunque ancora la pretesa di far parte di un dibattito. Come mi è stato scritto da chi cura questo spazio di riflessione su carta impressa, con questo numero quattordicesimo mi veniva offerta una rara possibilità: fermarmi e guardare indietro. Certo, l’e-mail proseguiva con un certo inquieto incoraggiamento, invitandomi a considerare sempre il futuro. La verità è che guardare al futuro nell’arte serve a poco. Lo fanno forse i giocatori di borsa prestati a questo mondo o i collezionisti assillati dai prezzi. È molto più utile guardarsi all’indietro: innanzitutto per capire quando le cose sono iniziate e come, da dove deriva un sentimento o un certo modo di fare le cose. L’arte è una promessa, una domanda che tutti noi colmiamo con il nostro percepito. A volte ci migliora, a volte ci cambia, a volte ci sollazza, a volte ci lascia angusti ed esposti, e moltissime altre semplicemente passa e va. Quello che ho deciso di fare in queste poche righe è allora proprio guardarmi indietro – e darmi questo privilegio è stato un bel regalo. Di chi ho scritto per voi? Ibrahim Mahama, Piero Fogliati, Arcangelo Sassolino, Christiane Löhr, Michel Blazy, Caretto e Spagna, Liliana Moro, Sabrina Mezzaqui, Peter Dreher, Attila Csörgö, Plumcake, Nathalie Du Pasquier, Geumhyung Jeong, Simone Fattal, Bertille Bak, Izumi Kato. È una compagine piuttosto variopinta. C’è chi guarda alla natura, al nostro rapporto con il vento o con le piante, ci sono macchine (in)utili, c’è la storia dell’uomo dalle sue origini, del fuoco, c’è il disegno e c’è la forma, c’è la ripetizione e c’è il tempo. C’è moltissimo. Funzionerebbe una mostra di questi artisti? Per i canoni attuali penso di no. Le mostre tramano progetti – e questa spesso è una condanna alla noia. E una collezione? Cosa dite? Non penso esista un collezionista che abbia comprato dalle macchine naturali di Fogliati, a quelle numeriche di Csörgö e che contemporaneamente abbia voluto in casa un giochetto in plastica dei Plumcake. Se esiste è un certamente un gran compratore. E allora tutto questo cosa è stato? Se non possiamo farne una mostra o un catalogo e non è la geografia di una collezione, cosa ci rimane? Per rispondere prendo malamente a prestito il titolo di un celebre articolo di Armando Testa per Il Giornale dell’Arte del 1983. «Dove me lo metto questo?». Testa se lo chiedeva a proposito delle abnormi dimensioni fisiche che l’arte contemporanea soleva raggiungere in relazione ai ben più normodotati muri degli appartamenti standard torinesi. Quei bei muri rassicuranti sopra il letto o sul pranzo. Ecco, i primi tredici infiniti sono stati questo: un esercizio di stile che non entrerà mai nel vostro salotto. D’altronde dove, se non qui? – con uno pseudonimo un po’ fatuo. Tutti questi sono mirabili artisti e così quelli che verranno dal quindicesimo numero di questa pubblicazione in avanti. Considerate di concedervi il lusso di guardarli senza l’ansia dei prezzi, l’assillo delle loro quotazioni in ascesa o in picchiata, perdervi tra le sale immaginarie di questo museo e leggere le loro storie guardando all’indietro per il solo gusto di viverle. Questa modesta rubrica ha il privilegio dell’ingenuità.

Dove me lo metto questo?
Il Cugino di Daverio
È forse la lista della spesa.

Il cugino di Daverio
Esiste una possibilità che sia io o che non lo sia. Scrivo, qui, di arte che verrà.