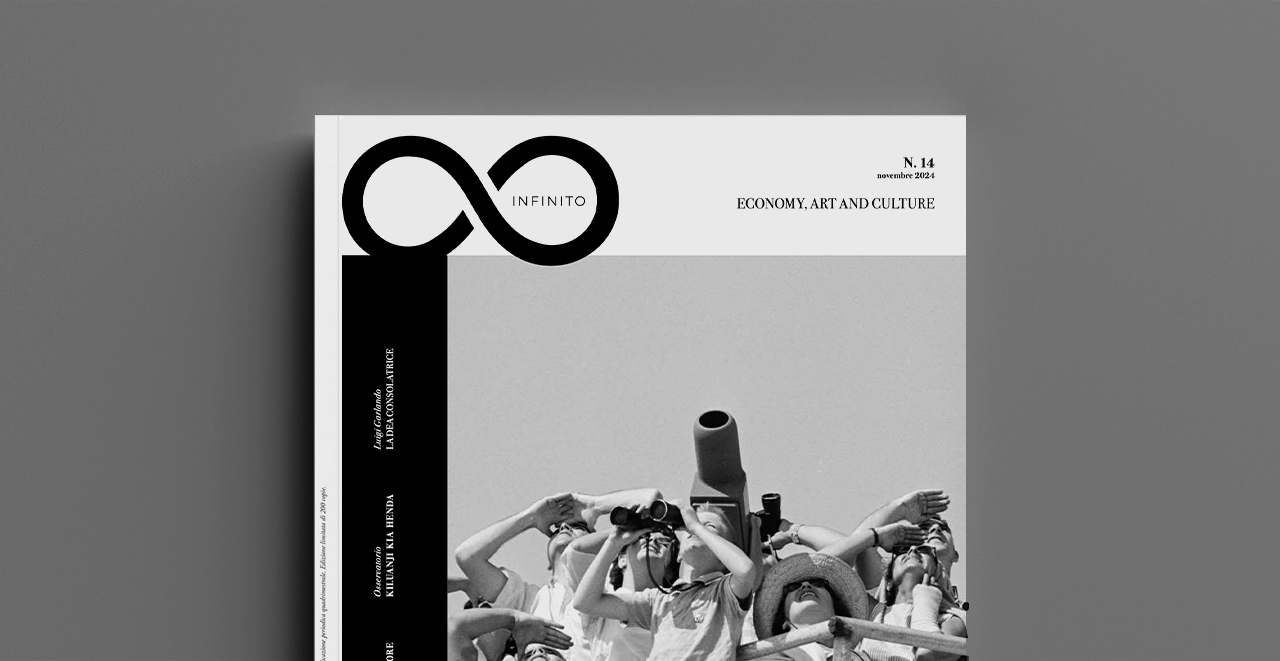Per una nuova lettura aggiornata del pezzo di Veronica Boldrin «Può un algoritmo salvare la vita?» uscito per il numero I di Infinito nel novembre 2017. In quel contributo Veronica Boldrin ci raccontava la storia di Claudio Reverberi e Nicola Gaibazzi, due tra i più noti e autorevoli cardiologi italiani, fondatori della start-up Heart Sentinel focalizzata sullo sviluppo di algoritmi dedicati alla prevenzione in ambito cardiologico. Vediamo dunque dove sono arrivati dopo 8 anni.
Il valore del «medtech»
In Italia, il settore delle startup medico-scientifiche (incluso il comparto delle Life Sciences, come biotech, dispositivi medici e digital health) sta crescendo rapidamente. Attualmente sono attive oltre 5.600 imprese nel settore delle scienze della vita, che rappresenta una parte importante dell'economia del Paese, con un valore produttivo di circa 250 miliardi di euro. Nonostante la rilevanza delle startup italiane nel campo medico-scientifico e il fatto che l’Italia, con un’elevata produttività nel settore farmaceutico, sia tra i leader europei, il peso globale delle sue startup nel contesto delle tecnologie mediche e della salute è ancora inferiore rispetto a paesi come Stati Uniti e Germania, incidendo per meno del 5% sul totale mondiale. Questa scarsa rilevanza è dovuta anche alle sfide che le startup italiane in campo medicale devono affrontare, rendendo difficile la loro crescita e sopravvivenza. Tra queste ci sono una regolamentazione complessa e prolungata, dovuta a normative molto stringenti, alti costi di sviluppo e un accesso limitato ai finanziamenti. Gli investitori italiani tendono infatti a essere più prudenti e meno propensi a rischiare su progetti a lungo termine, come quelli medici, che prevedono tempi lunghi di ritorno sugli investimenti. A ciò si aggiungono barriere culturali, la mancanza di collaborazione con il settore pubblico, la carenza di competenze specifiche, una scarsa digitalizzazione e una cultura dell'innovazione ancora limitata. Nonostante i progressi compiuti, il settore sanitario italiano rimane spesso poco digitalizzato e lento nell’adottare nuove tecnologie, il che rallenta l’implementazione delle innovazioni.
Parlavamo di Heart Sentinel
Queste difficoltà sono state affrontate anche da Heart Sentinel, startup fondata a Parma nel 2016 da Claudio Reverberi e Nicola Gaibazzi, due tra i più noti e autorevoli cardiologi italiani, con l'obiettivo di sviluppare algoritmi in grado di «salvare la vita». Il primo algoritmo rileva un arresto cardiaco, inviando immediatamente messaggi a numeri predefiniti e fornendo, tramite geolocalizzazione, la posizione esatta ai soccorritori, favorendo così un'assistenza rapida e mirata. Il secondo algoritmo segnala automaticamente la presenza di episodi, anche brevi e asintomatici, di fibrillazione atriale, la più comune aritmia cardiaca e frequente causa non riconosciuta di ictus cerebrale. Nel mondo, 33,5 milioni di persone ne sono affette, ma spesso viene diagnosticata solo dopo l’evento ischemico. Una diagnosi preventiva, condizione necessaria per accedere alle moderne terapie prescritte dai cardiologi, riduce il rischio di ictus del 70%.
Nel 2017, sul primo numero di Infinto, avevamo descritto i progetti di Heart Sentinel nella fase finale di sperimentazione, pronti per un percorso di crescita e lancio sul mercato. Qual è la situazione a sette anni di distanza?
«Nonostante i numerosi test di laboratorio avessero confermato l’efficacia del primo algoritmo e contribuito alla realizzazione di pubblicazioni scientifiche presentate in diversi congressi internazionali – racconta il prof. Claudio Reverberi – il progetto non ha trovato i finanziamenti necessari per uno sviluppo commerciale. A questo si è aggiunto anche un fattore di natura culturale e psicologica. Paradossalmente, gli sportivi, ovvero il target cui abbiamo rivolto fin da subito le nostre attenzioni, non hanno accolto di buon grado l’associazione tra ‘arresto cardiaco’ e ‘attività fisica’, portandoli più a pensare a pratiche di ‘scongiuro’ che all’effettivo interesse per la tutela della loro salute. Quindi abbiamo abbandonato questa strada e ci siamo concentrati sul secondo algoritmo, sviluppando un dispositivo oggi presente sul mercato con il nome Ritmia».
Il nuovo sviluppo: Ritmia
Ritmia è un sistema di monitoraggio del ritmo cardiaco che rileva automaticamente le aritmie, inclusa la fibrillazione atriale. Il dispositivo, compatto e pratico – grande quanto una moneta da 2 euro – può monitorare il cuore fino a due settimane senza essere invasivo, grazie a cerotti adesivi o una fascia da cardiofrequenzimetro. Il sensore traccia elettrocardiogrammi (ECG) di alta qualità, facilmente consultabili e condivisibili tramite una app per smartphone Android e iOS. Il device può essere utile a chiunque voglia monitorare il proprio battito cardiaco in modo continuativo, per scoprire eventuali aritmie che possono manifestarsi durante attività fisiche di varia intensità o in soggetti che necessitano di un'osservazione più prolungata. Per diagnosticare la fibrillazione atriale è necessario un monitoraggio continuativo, e solo Ritmia, tra i dispositivi presenti sul mercato, è in grado di farlo.
Il sistema è molto semplice. Basta scaricare l’app sul telefono, registrarsi, associare il dispositivo e fissarlo al corpo con l’apposito cerotto che conferma sul monitor del telefono il corretto posizionamento. Al termine del periodo di registrazione, avvicinando il dispositivo al telefono, i dati vengono trasmessi tramite Bluetooth e viene realizzato un report, che può essere inviato direttamente a un cardiologo o consegnato al proprio medico di fiducia.
«Ritmia – spiega il dott. Nicola Gaibazzi – si differenzia da altri dispositivi innanzitutto perché monitora più a lungo l’attività cardiaca. L’attività registrata, ad esempio, da uno smart watch in commercio è relativa al momento in cui si chiede all’app di farlo, ma in quel momento potrebbe non esserci un episodio di fibrillazione atriale».
Non solo. Ritmia registra l'attività cardiaca come evento elettrico, mentre le normali app in commercio si basano sulla frequenza cardiaca, che può indicare il ritmo, ma non fornisce informazioni sull'attività elettrica del cuore, né su eventuali anomalie strutturali o ischemie.
«L'analisi dei prerequisiti - sottolinea Bernardo Di Maria, Ingegnere Clinico socio di Heart Sentinel - ci ha portato a propendere per un sistema di monitoraggio indipendente dalla connessione allo smartphone. Quest'ultimo viene chiamato in causa soltanto nelle fasi di avvio e download dei tracciati. Nella sua ultima release, inoltre, Ritmia 2.0 consente di eseguire una registrazione estemporanea in real time di un ECG a singola traccia qualora l'utente senta che "qualcosa non va" e voglia fotografare il momento in cui avverte il disagio per successivi approfondimenti a cura del proprio cardiologo».
Il futuro di Ritmia
Nonostante l’efficacia dello strumento e i risultati promettenti a livello di test, Ritmia è ancora ufficialmente uno strumento di pre-diagnosi. «Abbiamo dovuto abbandonare l’idea di ottenere il riconoscimento di Ritmia come dispositivo medico – spiega Claudio Reverberi –. Si tratta innanzitutto di processi molto costosi: parliamo di circa 150 mila euro per il percorso completo. Inoltre, è un iter lunghissimo, che dura in media due o tre anni, un aspetto che scoraggia molti investitori, interessati a rendimenti più rapidi. La società è ancora viva grazie alla collaborazione con un'azienda farmaceutica che ha utilizzato i nostri device per una campagna di sensibilizzazione sull'uso di un farmaco per la cura delle aritmie. Abbiamo anche avviato un canale di e-commerce, che ci ha permesso di vendere alcuni dispositivi a clienti privati, in particolare extraeuropei».
Il dispositivo, acquistabile online, costa circa 220 euro. Viene fornito in una piccola scatola che contiene il device, prodotto in Finlandia, e i cerotti, prodotti in Svizzera. «Su ogni device venduto al pubblico la società ha una marginalità minima – conclude Claudio Reverberi –. Quella sugli algoritmi è una ricerca che potrà fare enormi passi avanti, anche grazie all'intelligenza artificiale. Le potenzialità sono enormi, ma il sistema non aiuta. Abbiamo registrato il brevetto per entrambi gli algoritmi, e per mantenerlo attivo, dobbiamo pagare circa 7.000 euro all'anno, cosa che accade solo in Italia. Inoltre, un altro grande ostacolo è la concorrenza cinese, dove tutto costa un terzo, se non un quinto, rispetto a noi. Se facessimo produrre in Cina il nostro device, sicuramente i margini sarebbero maggiori e più interessanti per gli investitori, ma la sicurezza e la qualità non sarebbero assolutamente le stesse. Se vogliamo andare avanti, serve un investitore che ci prenda per mano. Inoltre, in un settore in cui ogni secondo conta per salvare vite, è essenziale che l'innovazione trovi il sostegno necessario per superare le barriere economiche e culturali, permettendo a soluzioni come Ritmia di diventare una realtà accessibile a tutti».