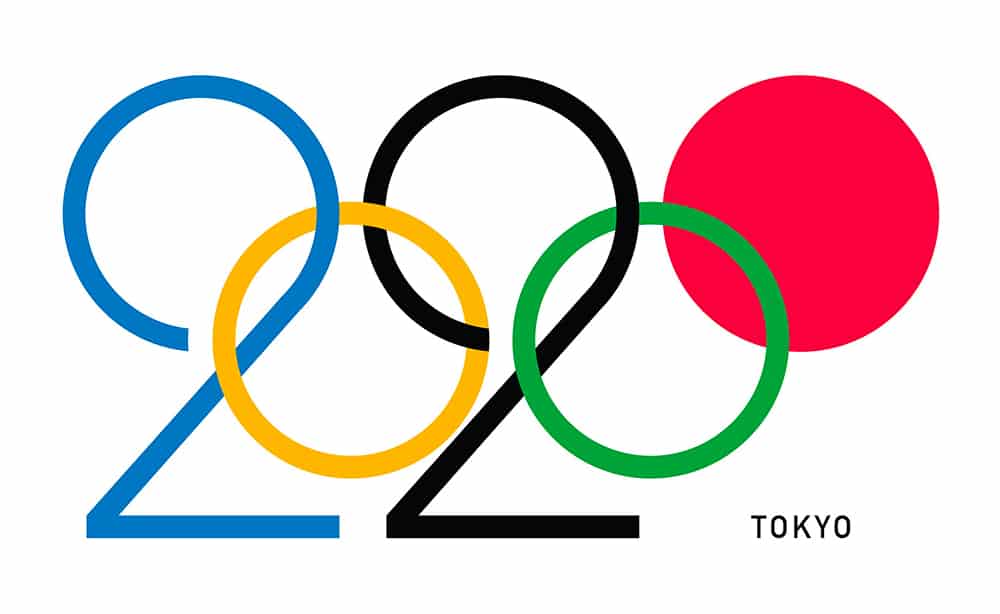Nella nebbia che avvolge la narrazione della nostra storia patria, spesso si fa risalire la caduta del fascismo al 25 aprile del 1945. In realtà la dittatura venne abbattuta una notte di due anni prima, quella tra il 24 e il 25 luglio del 1943, ad opera degli stessi capintesta fascisti, i gerarchi capitanati da Dino Grandi, all’epoca presidente della Camera dei fasci e delle corporazioni, dopo essere stato ministro Guardasigilli, ambasciatore a Londra e tante altre cose. Fu forse la notte più lunga e tormentata del Novecento italiano, nella quale si giocò una disperata partita a poker con tutti i partecipanti disposti a bluffare, a partire da chi occupava il posto a capotavola, vale a dire l’ormai declinante Benito Mussolini. Grandi raccontò di essersi addirittura messo in tasca due bombe a mano.
Chi vi partecipò, a posteriori, raccontò ciò che accadde e perché avvenne, ma le versioni sono talmente discordanti da ingarbugliare ulteriormente una vicenda già di per sé difficile da comprendere. Ho riannodato le fila di ciò che accadde nel libro “La notte in cui Mussolini perse la testa” (Neri Pozza) per cercare di dimostrare che, in realtà, quel tavolo era truccato: dietro alle spalle dei contendenti aleggiavano altre figure, le autentiche padrone del gioco. Grandi era sicuramente il più informato e si guardò bene dal condividere con i suoi alleati le notizie di cui era venuto a conoscenza. Nonostante tutto, anche lui finì nella trappola e si salvò solo fuggendo per tempo all’estero e mantenendosi, per qualche anno, insegnando latino sotto falso nome. Giuseppe Bottai, l’altro personaggio chiave della vicenda, la fece franca con l’aiuto del Vaticano: raggiunse il nord Africa e si arruolò nella Legione straniera sotto falso nome. Prese parte ai combattimenti contro i tedeschi in Francia e si guadagnò sul campo i galloni da sergente, tornando in Italia dopo che Palmiro Togliati fece votare l’amnistia anche per i gerarchi molto compromessi con il defunto regime.
Il terzo giocatore seduto a quel tavolo, Galeazzo Ciano, genero del Duce, meno accorto e più frascone, ma naturalmente tra i più in vista, pagò per tutti. Qualche mese dopo, costituito il governo fantoccio della Repubblica di Salò, venne incarcerato a Verona e giudicato per alto tradimento. A salvargli la vita non bastarono le implorazioni e le minacce di sua moglie Edda Mussolini al padre Benito. Venne giustiziato, insieme ad altri congiurati, in un poligono di tiro veneto una gelida mattina del 1944. Mentre lo fucilavano alla schiena, si voltò e il fotografo lo immortalò mentre si guardava indietro, incredulo di ciò che stava accadendo.
Ma cos’era accaduto? Quella notte tra un sabato e una domenica di fine luglio ’43, venne convocato l’organo supremo del fascismo: il Gran Consiglio. Era sì il luogo delle decisioni supreme, ma da quando era stato creato, poco dopo la Marcia su Roma, era stato sempre dominato e manipolato dal Duce. Lui proponeva, si discuteva blandamente e poi si faceva ciò che l’onnipotente capo del governo aveva già stabilito. Da quando l’Italia entrò in guerra al fianco della Germania, nel giugno del 1940, era stato comunque messo in naftalina. Un po’ per imbarazzo, un po’ perché il dittatore era diventato insofferente alle critiche, pur larvate, di gerarchi che considerava soltanto degli approfittatori. Da maresciallo d’Italia gli pareva di trovare maggiore soddisfazione nel trattare con i militari, usi a obbedir tacendo. Nell’ultima seduta, quella del 1939, il Gran Consiglio (Mussolini compreso) aveva infatti votato la non belligeranza nel caso l’alleato tedesco avesse scatenato una guerra. Italo Balbo, allora vivo prima di venire abbattuto da «fuoco amico», aveva addirittura adombrato la possibilità, se messi alle strette, di schierarsi al fianco delle democrazie inglese e francese. Nel giugno del ’40, però, i membri del Gran Consiglio appresero dal balcone di Porta Venezia che quanto da loro deliberato era carta straccia: l’Italia, a loro insaputa, era entrata in guerra al fianco della Germania ormai padrona di tutto il cuore d’Europa. Ciò che accadde da allora è storia nota in tutti i particolari. Dovunque schierasse le sue truppe, l’Italia si trovava ben presto in difficoltà: in Grecia, in Nord Africa, poi in Russia, quando aderì alla follia di Hitler di invadere l’Unione Sovietica.
Eravamo diventati un esercito sotto tutela: dietro alle nostre spalle dovevano sempre darci man forte, quando non soccorrerci, i tedeschi. E da gregari ci trattarono sin dal primo giorno.
Con l’entrata in guerra degli Stati Uniti, il destino del Patto d’acciaio era ormai segnato. Gli Alleati decisero di lasciare i tedeschi a scannarsi con i russi (nella speranza di Winston Churchill che si elidessero a vicenda) e di concentrarsi con tutta calma sul ventre molle dell’Asse, ovvero l’Italia. Nel luglio del ’43, dopo aver consolidato le teste di ponte in Nord Africa, invasero la Sicilia, cominciando a risalire la Penisola previa sventagliata di bombe su Roma e, in particolare, sul quartiere di San Lorenzo. Mussolini annaspava. Nell’ultimo anno aveva passato più tempo in convalescenza per l’ulcera che gli mordeva le viscere che a Palazzo Venezia, dove pure la luce rimaneva accesa nella Sala del Mappamondo perché «il Duce veglia sempre». Agli inizi di quel fatidico 1943 incontrò due volte Hitler, la prima a Salisburgo e la seconda non lontano da Feltre, con l’intento di fargli abbandonare il fronte sovietico, di trovare un accomodamento con Stalin, e di concentrarsi sulla difesa della «fortezza Europa». Niente da fare. Il führer sbraitava come un ossesso e non voleva sentir ragioni. E intanto i granelli della clessidra che segnava l’avvento di un clamoroso disastro per l’Italia scendevano inesorabilmente.

Mussolini, Federzoni, Volpi, Bottai durante la seduta notturna del Gran consiglio del Fascismo in cui fu approvata la Carta del Lavoro. © Istituto Luce
Fu allora che Grandi e altri gerarchi decisero di passare ai fatti. Ma non avrebbero potuto fare nulla se Mussolini, pur dimenandosi, non fosse stato d’accordo nel farsi imbrigliare. Accettò di convocare il Gran Consiglio, lesse con molto anticipo l’Ordine del giorno Grandi, che sanciva la fine della dittatura e la restituzione dei poteri militari e politici a Vittorio Emanuele III e, senza esserne obbligato, lo fece votare. Il discorso in propria difesa fu, a detta di tutti, fiacchissimo. Inoltre, il generale della milizia Enzo Galbiati aveva già allertato i suoi sgherri per procedere all’arresto dei congiurati, ma Mussolini, pur vestendo i panni della vittima, glielo vietò. Il Duce stava dunque giocando le sue ultime carte, pensando di approfittarne per portare in pellicceria la volpe Grandi. La mattina successiva alla notte del Gran Consiglio, infatti, lo fece cercare disperatamente per offrirgli la carica di ministro degli Esteri nel rimpasto di governo che era convinto di strappare al Re. A quel punto sarebbe spettato a lui, il capo dei congiurati, trattare la pace con gli Alleati, e se l’avesse fatto maldestramente se ne sarebbe assunto la responsabilità di fronte al Paese e al sovrano.
Nella pellicceria finirono, invece, entrambe le volpi, Duce e congiurato. Vittorio Emanuele III, al corrente di ciò che stava accadendo e, anzi, grande manovratore di altre congiure in atto attraverso il ministro della Real Casa, il duca Pietro Acquarone, quella domenica del 25 luglio 1943, a conclusione del colloquio con Mussolini che gli rendeva conto della riunione del Gran Consiglio e gli chiedeva l’incarico per un rimpasto di governo, lo fece arrestare, caricare su un’ambulanza e trasportare in una caserma dei carabinieri. Un’autentica commedia all’italiana.
L’incarico di formare il nuovo governo venne affidato al solito maresciallo di sempre, Pietro Badoglio, a dimostrazione che l’altra congiura in atto, quella dei militari, che prevedeva l’arresto a tradimento di Mussolini all’uscita di un’udienza al Quirinale quando la scorta era blanda, era andata a buon fine senza neppure creare patemi d’animo agli esecutori. Diremo per inciso che, negli stessi mesi, anche il Vaticano, nella figura del vicesegretario di Stato Giovanni Battista Montini, che sarebbe poi diventato Papa con il nome di Paolo VI, armeggiava per facilitare una presa di contatto internazionale e trattare una resa separata. Così come gli antifascisti ancora in Italia e rimasti silenti per oltre un decennio, chi blindato in qualche studio d’avvocato, chi nella Biblioteca vaticana, cominciarono a ritrovarsi e a manovrare nelle vicinanze del Re. Ma tutto questo brusio, questo armeggiare non avrebbe portato a nulla se il Re non avesse tessuto, con l’astuzia e la pazienza tipica dei Savoia, la tela in cui far cadere Mussolini. Quel che avvenne dopo è stato raccontato migliaia di volte. Il Duce rimbalzò dall’isola di Ponza a quella della Maddalena e, infine, a Campo Imperatore, dove i tedeschi lo scovarono, liberarono e insediarono come uno spaventapasseri in una repubblica fantoccio nel nord d’Italia a protezione dei confini germanici.
E Mussolini? Tutto lascia pensare che avrebbe voluto uscire di scena ed estinguersi nella quiete della sua casa a Rocca delle Caminate vicino a Predappio. Lo chiese a Badoglio e lo ribadì in una lettera molto personale e malinconica a sua sorella Edvige. Ma il demone in carne e ossa che aveva turbato i giorni e le notti del Duce italiano, Adolf Hitler, non glielo concesse. Dovette anzi far giustiziare suo genero per dimostrare ai tedeschi e ai fanatici italiani di cui si era circondato a Salò di non aver ricoperto un ruolo nella commedia all’italiana che si tenne la notte tra il 24 e il 25 luglio a palazzo Venezia. Fu una beffa del destino, un capitombolo della storia. Non a caso Bottai, il gerarca più arguto di tutti, nei suoi diari annotò: «Ciò che accadde il 25 luglio smentì ciò che era accaduto il 24». Il gran giocatore che aveva vinto almeno quella mano era Vittorio Emanuele III, ma anche lui dovette pentirsi di aver messo il destino della dinastia e del Paese nelle mani del maresciallo Badoglio. Naturalmente chi pagò il prezzo più alto furono gli italiani.