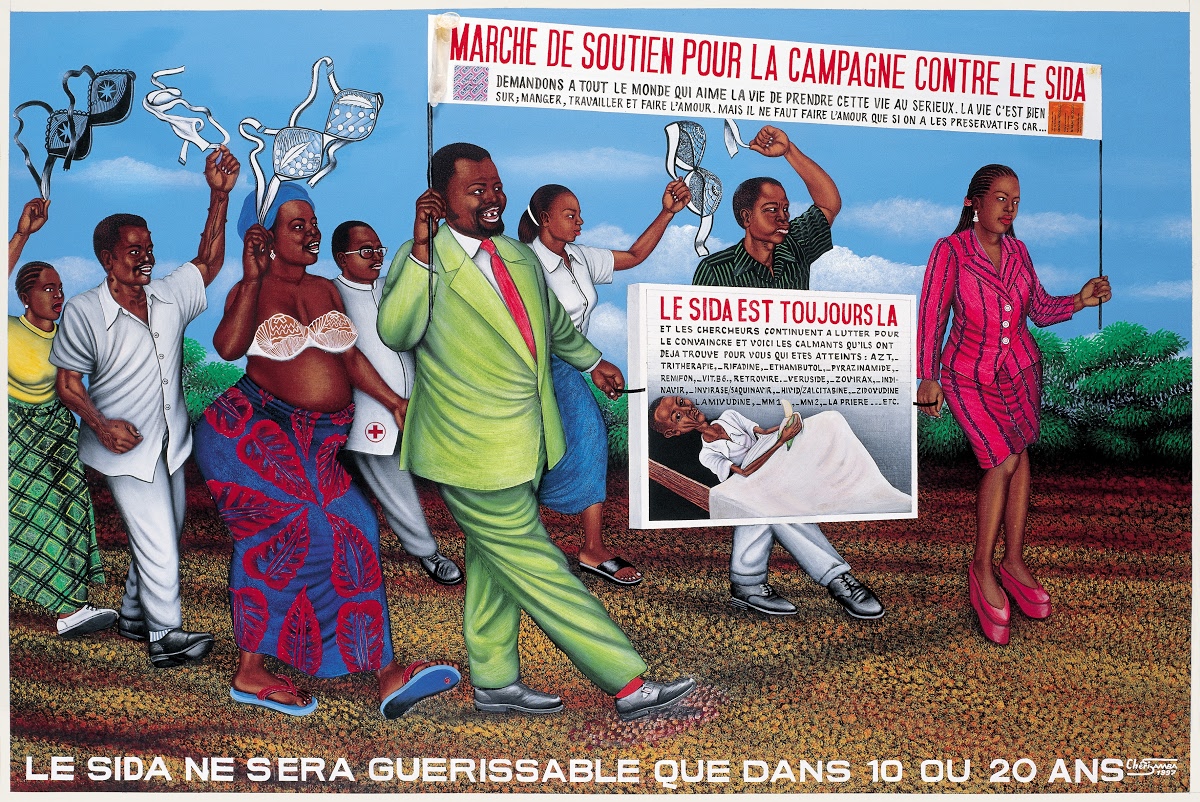Si "litiga" anche sul cibo.
Quando gli oltre duecento atleti della Corea del Sud sono atterrati a Tokyo la scorsa estate per partecipare alle Olimpiadi, da Seul si sono portati dietro anche una squadra di cuochi. Il motivo? La delegazione sudcoreana si era detta preoccupata per il rischio di contaminazione radioattiva del pesce, del riso e degli altri alimenti prodotti in Giappone come conseguenza del terremoto, dello tsunami e della catastrofe nucleare di Fukushima. «Stiamo facendo delle indagini sulla presenza di cesio negli ingredienti», rivelava alla stampa coreana un membro del Comitato Olimpico di Seul. Subito gli organizzatori di Tokyo 2020 si affrettarono però a dire che i prodotti nipponici sono sicuri e controllati, soprattutto dopo che il paese del Sol Levante aveva fatto ogni sforzo per usare queste Olimpiadi - già rinviate di un anno a causa della pandemia - proprio per celebrare la rinascita del Giappone dopo il disastro nucleare dell’11 marzo 2011. Già pochi giorni prima dell’inizio dei Giochi, il presidente sudcoreano Moon Jae-in aveva fatto sapere che non sarebbe andato a Tokyo per partecipare alla cerimonia di apertura. Una decisione che la Casa Blu, il palazzo presidenziale di Seul, prendeva mentre nel paese infuriava la polemica per le parole volgari di un diplomatico giapponese in Corea. Appena arrivati al villaggio olimpico di Tokyo 2020, gli atleti sudcoreani hanno srotolato dai balconi delle loro camere uno striscione con su scritto: «Ho ancora il sostegno di 50 milioni di coreani». Caratteri in alfabeto hangul che conoscono tutti nella penisola: l’evocazione delle parole - «Ho ancora dodici navi da guerra» - pronunciate alla fine del Cinquecento dall’ammiraglio coreano Yi Sun-sin prima di una leggendaria vittoria sull’invasore arrivato dal Giappone. Le imprese del comandante navale sono la versione coreana del mito di Davide contro Golia: forte di solo dodici vascelli da guerra, Yi Sun-sin decimò nel 1592 la più numerosa e meglio armata flotta nipponica. «L’uomo più ammirato e più temuto dai giapponesi», lo definì l’ex presidente sudcoreano Park Chun-hee solo pochi mesi dopo la firma del controverso accordo che nel 1965 normalizzava le relazioni tra Tokyo e Seul. È stato solo dopo le proteste della destra nazionalista nipponica e il monito del presidente del Comitato Olimpico Internazionale che la delegazione sudcoreana ha deciso di rimuovere lo striscione che prendeva in prestito le parole di questo eroe nazionale del XVI secolo.
Il passato che ritorna.
Le tensioni tra Giappone e Corea del Sud, andate avanti anche durante le Olimpiadi di Tokyo, dimostrano quanto le vicende del passato continuino a essere importanti in Asia, mentre i fatti storici influenzano ancora l’opinione pubblica, la politica e la diplomazia. A dividere le due democrazie dell’Asia nord-orientale sono soprattutto le cicatrici della storia: i numerosi tentativi giapponesi di invadere la penisola iniziati nel VII secolo, ma soprattutto l’occupazione nipponica della Corea iniziata nel 1910 e finita solo con la Seconda Guerra Mondiale. Prima di rimuovere lo striscione dai balconi del villaggio olimpico, la delegazione sudcoreana ha infatti voluto rivendicare di aver convinto il CIO a vietare l’esposizione negli stadi della kyokujitsu-ki, la bandiera del Sole nascente: un cerchio rosso da cui partono 16 raggi, che in molti paesi dell’Asia è ancora associata all’imperialismo giapponese durante la Guerra nel Pacifico. Ma non è la sola Corea a provocare reazioni diplomatiche. Alla vigilia dell’anniversario della resa del Giappone nella Guerra del Pacifico, due esponenti di alto profilo del governo giapponese di Yoshihide Suga - il ministro della Difesa e quello dell’Economia - si sono recati in visita al controverso santuario Yasukuni di Tokyo. Mentre nel resto del mondo gli occhi erano puntati sull’imminente caduta dell’Afghanistan nelle mani dei Talebani, da Pechino e Seul arrivano le consuete condanne contro un gesto che è visto come una provocazione. Costruito nel 1869 dall’imperatore Meiji in un’area verde non distante dal cuore politico della capitale giapponese, questo santuario shintoista è dedicato alle vittime della guerra: poco meno di 2 milioni e mezzo di nomi di servitori dell’impero caduti nei decenni del militarismo del Sol Levante in Asia.
A infiammare l’opinione pubblica in Cina e Corea è soprattutto il fatto che nel santuario Yasukuni ci sono anche i nomi di quattordici criminali di guerra di classe A condannati per «crimini contro la pace». Per i paesi vicini, ogni visita di esponenti del governo di Tokyo allo Yasukuni è la celebrazione del passato imperialista del Sol Levante, oltre che la prova che il paese vuole tornare ad armarsi abbandonando la Costituzione pacifista imposta dagli americani dopo il 1945. Secondo gli analisti, le visite dei papaveri del Partito Liberal Democratico sono però soprattutto un modo per solleticare gli umori degli elettori più anziani, conservatori e spesso revisionisti.
«Il vero problema è il museo militare Yushukan vicino al santuario», scriveva tempo fa Francis Fukuyama. «Passando davanti a Mitsubishi Zero, a carri armati e mitragliatrici - spiegava l’accademico su Project Syndacate - si trova la storia della Guerra nel Pacifico che restaura “la verità della storia giapponese moderna”: vittima delle potenze coloniali europee, il Giappone ha solo cercato di proteggere il resto dell’Asia. L’occupazione coloniale giapponese della Corea è descritta come “una partnership”, mentre si cerca invano un resoconto delle vittime del militarismo giapponese a Nanchino o a Manila». Eppure, nell’ottobre del 1998, l’allora presidente sudcoreano era volato a Tokyo per ricevere le scuse dal Giappone. Cresciuto sotto l’occupazione del paese del Sol Levante, Kim Dae-jung conosceva bene le brutalità che aveva subito la Corea negli anni di dominazione straniera: la repressione del dissenso, i tentativi di diluire l’identità della penisola al punto da costringere i coreani a adottare nomi giapponesi, mentre Tokyo sfruttava risorse e manodopera locale nell’industria bellica e manifatturiera. Nella dichiarazione congiunta diffusa dopo quell’incontro, il primo ministro conservatore giapponese Keizo Obuchi riconosceva «gli enormi danni e sofferenze» causate al popolo coreano durante il periodo coloniale, mentre esprimeva «profondo rimorso e sincere scuse».
E' possibile superare la storia?
Accettando quella mossa da parte del Giappone, Kim Dae-jung spronava entrambi i paesi a «superare la loro storia sfortunata» e a «costruire una relazione orientata verso il futuro e basata sulla riconciliazione». Esattamente vent’anni dopo quelle parole, la cronaca racconta però che i due più importanti alleati dell’America nella regione faticano a trovare una via di uscita dagli eventi che hanno segnato la prima metà del XX secolo. Nell’autunno del 2018 la Corte Suprema di Seul decide che due colossi nipponici - la Nippon Steel e la Mitsuishi Heavy Industries - devono pagare risarcimenti per decine di milioni di won a ciascuno dei sudcoreani che ha fatto causa denunciando di essere stato vittima di lavoro forzato durante la Seconda Guerra Mondiale. Secondo le stime di Seul, infatti, nei decenni di occupazione della penisola sono stati oltre 7 milioni i coreani arruolati con la forza nell’esercito imperiale o costretti a lavorare nelle fabbriche dove si alimentava il militarismo del Sol Levante. Temendo però una pioggia di richieste di risarcimento contro le 300 aziende giapponesi coinvolte nel lavoro forzato, Tokyo rifiuta di riconoscere quelle sentenze. La questione - spiega il governo nipponico di Shinzo Abe - è stata risolta una volta per tutte con l’accordo del 1965 che ha normalizzato le relazioni tra i due paesi e con cui il Giappone ha versato alla Corea del Sud centinaia di milioni di dollari in aiuti e prestiti agevolati. Secondo l’amministrazione giapponese quella pagina di storia è stata chiusa e le cause rappresentano una violazione del diritto internazionale, invece per Seul l’intesa non può precludere alle vittime di chiedere indennizzi. Intanto, nel dibattito pubblico del paese inizia anche a farsi largo l’idea che se i colossi giapponesi non pagano, si possono allora sequestrare gli asset economici che le compagnie possiedono in Corea.
L'ingresso pesante di Trump.
È a quel punto che l’amministrazione giapponese di Shinzo Abe inizia a fare le prime mosse. Mentre infuria la guerra commerciale tra gli Stati Uniti di Donald Trump e la Cina, anche le dispute sul passato tra le due democrazie dell’Asia nord-orientale minacciano di rallentare le catene delle forniture globali. All’inizio di luglio 2019, Tokyo impone restrizioni sull’esportazione verso la Corea del Sud di tre prodotti chimici fondamentali per la produzione di display e semiconduttori, lasciando così la Samsung e gli altri giganti dell’elettronica di Seul senza molte alternative sul mercato. Mentre l’Amministrazione del presidente democratico sudcoreano Moon Jae-in minaccia di fare ricorso all’Organizzazione mondiale del commercio, Tokyo addirittura rimuove la Corea del Sud dalla «white list» di 26 paesi - inclusi gli Stati Uniti - che godono di una corsia preferenziale per fare affari con il Giappone. Il messaggio è chiaro: il Sol Levante spera di far crescere la pressione del mondo del business coreano sul governo di Moon Jae-in così da convincerlo a raffreddare le tensioni sulla storia. Intanto la risposta dei sudcoreani è il boicottaggio della catena di abbigliamento giapponese Uniqlo e, più in generale, del turismo in Giappone, mentre con un’ulteriore escalation Seul annuncia che a novembre non rinnoverà il General Security of Military Information Agreement: l’accordo con cui i due principali alleati dell’America in Asia si scambiano informazioni di intelligence sulla Corea del Nord.
«Una volta terminato - ammoniva Victor Cha, tra gli specialisti di Corea più ascoltati a Washington - sarà difficile ricostituire l’accordo a causa degli ostacoli politici interni sul passato, in particolare in Corea del Sud». Non solo: «Sebbene sia una vendetta contro il Giappone, questa mossa indebolisce anche l’alleanza tra Stati Uniti e Corea del Sud perché indebolisce la cooperazione tra i tre paesi».
Solo sei ore prima della scadenza dell’accordo, la Corea del Sud torna sui suoi passi: «per il momento», fanno sapere, Seul rimarrà all’interno dell’accordo che era stato fortemente voluto da Washington per creare un fronte comune contro le minacce nucleari di Pyongyang e la crescente influenza della Cina nella regione. Solo una manciata di settimane più tardi arriva però un’altra sentenza di un tribunale di Seul che questa volta ordina al Giappone di pagare un risarcimento a ciascuna delle 12 donne coreane che avevano presentato la causa per un’altra pagina estremamente controversa della storia del Giappone in Asia all’inizio del XX secolo. Le chiamano comfort women - «donne di conforto» - un eufemismo dietro cui si maschera il destino di 200 mila ragazze coreane che durante l’occupazione giapponese della penisola vennero mandate al fronte per fare da schiave sessuali all’esercito imperiale. «È stato un crimine contro l’umanità commesso dal Giappone in modo sistematico, deliberato e in violazione delle norme internazionali», ha spiegato il giudice nella sentenza.
L'accordo revocato.
I conservatori giapponesi contestano però che le donne coreane siano finite nelle «stazioni di conforto» contro la loro volontà, e sostengono invece che venivano pagate per i servizi sessuali offerti all’esercito imperiale. Soprattutto a Tokyo la questione si considera risolta in modo «definitivo e irrevocabile» con l’accordo firmato nel 2015 da Shinzo Abe e dall’ex presidente sudcoreana Park Geun-hye. Quell’intesa - sostenuta con forza anche dall’Amministrazione americana - prevedeva che il Giappone avrebbe presentato le scuse e offerto una grossa somma di denaro destinata a una fondazione di aiuto per le «donne di conforto» ancora in vita. Quando però l’ex presidente coreana - figlia dell’uomo forte di Seul che nel 1965 aveva normalizzato le relazioni con il Giappone - viene travolta dallo scandalo politico-giudiziario che la rimuove dalla Casa Blu, il suo successore democratico Moon Jae-in si affretta a dire che «la gente in Corea è contraria all’accordo firmato da Park». Al momento dell’elezione di Moon, nella primavera del 2017, già da qualche mese che i rapporti tra Tokyo e Seul si stanno facendo di nuovo incandescenti dopo che una «statua della Pace» è stata eretta davanti al consolato giapponese di Busan. La sagoma di una «donna di conforto» esposta nella seconda città della Corea - un’adolescente seduta su una sedia, lo sguardo impassibile e fiero, i piedi nudi e i pugni stretti nelle mani - è identica a quella già svelata nel 2011 sul marciapiede opposto all’ambasciata di Tokyo a Seul. Mentre in questi anni le «statue della Pace» si sono moltiplicate e il governo di Moon Jae-in non ha perso occasione per chiedere al Giappone «scuse sincere», altre recentissime sentenze di tribunali della Corea del Sud hanno capovolto i precedenti verdetti dicendo che le questioni storiche devono trovare una soluzione attraverso la diplomazia. In un momento in cui l’amministrazione di Joe Biden sottolinea l’importanza delle alleanze per contenere l’ascesa della Cina nella regione, a Washington ci si chiede anche se le due democrazie dell’Asia nord-orientale saranno mai in grado di mettere da parte le dispute sul passato. «È la geopolitica la fondamentale divergenza tra Giappone e Corea del Sud», notavano però gli specialisti di relazioni internazionali Tayuka Matsuda e Jaehan Park. «Il Giappone è un paese proiettato sui mari che vede nella Cina la sua principale preoccupazione. Invece, la Corea del Sud vede in Pechino un partner economico fondamentale che può anche rivelarsi utile per realizzare la sua più importante ambizione geopolitica: unificare la penisola coreana alle sue condizioni. Le questioni che riguardano la storia e la memoria - proseguivano gli accademici - sono pesanti e rendono più difficile conciliare interessi contrapposti, non è però il passato la sfida principale in Asia nord-orientale, bensì la geopolitica».