Da St. Louis, Senegal. Quella notte Mama Maïsa Dieye non fece in tempo a raccogliere le vecchie fotografie di famiglia e nemmeno il suo unico vestito buono, dono d’una cugina di Dakar, né il batik appeso sopra il letto con l’immagine di Amadou Bamba, il leader sufi più venerato tra i pescatori, pittato su quasi tutte le ottomila piroghe della «Langue». Quando arrivò l’onda, quella notte di marzo del 2018, Mama Maïsa ebbe pochi secondi per decidere. Caricò il nipote più piccolo sulle spalle e riuscì a strapparne altri due alle grinfie dei flutti. Le viene un groppo in gola a pensare alle cinque capre che rimasero legate all’uscio principale, quello che affacciava sull’oceano: «Vidi i loro occhi disperati, poi sparirono insieme alla casa», mi dice sotto una delle tende lungo il Quai de pêcheurs, dove sta trattando la vendita di un blue marlin che peserà un centinaio di chili. Come sua madre e la madre di sua madre e come fanno da secoli tutte le donne della «Langue», Mama Maïsa, 49 anni e undici figli, si occupa del pesce quando gli uomini rientrano dall’Atlantico, lo preleva dalle piroghe scivolando in mare fino alla cintola e lo porta a riva reggendo in capo un grande mastello. La sabbia è intrisa di sangue, decine di corvi, falchi e gabbiani si contendono famelici le interiora, l’aria caldissima sa di sale, di sudore e di plastica bruciata, la vita della comunità ribolle in un eccitante rimando di voci, urla e risate. Eppure, il mondo di Mama Maïsa sta crollando, tempesta dopo tempesta, ondata dopo ondata. L’oceano se lo sta portando via con tutte le radici; per gli 80 mila abitanti della «Langue» l’unico futuro possibile è una nuova vita altrove, da sradicati. Questo è il fronte più caldo del cambiamento climatico, per l’Onu è il «luogo più vulnerabile del mondo», per la Banca Mondiale è «la città-benchmark per quel che accadrà in molte aree urbane costiere», l’alfa delle catastrofi prossime venture lungo i litorali del pianeta. E non solo perché è dove gli effetti dell’innalzamento dei mari sono qui maggiormente visibili, testimoniati da un paesaggio di rovine che ricorda certe città terremotate o bombardate, con migliaia d’edifici, case, scuole, moschee di cui rimangono solo avanzi spettrali ammassati sul litorale, ma perché questa lingua di terra è la più densamente popolata al mondo, una sorta di «Manhattan» africana di pescatori collocata alla foce del fiume Senegal. La Langue de Barbarie - così chiamata perché fondata dai berberi, ma ritenuti barbari - è una stretta penisola che s’estende dal confine della Mauritania a Nord per circa trenta chilometri parallelamente alla terra ferma, tra l’oceano e il delta del fiume; ed è un quartiere di St. Louis, collegato da due ponti al vecchio centro coloniale della città che fu la prima capitale dell’Africa occidentale sotto il dominio francese. Dal Duemila il borgo coloniale di St. Louis, costruito tra il Seicento e l’Ottocento con lo status di Comune di Francia, centro della tratta degli schiavi e della gomma arabica, è diventato patrimonio Unesco perché molte splendide dimore storiche hanno ben resistito alla salsedine, ma anche allo spirito del Senegal indipendente, storicamente lontano dai sentimenti antifrancesi che hanno invece caratterizzato ad esempio il confinante Mali. Se la sua natura anfibia e una certa patina délabré hanno assegnato a St. Louis il soprannome di «Venezia d’Africa», ora, in tempo di crisi climatica, il gemellaggio assume toni assai meno romantici. Ciò che sta accadendo alla Langue, solo a poche centinaia di metri dal vecchio palazzo del governatore in via di restauro e dal distretto dove se la spassano i turisti, potrebbe accadere molto presto all’intera città, che conta oltre 150 mila persone - c’è chi parla d’una decina d’anni. Perché l’Atlantico sfonda la costa come un ariete, ne porta via otto metri l’anno. Le onde sono rostri che sventrano le abitazioni, e generano un mare di rifugiati climatici, finora già 15 mila, il numero più alto al mondo.
La nuova Langue
Un giorno sono stato a Djougop, a 12 chilometri di St. Louis, in piena savana. È qui dove si sta costruendo la «nuova Langue». Ho incontrato Insa Fall, 25 anni, l’ingegnere che è il referente locale del piano d’intervento statale, affidato a un’apposita agenzia per l’emergenza climatica: «Abbiamo un budget di 95 milioni», mi ha detto, «15 stanziati dal governo e 80 dalla Banca Mondiale. Procediamo sul fronte urbanistico, con la costruzione delle infrastrutture e quindi delle prime cinquemila abitazioni che dovrebbero essere pronte entro il 2023, e contemporaneamente affrontiamo gli aspetti sociali, queste persone devono iniziare una nuova vita lontano dall’oceano. È un progetto pilota, siamo i primi al mondo a gestire una simile emergenza causata dal cambiamento climatico». Alle famiglie dei rifugiati è stata offerta la scelta di farsi pagare il valore stimato delle loro case alla Langue de Barbarie, oppure di ricevere un’abitazione adeguata al nucleo famigliare nella newtown. Per ora il piano prevede, oltre alla rilocazione di coloro che hanno già perso tutto, l’obbligo di sgombero per le famiglie che continuano ad abitare nell’«area rossa», entro i venti metri dal fronte mare. A circa quattromila rifugiati sono già state assegnate unità abitative che ricordano un campo militare o minerario. Il villaggio è l’embrione della futura città che sta per nascere oltre il recinto, dove i caterpillar scavano strade e fognature. Il sole picchia implacabile sui prefabbricati color sabbia, il vento solleva turbini di polvere, bisogna girare con il viso coperto come i tuareg. Michelle Gueye, 50 anni, guida il comitato dei residenti, si occupa della «riconversione sociale», cioè è incaricata dei corsi per insegnare alle donne a cucire, diventare parrucchiere e a coltivare orti, cioè a passare dalle spigole al mango. Michelle fa parte dei primi sfollati, quelli dell’ondata del 2017, 180 famiglie che prima furono sistemate per qualche mese in una scuola abbandonata della Langue de Barbarie e poi nel campo di Khar Yalla, una baraccopoli ai margini di St. Louis dove vivono ancora trecento persone senza fognature e acqua corrente. «Io ero preparata», mi ha detto, «in quei giorni la tempesta era spaventosa, vedevo la vecchia massicciata costruita dai francesi nel 1950 che si sbriciolava. Eravamo in dodici in casa, avevamo riempito qualche sacco con le cose più importanti. Poco dopo la preghiera delle cinque del mattino una prima onda ha abbattuto parte della casa, così siamo fuggiti, giusto in tempo perché una seconda onda ha portato via un’intera parte del quartiere Guet Ndar». Nel 2019, in marzo, lo sfondamento è avvenuto un chilometro più a Sud, al quartiere Santhiaba, altre duemila persone senza tetto. Michelle è tra quelli che si sono rassegnati alla nuova esistenza nei prefabbricati: «Mi manca tutto della Langue, gli odori, addormentarmi con il rumore delle onde. Lì le case non hanno serrature, per fare dieci metri devi fermarti a parlare con venti persone, se sei in difficoltà ognuno tira fuori qualcosa. La Langue è una dipendenza. Guarda, vedi come si sta seccando la mia pelle qui al campo? Sto diventando un’altra persona anche fisicamente».
C’era una festa di matrimonio quella sera nel lotto cinque tra i prefabbricati, le donne vestivano abiti tradizionali, ma era l’unico segno d’un evento che alla Langue sarebbe stato un’apoteosi di musica, balli e cibo. C’erano solo bambini, mancavano gli uomini perché gli autobus arrivano da St. Louis che è già buio. «Oggi queste donne sono rimaste qui al campo», diceva Michelle, «ma altrimenti vanno quasi tutti alla Langue ogni mattina, gli uomini in mare e donne a vendere o a salare il pesce, partono alle 5 del mattino e ritornano alle 9 di sera. Il loro mondo è ancora là, anche se ci vogliono due ore di autobus per fare 12 chilometri. Senza l’oceano morirebbero». Il costo è altissimo rispetto a chi ancora vive alla Langue, non solo in termini di perdita di storia personale e collettiva: significa spesso uscire più tardi in mare e quindi dover andare più al largo degli altri, così si pesca meno e si guadagna meno. Le donne si trovano a dover rientrare con l’ultimo bus prima dell’arrivo delle piroghe, oppure sono costrette a prendere dei taxi vanificando il misero guadagno della giornata. «Sempre meglio che stare chiusi in questa maledetta prigione rovente», mi ha detto Aida Sy, la madre dello sposo, una pescivendola vestita da regina, ma con gli occhi che avevano assorbito tutte le sfumature della sconfitta.
La Groenlandia chiama, l’Africa risponde.
Secondo gli scienziati ciò che accade a St. Louis – e che minaccia molte altre comunità costiere nel mondo – è collegato allo scioglimento dei ghiacci nell’Artico, che si sta riscaldando quattro volte più velocemente al resto del pianeta secondo un documento pubblicato dalla Nasa. Se si sciogliesse la Groenlandia gli oceani s’alzerebbero di oltre otto metri, ma già l’Atlantico meridionale negli ultimi quattro anni è aumentato del 60 per cento in più rispetto alle previsioni. La Corrente del Golfo subisce alterazioni e rallentamenti allarmanti e gli effetti si vedono, secondo alcuni studi, nella desertificazione dell’Africa subsahariana, dove sta andando in cortocircuito l’alternanza tra stagioni umide e secche: è calcolato che quasi 90 milioni di persone saranno costrette a migrare nei prossimi dieci anni. Un’altra onda infatti preme non lontano da St. Louis, a monte del fiume Senegal, cioè dalla regione sud occidentale del Mali, non più risparmiata dal tornado che sta investendo il Sahel, dove carestie e inondazioni alimentano esodi e violenza jihadista: fino a quando questa regione vulnerabile del Senegal riuscirà a resistere al contagio che arriva dall’interno? Alla Langue de Barbarie stanno costruendo una nuova barriera per arginare l’oceano, con il finanziamento di 15 milioni di euro concesso da Manuel Macron: il 14 luglio del 2022, simbolicamente nel giorno più caro alla Francia, un riconoscente Macky Sall, presidente del Senegal, ha inaugurato i lavori, anche se non si tratta di un dono dell’ex colonizzatore, ma di un prestito. La massicciata fa parte del piano di protezione per prolungare la vita, o l’agonia, di questa comunità. C’è poi un altro frangiflutti, questo sì pagato da Parigi, e sta a una trentina di chilometri al largo, tra i confini marittimi del Senegal e della Mauritania, costruito dal gruppo francese Eiffage: 21 cassoni, lunghi 55 metri, alti 32 e larghi 55 ciascuno, per un peso complessivo di 340 mila tonnellate di cemento e acciaio, una sorta di «Mose» – per rimanere sul parallelo Venezia-St. Louis - però irremovibile, piazzato sul fondo dell’Atlantico a protezione delle piattaforme della BP, il più grande complesso d’estrazione di LNG e petrolio dell’Africa, chiamato Greater Tortue Ahmeyim (GTA), ben visibile dalle macerie della Langue. Entrerà in funzione nel 2023, ma produce già polemiche, perché fa un certo effetto che davanti all’esempio più plastico di crisi climatica si stagli un gigantesco impianto di sfruttamento di combustibili fossili. GTA è soprattutto diventato una bandiera politica dell’Africa che si ribella alle imposizioni ambientaliste occidentali, vissute come un colonialismo di nuova generazione. Ho incontrato Abba Mbaye, economista formatosi a Parigi, rappresentante locale del partito nazional-populista che s’oppone a Macky Sall. Eppure, sul tema del diritto all’estrazione anche lui sposa la linea del presidente senegalese e attuale leader dell’Unione africana, portavoce d’un continente che non accetta più gli accordi internazionali sulla transizione ecologica e il blocco allo sfruttamento di gas e petrolio: «Produciamo il 4 per cento delle emissioni globali. Come possono dirci di svilupparci con le rinnovabili? Non è mai stato così da nessun’altra parte e non può essere a St. Louis e in Africa», mi ha detto Mbaye.
«Rivendichiamo il diritto di sfruttare le nostre risorse, non accettiamo più l’ipocrisia dei governi occidentali che sono felici di ingoiare gas in patria ma hanno stabilito una moratoria sul finanziamento di nuovi impianti in Africa. Solo per venderci le loro tecnologie verdi. No, è il nostro turno di sviluppare e porre fine alla povertà. Ci dicono di non inquinare… quando l’Europa e l’America tornano addirittura a bruciare carbone. E a noi viene impedito d’usare il nostro gas, non per riscaldare le piscine, ma per avere la luce elettrica». Bene, dunque, il mega impianto della BP, quello che però contesta il parlamentare di St. Louis è che «non è accettabile che questi colossi si prendano il 90 per cento dei profitti. Che cosa resta al Senegal, che cosa resta ai pescatori della Langue?»
Resto a casa.
Sotto la tenda della «borsa del pesce» sul Quai de pêcheur, Mama Maïsa Dieye mi confessa che ha optato per il contributo statale a risarcimento della casa persa con l’onda del 2018. Ha visto come vivono quelli dei prefabbricati, lì non ci vivrebbe un’ora. «Se mi danno i soldi li prendo, ma di qui non mi muovo. Verrà l’esercito a sfollarci? Mi lascerò morire, camminerò nell’oceano fino ad annegare. E comunque qui stiamo già morendo». Lei è accampata sulle macerie della sua proprietà, praticamente sulla massicciata che stanno costruendo, e così è per altre centinaia, migliaia di abitanti della Langue che si rifiutano di diventare profughi. Nonostante il rapporto tra la Langue e l’oceano sia entrato in crisi prima che arrivasse l’onda maledetta. Il pesce se lo sono preso cinesi, portoghesi, italiani, francesi, con le loro navi-fabbrica. Per quelli della Langue restano poche miglia, e anche queste interdette dal complesso della BP, sorvegliato dalla guardia costiera senegalese. I giovani s’avventurano in acque mauritane rischiando il sequestro della piroga, le multe e la prigione. Così questi lidi sono diventati la rampa di lancio per la migrazione clandestina verso le Canarie: pochi quelli che ce la fanno, inviano foto d’improbabili vite prosperose in Europa, esche per nuove partenze, di ragazzi sempre più giovani. Un pomeriggio ho incontrato Latyr Fall, 38 anni, che riverniciava la piroga davanti ai resti della storica moschea della Langue, stava disegnando lo stemma del Barcellona sulla prua. Era da poco ritornato dalla Spagna appunto, dove raccoglieva fragole nelle serre. «Se sei della Langue devi morire nella Langue. Senti come profuma l’aria qui?»


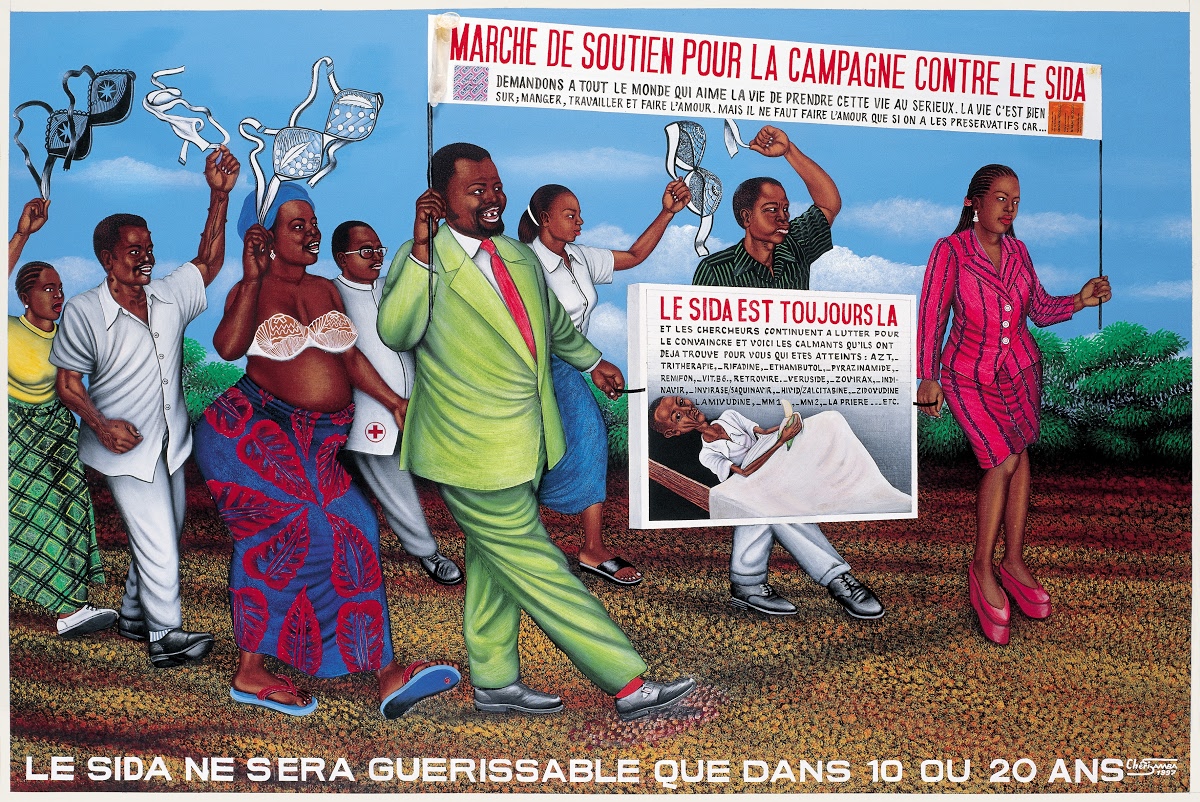
_Dd4VV.jpeg)



_upR9F.jpg)
