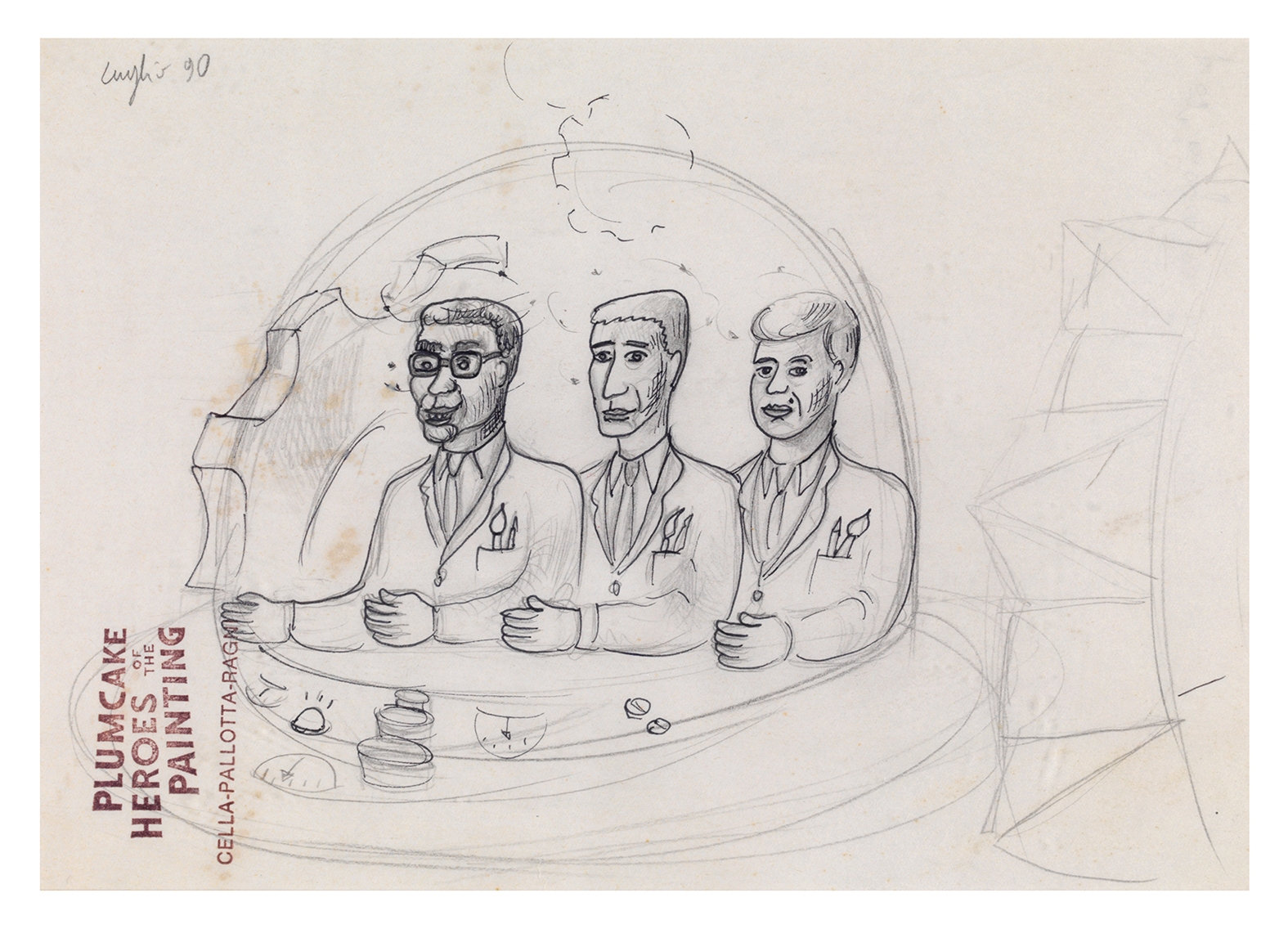Fatta eccezione per la presenza degli ospiti che arrivano a Parigi con volo privato, e che comunque sono sempre di meno, in particolare dal nord Europa dove imperversa il “flight shaming”, cioè lo svergognamento di chi usa troppo spesso l’inquinatissimo aereo, magari a fini ludici, le sfilate della haute couture di Parigi hanno aggiunto un nuovo plus all’attrattiva straordinaria che già possiedono, e cioè l’intrinseca sostenibilità delle collezioni. Mentre il fast fashion è entrato a sua volta nella pipeline dello “shaming” e va affannandosi a creare capsule collection in tessuti sostenibili e campagne di recupero di abiti smessi per re-indirizzare verso la propria offerta la “sensibilità del cliente”, nuovo paradigma del consumo dopo che, per dieci anni, lo si è definito “informato”, la haute couture vive uno straordinario momento di gloria: mostra infatti solo abiti bellissimi, realizzati con tessuti di alta qualità in pezza unica, tinti con colori naturali o comunque privi di cromo, tagliati, cuciti e ricamati a mano da sarti ed artigiane che vengono pagati non solo “eticamente”, ma per quanto valgono, cioè a peso d’oro.
Pur con le dovute differenze, quasi tutte attribuibili a fattori esogeni come i costi e i materiali usati per la sfilata, il consumo di gas e benzina per il trasporto degli invitati, il consumo di elettricità eccetera, un abito di alta moda di oggi costa più o meno quanto sarebbe costato nel Rinascimento: una fortuna. Si può anche spendere di meno, naturalmente, anche molto di meno, eppure, come ricorderanno i nostri nonni per chi è ancora così fortunato da averli, anche fra le famiglie agiate cambiare guardaroba tutte le stagioni era non solo un lusso inaudito, ma uno spreco sibaritico, immorale: le signore andavano dalla sarta per due-tre abiti al massimo, i signori per un nuovo completo, magari un cappotto e un nuovo set di camicie. Ai guardaroba traboccanti di capi “divertenti”, quasi sempre poco durevoli e di origine incerta, in Occidente ci siamo abituati da qualche decina di anni.
L’altra faccia della medaglia è la seguente: una tonnellata di abiti di fast fashion ne produce 17 di Co2 quando una tonnellata di plastica solo 5; poi, certamente, nel mondo si produce plastica in misura maggiore rispetto a gonne e pantaloni, però non si tratta comunque di dati di cui si possa andare orgogliosi. Lungo tutta la sua vita da piantina di cotone a indumento amatissimo che buttiamo in lavatrice più di quanto dovremmo, un solo paio di jeans consuma 2800 litri d’acqua, e si tratta di una cifra già diminuita di quasi un quarto rispetto a dieci anni fa, grazie all’impegno dei vari attori del processo, dai coltivatori, ai filatori, ai tintori.
Senza volerlo, ma si tratta di un dato indiscutibile che Legambiente ha denunciato da poco, noi italiani contribuiamo in misura importante alla desertificazione del mondo. E come mai, visto che i capisaldi della nostra economia e del lifestyle che vendiamo sono moda, design e alta cucina? Appunto. Nel solo 2018 abbiamo comprato dal Brasile 25.400 tonnellate di carne congelata: il 50 per cento di questa è stata utilizzata per produrre la bresaola della Valtellina igp. Gli allevamenti hanno bisogno anche di soia (267mila dal Brasile e 114mila dal Paraguay) per produrre i mangimi animali, e per quanto riguarda l’olio di palma (di suo non avrebbe niente di male, ma abbattono le foreste per coltivare le piante) oltre 1,2 milioni di tonnellate arrivano da Indonesia e Malesia. Ed eccoci con la deforestazione in tavola. Non va meglio ai nostri piedi. L’Italia è il primo esportatore europeo di prodotti in pelle; un settore d’eccellenza il cui materiale di lavorazione proviene dagli scarti dell’industria alimentare animale. E fin qui, tutto sostenibile. Ma c’è un ma: buona parte di queste pelli provengono dal Sudamerica, dai famosi allevamenti ottenuti con le vie note in Brasile.
Dunque? Dunque, e per fortuna, la consapevolezza va aumentando, non solo fra i clienti finali ma fra i produttori: lo scorso settembre marchi come Timberland, Vans e The North Face hanno firmato dichiarazioni in cui si impegnano a non acquistare pelli provenienti dal Brasile, e a dicembre l’unione europea ha emanato un mandato che obbliga gli stati membri a sviluppare un marchio ufficiale ”deforestation free”. Quando si dice che la moda è la seconda industria più inquinante al mondo dopo quella del petrolio, non lo si fa per colpevolizzare chi acquista ancora a cuor leggero, spesso perché incapace di rassegnarsi allo shopping ben più scarno che potrebbe permettersi comprando eticamente, spesso e solo perché meno informato di quanto creda: lo si dice perché è, semplicemente, la verità. Le premesse di quanto viviamo oggi vennero lanciate nella Londra e nella Manchester narrate da Charles Dickens, nelle piantagioni degli stati unionisti del sud, nelle fabbriche dei coloranti chimici della Germania, non dimenticatelo. La consapevolezza dei danni prodotti dalla produzione di moda, in particolare fast fashion, è invece recentissima: circa dieci anni per i più accorti di noi esperti e analisti, meno di cinque per l’industria, solo due per i consumatori, eccezion fatta per il gigante dell’e-commerce guidato da Federico Marchetti, YNap, che iniziò a lavorare sul packaging riciclabile ancora nel 2009 e passo dopo passo sta eliminando emissioni e trattamenti inquinanti da ogni fase del proprio processo, fino alla consegna che, nelle grandi città mondiali, viene fatta su mezzi elettrici. A fine gennaio di quest’anno, il fashion forum Global Fashion Agenda si è ritrovato a Davos per aggiornare dati e programmi, in particolare sulla tracciabilità della filiera. Dopo un anno di programmi, è infatti tempo di agire. Ma agire costa moltissimo, e non solo in termini economici.
La riconversione del modello attuale di produzione di moda e accessori durerà almeno un decennio, anche senza voler prendere in considerazione i tanti fattori geo-politici che vi giocano contro, ammette il presidente della Camera della Moda Carlo Capasa, che impone regole molto severe ai propri aderenti, soprattutto in tema di chimica dei componenti e logistica, e lavora da anni a un disegno di direttiva da sottoporre a Bruxelles con il supporto della Francia, secondo produttore di moda di qualità dopo l’Italia con il suo 42 per cento di quota:«Ci diamo altri cinque anni per fare un punto», dice. Ce ne vorranno, come minimo, altri dieci. Stiamo parlando di centinaia di milioni di persone, qualche decina in Europa, chiamata ad investire denaro a miliardi, per convertire tutte le fasi di un sistema di produzione ex-novo, investendone molti altri in aggiunta nel suo smaltimento e nella sua riconversione. Il recupero, il famoso riciclo che sembra tanto evidente – dopotutto il capo è già lì, che cosa ci vuole – è invece incredibilmente complesso. I nostri abiti non sono assimilabili in nulla a quelli dei nostri trisavoli; sono capolavori di complessità chimica e manifatturiera, fra tessuti in composti misti, accessori (zip, bottoni, cuciture), applicazioni. Scomporre e riciclare tutti questi elementi è diventata un’impresa industriale a sé. Dalla lunga, difficile e lenta conversione del modello produttivo del tessile-abbigliamento discende anche la difficoltà nell’approvvigionamento di materie prime e di semi-lavorati sostenibili. Attualmente, l’offerta non è sufficiente per soddisfare una domanda che va crescendo a ritmi del 20-30 per cento all’anno, come racconta Carlo Boselli, figlio del presidente onorario della Camera della Moda Mario e massimo importatore di poliestere, sia filato sia tessuto pre e post consumer, cioè nuovo e di riciclo. Questo prodotto arriva in buona parte dalla Cina, che è fra i principali produttori di pet riciclato. In tema di cotone, la materia è ancora più impervia: quello di riciclo ha la fibra troppo corta e produce gli aborriti “pallini”.
Perciò, bisogna usarne di nuovo, ma è ormai accertato che la coltivazione di cotone sia altamente impattante sull’ambiente. Dunque, solo bio, ad averne e soprattutto a volerlo pagare per quel che vale: i costi, fino a oggi, sono stati assorbiti dai filatori stessi, a cui spetta anche il sostegno ai coltivatori etici attraverso programmi internazionali come Better Cotton Initiative. Per quanto riguarda tessuti di riciclo molto pubblicizzati, come il nylon, è difficilissimo farsi un’idea del suo costo. Molto dipende dalle origini (vecchie reti da pesca, o tappeti, o indumenti), ma si tratta comunque di un segreto, al momento, molto ben conservato. Il costo di un capo in nylon riciclato di firma, diciamo un piumino, si aggira attorno ai mille euro. Il costo di uno zainetto Prada in Re-nylon, pur bellissimo, è di 1350 euro, da cui risulta evidente che fino a quando la conversione del modello produttivo della moda non sarà diventata patrimonio comune, cioè saranno diminuiti i costi della filiera, dirsi sostenibili sarà il nuovo marcatore del benessere. L’ecologia si deve fare sui grandi numeri, dicono tutti. Al momento, l’unica cosa chiara è il gran battage che vi si fa attorno.