La Fondazione Merz quella sera era avvolta da una foschia diradata che non annunciava alcunché della mostra di Bertille Bak, così come il suo stesso titolo «Mineur Mineur», dal quale si poteva desumere una approfondita ricognizione delle condizioni dei minatori, dal taglio fotogiornalistico come fu per il caso del suo stesso lavoro video che coinvolgeva i venditori di gamberetti tra Olanda e Marocco[1]. Non è stato così. E molto di questo scarto lo si deve alla prospettiva che l’artista decide di imprimere all’intera mostra alla Fondazione Merz: quella dei «minuers mineurs», i bambini che lavorano nelle miniere, in questo caso di cinque grandi paesi produttori, l’India (carbone), l’Indonesia (stagno), la Tailandia (oro), la Bolivia (Argento) ed il Madagascar (zaffiri). All’ingresso dell’architettura della Fondazione questo scarto, questo delta emotivo e formale, si materializza subito nelle sembianze di una giostra senza movimento, una di quei caroselli di paese (dalle mie parti si chiamava «pentalcù»). Alle spalle, una quinta di animali in legno o cartapesta che sembrano osservare lo spettacolo che è al contempo desolante, melanconico ed anche ironico. Sulla destra della giostra che si illumina ma non si desta, una lunga fila composta da alcune strutture in ferro sulle quali lo spettatore può salire per osservare, con la testa all’ingiù, il buco offerto da una struttura in cartone. Questo gesto sembra una sorta di rito iniziatico, una tana del Bianconiglio, uno stargate da cui passare per accedere al mondo che la Bak ha predisposto per noi. O forse la rappresentazione plastica di quelle miniere, antri bui e strettissimi in cui i bambini entrano disegnando con la loro creatività infantile delle proiezioni giocose (qui rappresentate nei cartoni da fili di neon colorati), che presto però si infrangeranno anche nel durissimo lavoro che li attende. Passati da questo meta-luogo iniziatico ci troviamo al centro di un palco su cui, come fossero lì eretti fisicamente, stanno quattro monitor verticali di circa due metri l’uno. All’interno i mineurs che ballano, girano su sé stessi e si muovono nelle miniere, mescolando video reali a stralci interpretativi, che riprendono, dalla musica all’aspetto, le pellicole di Wes Andersen o la Amélie di Jean-Pierre Jeunet. È questo scarto tra la condizione reale di questi bambini e la loro rappresentazione che ci spinge un po’ oltre. L’opera e la mostra sembrano riprodurre il meccanismo mentale ideato da René Saavedra, il protagonista realmente esistito, di «No – i giorni del silenzio». Quando un pubblicitario realizzò la campagna (risultata incredibilmente vincente) per il referendum sulla presidenza del dittatore cileno Augusto Pinochet nel 1988. Il creativo capì che la campagna a sostegno del «NO», contro la rielezione di Pinochet e la sua consacrazione a dittatore ad-interim, non poteva insistere sulla morte e sulla devastazione portata dal regime. Questo avrebbe impaurito le masse, le avrebbe spinte nella paranoia di continuare a vivere quelle atrocità. Ed ecco che René Saavedra concepì una campagna tutta fatta di arcobaleni, persone felici che cavalcano nude puledri bianchi. Vendette un sogno: quello di una vita che inizia con un «NO». Bertille Bak mi sembra René Saavedra. Ci parla della vita di quei bambini mostrandoci il mondo che hanno dentro, ridisegnando il loro circostante con gli strumenti visivi e creativi dell’infanzia, in cui il mimetismo è tutto, dove un pennarello diventa un aeroplano con il quale evadere e viaggiare per tutto il globo. Ma non finisce qui, Bertille Bak compie una ulteriore operazione di metalinguaggio: se al piano terreno della mostra il registro immaginifico ci butta in questa discrepanza tra realtà narrata e narrazione, nel sottosuolo della Fondazione Merz, al piano meno uno, un lungo video di 19 minuti ci rigetta nelle viscere delle miniere e delle morti dei minatori in quei luoghi di lavoro che scoinfina nello sfruttamento. È un contrappunto ruvido a quello che abbiamo visto di sopra: è la dura realtà; e lo è ancora di più se la contestualizziamo oggi, dove l’estrazione e la distribuzione di materie prime risulta essenziale per le economie moderne, e lo stress che molti di questi mercati stanno vivendo produce effetti domino rilevanti sugli approvvigionamenti, sulle economie nazionali e sull’equilibrio geopolitico mondiale. Ecco che la mostra compie il suo percorso e ci lascia attoniti ed un po’ straniti.
[1] «Boussa from the Netherlands» (2017)


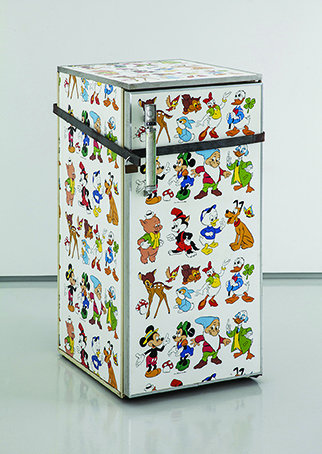
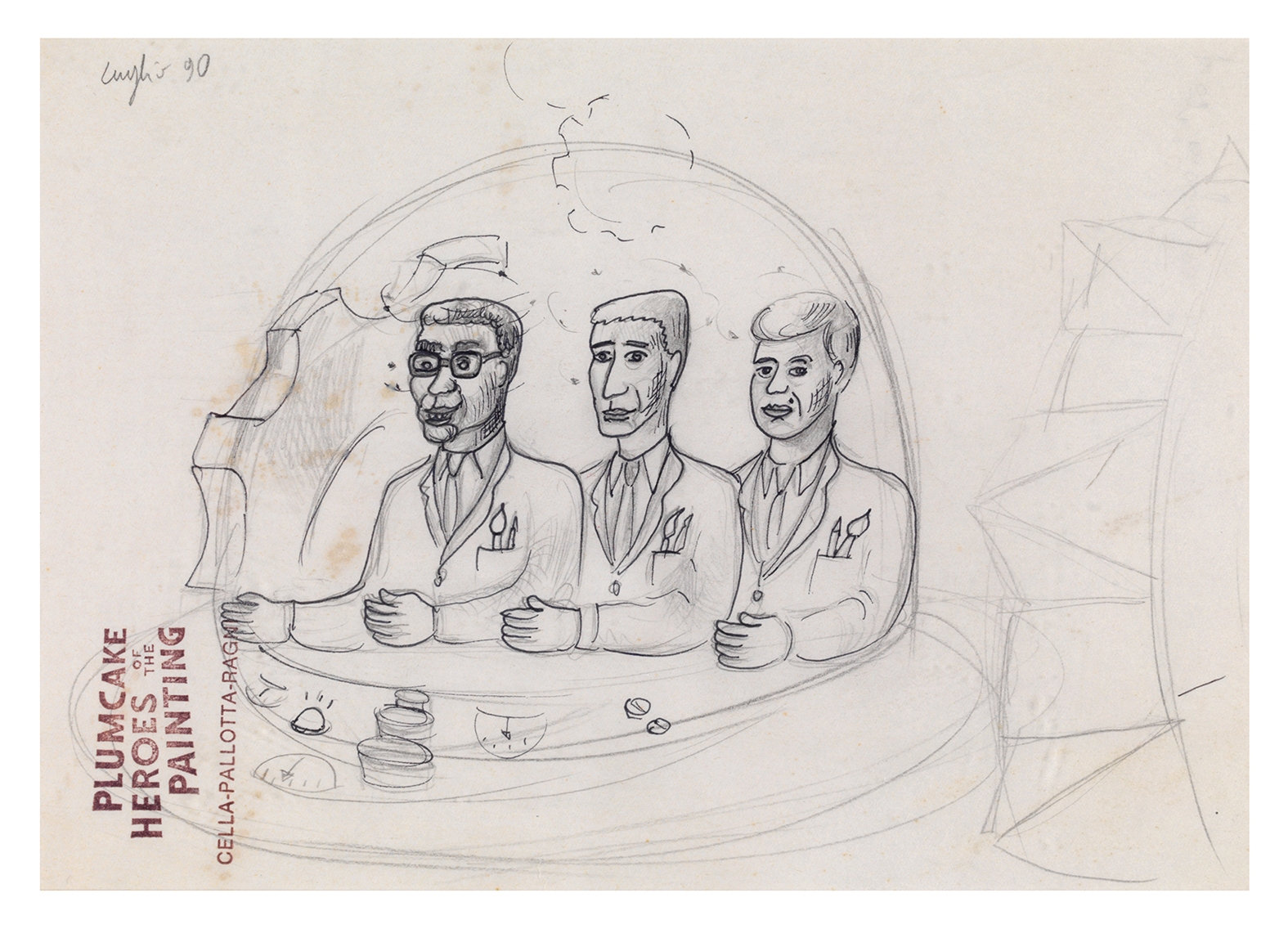



_upR9F.jpg)
_Dd4VV.jpeg)
