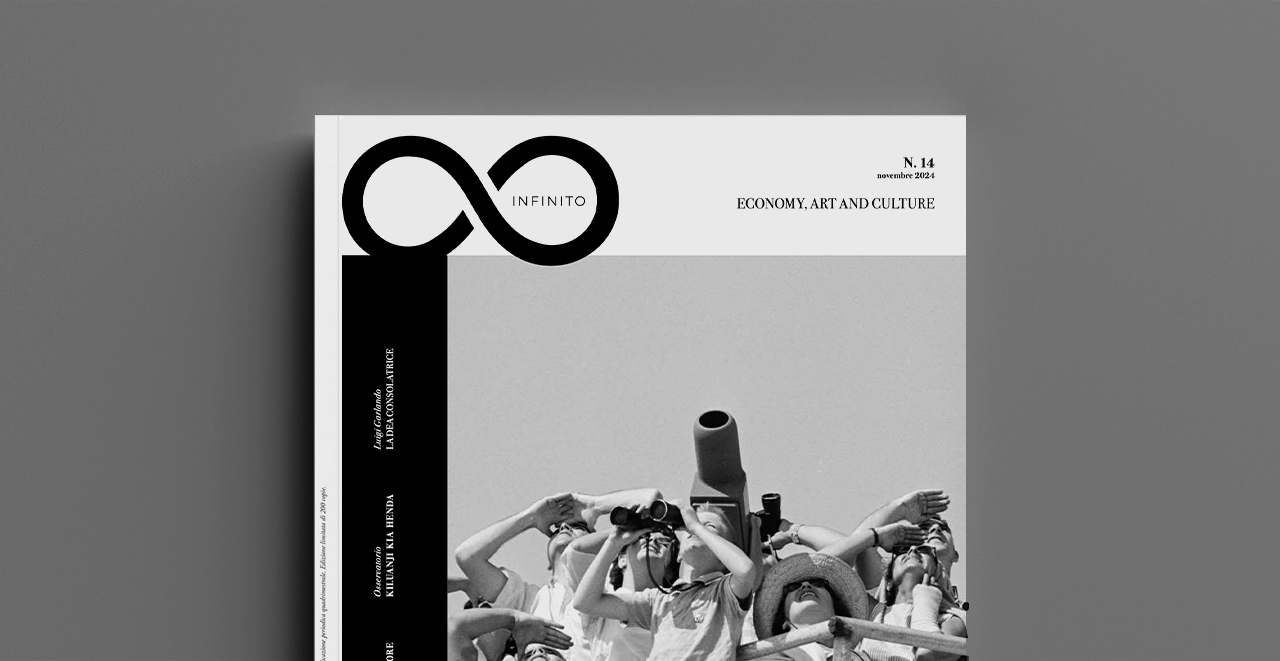Per una nuova lettura aggiornata del pezzo di Andrea Marinelli «L’anno delle donne» uscito per il numero V di Infinito nel marzo 2019. In quel contributo Marinelli si chiedeva se il 2019 fosse davvero l’anno delle donne, tra #MeToo e Ocasio-Cortez, dopo Hillary Clinton e prima di Kamala Harris. E quanto di quel 2019 c’è o ci sarà in questo 2024?
#MeToo cinque anni fa
Cinque anni possono essere un soffio, oppure un’eternità. Ci eravamo lasciati a marzo del 2019, con l’anno delle donne alle spalle e un’elezione presidenziale alle porte: Donald Trump era alla Casa Bianca da poco più di due anni; il movimento #MeToo aveva aperto uno squarcio sugli abusi maschili e aveva contribuito a trasformare questa rinvigorita consapevolezza femminile in una forza civile e politica; il simbolo di quegli abusi – il potentissimo produttore cinematografico Harvey Weinstein – era da qualche mese rinchiuso in carcere in attesa di processo; al Congresso americano erano appena state elette 117 donne che avevano portato il totale a 127 (su 535 parlamentari), un record assoluto per gli Stati Uniti. Almeno fino a quel momento. Quel 2019 appena iniziato era dominato dalle battaglie per i diritti – o contro i diritti – e sembrava avere una direzione chiara, quasi prevedibile. Non avevamo tuttavia ancora mai sentito parlare di Covid, non c’era una guerra in Ucraina – o quanto meno non c’era stata un’invasione, perché in Donbass si combatteva già da anni – non avevamo assistito al 7 ottobre, una data che è divenuta uno snodo cruciale non solo per il Medio Oriente. Insomma, rileggere il mondo di allora è un po’ come guardare un vecchio film per l’ennesima volta e sapere che sta per arrivare un colpo di scena. Eppure, c’è un modo per riannodare quella storia, per tornare all’anno delle donne, e parte da Hillary Clinton.
Lo snodo chiamato Hillary Clinton
Cinque anni fa la sorpresa per la sua sconfitta alle presidenziali del 2016 era ancora grande: non solo per chi la sosteneva, o l’aveva votata, o detestava Donald Trump, ma per tutti coloro che davano un po’ per scontato il risultato di quelle elezioni. Il mondo stava ancora elaborando quell’improvviso, inatteso, cambio di direzione. Clinton aveva ottenuto quasi tre milioni di voti in più a livello nazionale, ma aveva perso per meno di 80 mila preferenze in tre Stati – Michigan, Wisconsin, Pennsylvania – che si erano rivelati fatali. In quella notte di novembre del 2016 lo stesso Trump si era stupito di essere diventato presidente, mentre Clinton aveva aspettato la mattina successiva per parlare di un soffitto di vetro contro cui si era infranto il suo sogno di diventare la prima donna presidente degli Stati Uniti. Alla vittoria di Trump rispose la «marcia delle donne», che il 21 gennaio 2017 scesero in piazza in tutti gli Stati Uniti per protestare contro il maschilismo del presidente appena insediato e innescarono la scintilla che portò, alle successive elezioni di metà mandato, a toccare il record della rappresentanza femminile in Congresso. Da allora il numero di donne che contribuiscono a indirizzare la vita quotidiana degli americani ha continuato ad aumentare: nel 117esimo Congresso eletto nel 2020 erano 147, in quello attuale, eletto nel 2022, sono diventate 149.
Gli elettori e le donne in politica
Dal 2016 le donne che hanno ottenuto cariche elettive, conferma un’analisi del centro di ricerca Reflective Democracy Campaign, sono aumentate notevolmente, non solo in Congresso ma anche a livello statale: fino al 2014 detenevano un quarto dei seggi mentre oggi sono arrivate a un terzo, con le donne di colore hanno raddoppiato la propria rappresentanza. La presenza femminile, inoltre, è aumentata in ogni ufficio federale. «Gli elettori sono decisamente più abituati a vedere donne in politica», ha confermato all’Atlantic la direttrice di Reflective Democracy Campaign, Brenda Choresi Carter. «Ora accettano questa realtà e soprattutto la votano: è un trend che riguarda tutto il Paese, gli Stati rossi conservatori e quelli blu democratici». Durante le elezioni del 2020, però, c’è stato un altro snodo fondamentale. Quell’anno, 29 democratici – fra i quali sei donne – si candidarono alle primarie presidenziali per sfidare Trump a novembre: gran parte di loro si ritirò prima ancora che le votazioni cominciassero a gennaio, in undici si diedero battaglia fino al Super Tuesday senza particolari slanci. Alla fine, prevalse l’ex vicepresidente Joe Biden che con l’aiuto decisivo del suo partito – Barack Obama in testa – riuscì ad allineare tutti i contendenti promettendo di sfruttare la propria esperienza per rimettere in sesto un’America gravata da crisi epocali, di restare in carica per un solo mandato e di nominare una donna come vicepresidente. La scelta ricadde sulla senatrice della California Kamala Harris, una di quelle sei donne che aveva corso alle primarie e dei diciotto candidati che si erano ritirati prima del voto in Iowa. La sua campagna presidenziale era naufragata fra le polemiche dello staff che aveva parlato di caos e del suo carattere autoritario, ma poi si era trovata – una dote che gli hanno sempre riconosciuto tanto i veri amici quanto i detrattori – al posto giusto nel momento giusto. Il 3 dicembre 2019 si ritirava dalla contesa elettorale, l’11 agosto 2020 era la candidata democratica alla vicepresidenza degli Stati Uniti, il 21 gennaio 2021 prestava giuramento sulle scale del Campidoglio ed entrava alla Casa Bianca.
Il momento giusto
Quattro anni dopo, Kamala Harris si è trovata di nuovo al posto giusto al momento giusto. Se quella del 2016 era stata la campagna elettorale più folle della storia recente e quella del 2020 la aveva superata di gran lunga, il 2024 è assolutamente fuori competizione: un presidente in carica che si ricandida nonostante quella promessa di governare per un solo mandato, ma poi si ritira a metà luglio, dopo un dibattito scioccante; uno sfidante che è già stato presidente ed è stato riconosciuto colpevole di 34 reati in un tribunale di Manhattan che sopravvive a due attentati; una vicepresidente ritenuta una delusione tanto a destra quanto a sinistra che in meno di 24 ore si assicura l’appoggio del partito e di conseguenza la nomination, provocando un inatteso entusiasmo fra gli elettori democratici ormai rassegnati a votare Joe Biden. O a non votare. E così Kamala Harris potrebbe diventare non solo la prima donna a guidare gli Stati Uniti, ma anche la prima donna nera e la prima persona di origine asiatica. A differenza di Hillary Clinton – che, come disse lo stratega democratico David Axelrod, si sminuì puntando sul genere e diventando un simbolo – la sua campagna elettorale non ne fa accenno: il suo programma è incentrato sui temi – l’aborto, principalmente, ma anche la sanità, la giustizia o l’immigrazione – piuttosto che sulla sua identità. C’è chi dice che abbia imparato dagli errori di Clinton, chi ritiene che non abbia bisogno di rimarcare i suoi primati e chi, invece, crede sia in fondo anche merito dell’ex first lady: nel 2016 perse, ma ha normalizzato l’idea di una candidata donna alla presidenza.
Rivoluzioni e retroguardie
In questa frase, che ci ha riferito l’ex manager delle sue campagne elettorali in California, Brian Brokaw, si ritrova un po’ la vera essenza della società americana: ai grandi passi avanti in termini di diritti rispondono grandi battaglie di retroguardia, alle conquiste seguono le frenate, al progressismo di Barack Obama replica il più brutale conservatorismo rappresentato da Donald Trump, al movimento #MeToo ribatte la decisione della Corte Suprema di abrogare la sentenza Roe v. Wade cancellando così il diritto federale all’aborto. Sono strattoni che permettono alla società di ricalibrarsi e che contribuiscono – ormai a fatica, va detto – a mantenere l’America nel suo (precario) equilibrio. Questo continuo gioco di pesi e contrappesi ha trasformato gli Stati Uniti, che non sono più quelli di otto anni fa, quando Hillary Clinton perse le elezioni. «Dopo di lei, gli elettori sono più a proprio agio con l’idea di una donna presidente: ha cambiato la concezione di cosa sia possibile», ha spiegato al New York Times Christina Wolbrecht, scienziata politica dell’Università di Notre Dome che studia i flussi di voto. Le senatrici Amy Klobuchar, Kirsten Gillibrand ed Elizabeth Warren sono state prese seriamente durante le primarie del 2020, sostiene Wolbrecht, così come l’ex governatrice della South Carolina Nikki Haley quando quest’anno ha sfidato Trump alle primarie repubblicane.
Oggi, secondo uno studio della sondaggista Tresa Undem, la percentuale di americani che ritengono gli uomini leader migliori delle donne è calata dal 16% del 2016 al 13% del 2022, mentre nello stesso periodo è raddoppiata la percentuale di coloro che considerano le donne leader migliori degli uomini, passata dal 6% al 14%. Questo trend, sostiene la scienziata politica della University of Virginia Jennifer Lawless, è riscontrabile in quasi tutti i campi professionali: «Ormai c’è pochissima differenza fra un candidato maschio o femmina», ha spiegato all’Atlantic. «Gli stereotipi di genere sono diminuiti in modo considerevole, non c’è più la tendenza a ritenere l’uomo più solido».
Gli Stati Uniti sono un Paese diverso perché Clinton ha perso le elezioni, otto anni fa, ma anche perché Trump quelle elezioni le ha vinte. «Quelle che all’epoca erano solo preoccupazioni per le sue posizioni, a cominciare dall’aborto, oggi sono diventate realtà», ha ricordato al New York Times Laurie Nsiah-Jefferson, direttrice del Center for Women in Politics and Public Policy all’università del Massachusetts di Boston. «Quando fu eletto eravamo arrabbiate, ci furono marce e dimostrazioni, e avevamo soltanto un’idea di ciò che poteva succedere. Oggi sappiamo cosa è successo».
Non è il genere
Si è sempre detto che gli americani votano guardando al portafoglio, ma nel 2016 uno studio dello scienziato politico della Tufts University Brian Schaffner riscontrava che i due principali indicatori di un voto per Trump erano l’ostilità verso le richieste di maggior equità razziale e di genere, i due temi che più motivavano gli elettori di Clinton. Non dipendeva, secondo Schaffner, dai due candidati: la stessa divisione venne riscontrata anche alle elezioni di metà mandato del 2018 e alle presidenziali del 2020, quando in corsa c’erano due maschi bianchi e ultrasettantenni. Nel 2016, sostiene, si consumò una sorta di riallineamento: gli elettori che avevano una visione più tradizionale del ruolo della donna nella società andarono con i repubblicani, quelli più femministi scelsero i democratici. Anche partendo da questo dato, molti studiosi che analizzano i flussi elettorali ritengono che il genere dei candidati avrà un impatto minimo sul risultato delle presidenziali che termineranno il 5 novembre: Harris potrebbe anche perdere qualche preferenza, ha spiegato Schaffner all’Atlantic, ma quasi tutti gli elettori che non sono a proprio agio nel votare una donna o una persona di colore – o entrambe le cose – già sostengono Trump e lo avrebbero votato anche se in corsa ci fosse stato Biden. Sicuramente la candidata democratica ha subito attacchi che non avrebbero nemmeno sfiorato un uomo – di aver fatto carriera andando a letto con uomini potenti, di essere una gattara senza figli, di essere stata scelta per motivi di diversità, equità e inclusione: una classica «DEI hire» – eppure, ritiene la scienziata politica Lawless, «non subirà la stessa resistenza a cui andò incontro Clinton nel 2016: un po’ perché all’epoca era la prima donna in corsa per la presidenza, un po’ perché era di per sé una figura controversa già dai tempi della Casa Bianca». Insomma, se il 2018 era stato l’anno delle donne, il 2024 potrebbe davvero essere quello della prima donna presidente.