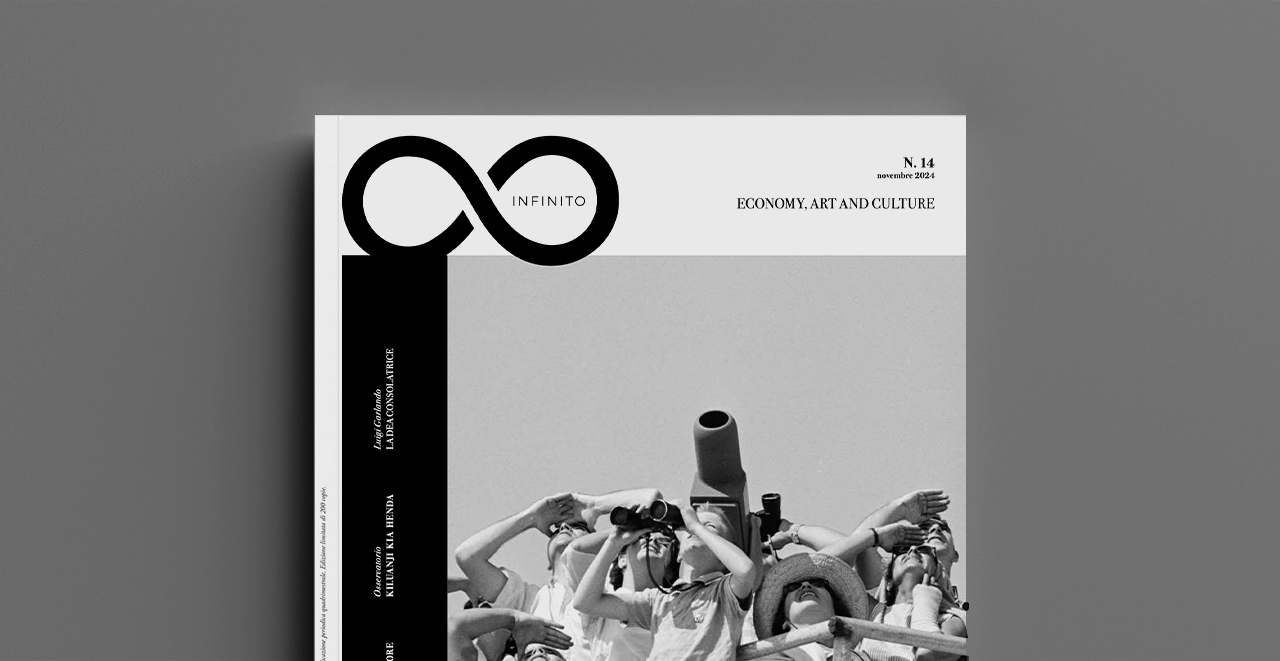Per una nuova lettura aggiornata del pezzo di Ferruccio De Bortoli «Il giornalismo scomodo salverà il mondo, e i quotidiani» uscito per il numero I di Infinito nel novembre 2017. In quell’occasione De Bortoli scriveva come fosse convinto «che debba essere la società a governare la tecnologia e non viceversa» e che nel dominio dei giganti digitali e tech, spesso americani, poteva esserci una speranza se non di auto-controllo per lo meno di sensibilità verso un migliore equilibrio sociale. Sentimento forse testimoniato dallo stesso Jeff Bezos che, acquisendo il controllo del Washington Post, non si è limitato all’uso sapiente di tecnologie digitali ma ha assunto i migliori cronisti e dato spazio alle inchieste più estreme. Il tutto sullo sfondo di una dichiarazione dello stesso Bezos che De Bortoli riprende, «“La carta scomparirà?” è stato chiesto al ridanciano Bezos nel corso del convegno “The future of newspaper”, organizzato a Torino per il 150 anni de La Stampa. Il tycoon americano ha detto di no. “Sarà come un oggetto di lusso, sarà come comprare un cavallo che nessuno più usa come mezzo di trasporto”. Ma il giornalismo non è né uno splendido purosangue, refrattario al morso, né il ronzino piegato dalla fatica. Casomai è il fantino».
La debolezza degli stati
La memoria della parola scritta è implacabile. Non perdona. Rileggo dopo sette anni quello che scrissi nel primo numero di Infinito e stento a riconoscermi. La principale ingenuità è stata credere che i grandi guru del web, prima o poi, si sarebbero convertiti alle regole di un sistema democratico. Che avrebbero alla fine assunto la veste - anche e soprattutto per interesse - di guardiani della civiltà occidentale. Del resto, nascevano quasi tutti nella libertaria Silicon Valley che mostra di non disdegnare le posizioni più populiste e conservatrici. Qualche volta temo, invece, tutti questi paladini dell’innovazione che ora scommettano sull’intelligenza artificiale, stiano diventando gli aguzzini dei sistemi economici e istituzionali dei loro Paesi. Hanno controparti politiche deboli che peraltro finanziano a piene mani con masse di denaro che assumono uno sgradevole contorno corruttivo. I loro fatturati sono pari se non superiori a quelli degli Stati che non riescono (o non vogliono come gli irlandesi) tassarli. La penosa fine della cosiddetta global minimum tax, faticosamente decisa in sede Ocse, è assolutamente paradigmatica. Perché l’opposizione che ha fatto naufragare il sistema fiscale internazionale è venuta sia dai democratici sia dai repubblicani americani in uno dei pochi dossier che li vede concordi. Il paradosso è che i governi delle società che hanno dato loro la possibilità di creare, investire e produrre - oltre a quella di arricchirsi quasi in esenzione fiscale - contano assai meno delle dittature. I miliardari del web scendono a più miti consigli quando dall’altra parte del tavolo vi sono degli autocrati. Con i politici dei loro Paesi, avendoli abbondantemente sostenuti e foraggiati, l’atteggiamento è diverso, il peso negoziale infinitamente maggiore. I Paesi autoritari dimostrano poi di usare spregiudicatamente la tecnologia, che negano come servizio ai propri cittadini, per avvelenare i pozzi delle opinioni pubbliche occidentali. E questo grazie alla tecnologia e alla condiscendenza di molti grandi gruppi digitali occidentali. Quasi il colmo.
L’illusione e l’ottimismo della volontà
Mi illudevo che i grandi del web (non tutti ovviamente, ci sono delle eccezioni) si facessero interpreti - dominando il mondo delle comunicazioni - dell’idea che il pluralismo dell’informazione sia la linfa vitale della cultura occidentale. E, ancora, che il grado di libertà d’espressione costituisca - come scriveva Giovanni Sartori, di cui celebriamo quest’anno il centenario dalla nascita - l’architrave di una democrazia rappresentativa. Mi sbagliavo, ma conservo l’ottimismo di fondo della mia antica analisi. Il buon giornalismo continuerà, nonostante il biblico passaggio dalla carta al digitale, la crisi profonda delle aziende editoriali, ad essere la penicillina delle società aperte e libere. La vitamina del progresso. L’antidoto agli estremismi di varia natura: religiosi e politici. Il barometro del buon senso nel rispetto dell’oggettività dei fatti che le opinioni, per quanto potenti, non dovrebbero avere l’avventura di piegare a proprio vantaggio. Il potere digitale delle piattaforme crea monopoli inquietanti ma l’accesso alla rete consente a tante piccole realtà informative di emergere con costi limitati e promettenti possibilità di successo. A differenza di quello che accade nel Novecento, la soglia d’ingresso di nuove testate nella infosfera è infinitamente più bassa. Si può fare molto di più.
Il grande sacrificio
Due fenomeni vanno analizzati con cura. Il primo riguarda il continuo appellarsi al Primo emendamento della Costituzione americana, da parte soprattutto di Elon Musk, nuovo proprietario di Twitter ribattezzata X. Il tycoon, che si avvia ad essere il più ricco al mondo, si arroga come proprietario di un grande social network, di fare il bello e il cattivo tempo. Ovvero di dettare non solo le regole d’ingaggio di chi partecipa alla sua piattaforma ma anche di garantire una libertà senza confini alle proprie idee e di quelli che la pensano come lui, tra cui Donald Trump. Anche a discapito della oggettività dei fatti. Come il Faust di Goethe è posseduto dall’orizzonte infinito dei suoi desideri che tende a sovrapporre a un concetto del bene del tutto particolare, Musk si appella alla libertà di parola della Costituzione americana, la cui interpretazione è stata fortunatamente piuttosto ampia nel corso del Novecento. Oggi ci si domanda, invece, se quel principio fondamentale della democrazia rappresentativa statunitense non debba proteggere di più e meglio il diritto dei cittadini a essere correttamente informati e a non diventare sudditi dei titolari delle piattaforme. I social network stentano ad assumere una responsabilità editoriale per i contenuti postati dagli iscritti che dovrebbero in teoria moderare. Solo l’Unione europea è stata in grado di approvare un insieme di norme, a protezione soprattutto della privacy, seguendo il concetto di harmful, ovvero di nocivo. Ma i grandi del web, quasi tutti americani o cinesi, sfuggono al fisco, figuriamoci se mai avranno, anche a fronte di multe stratosferiche, un sussulto di disciplina deontologica. Chi detiene le chiavi dell’innovazione crea nuovi mercati prima che il diritto tenti di regolarli. La velocità del cambiamento è tale da indurre nelle società alla frontiera dell’innovazione una sindrome di potenza che fa da contraltare all’affanno dei legislatori. Lo squilibrio contemporaneo è soprattutto questo: la dittatura dei grandi innovatori che hanno anche il vantaggio indescrivibile di essere profeti del loro tempo e dunque in qualche modo amati o temuti dal pubblico. Ma gli innovatori, nella sfida soprattutto con la Cina sono necessari ed è inevitabile che siano corteggiati e destinatari di privilegi.
Un’arma impropria
Il secondo aspetto che vale la pena di affrontare, e che un decennio fa avevamo totalmente trascurato, è rappresentato dalla capacità delle dittature, in particolare di cinesi e russi, di utilizzare le tecnologie digitali per «corrompere» il dibattito pubblico delle democrazie rappresentative. Un’arma impropria ma potentissima. Lo abbiamo visto durante la pandemia con l’incessante attività di anonimi Bot nello spargere falsità o mezze verità per turbare le opinioni pubbliche occidentali o addirittura di condizionare le campagne elettorali. Lo vediamo con le guerre in corso, in particolare sul fronte ucraino. Non solo. Il principale social network preferito dai giovani, di proprietà cinese, è stato formidabile per far vincere i leader populisti di destra. Jordan Bardella del Rassemblement national in Francia e Bijorn Hocke dell’Alternative für Deutschland in Germania, sono stati molto abili nello sfruttare le potenzialità di una piattaforma per giovanissimi, le cui chiavi algoritmiche sono tenute saldamente nelle mani del partito comunista cinese. Tra l’altro, una bella contraddizione storica e politica.