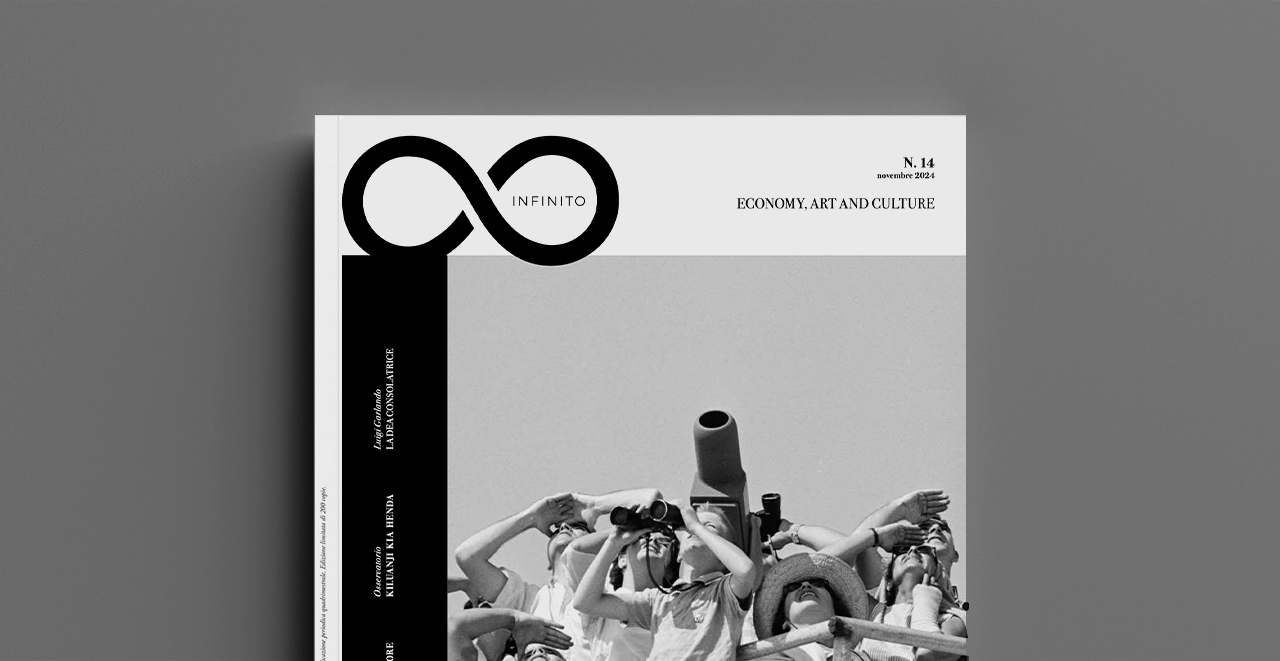Per una nuova lettura aggiornata del pezzo di Alberto Brambilla «iPhone, 10 anni so-stop» uscito per il numero I di Infinito nel novembre 2017. In quel contributo Brambilla raccontava tracciava una mappa delle materie prime utilizzando l’iPhone come atlante. A distanza di 7 anni come è evoluto lo scacchiere globale dei minerali e delle terre rare?
8,31 miliardi
«Spesso i nostri desideri sono così potenti che dimentichiamo i vortici di molecole che rendono possibile soddisfarli». Vale la pena citare subito questa frase di Leif Wenar, docente di filosofia e legge al King's College di Londra, già ricordata nel primo numero di questa rivista, per riprendere il filo del discorso. Dopo diciassette anni dal lancio del primo iPhone – introdotto sul mercato il 29 giugno 2007 a Cupertino – uno degli aspetti più sottovalutati riguarda la difficoltà di avere a disposizione le materie prime critiche necessarie a soddisfare una domanda crescente di beni di consumo. Soprattutto da quando nuove priorità globali come la decarbonizzazione e la digitalizzazione si sono affermate con maggiore forza sia dal punto di vista ambientale e politico, sia finanziario. Oggi il numero di telefoni cellulari utilizzati nel mondo è superiore a quello degli esseri umani viventi: su una popolazione mondiale di 8,08 miliardi di persone, sono in uso 8,31 miliardi di dispositivi, di cui poco più di un miliardo di feature phone, i telefoni senza funzioni smart diffusi maggiormente nei paesi in via di sviluppo. A possedere uno smartphone è solo il 60% della popolazione mondiale, ma la crescita è molto sostenuta: secondo i dati di Statista, nel 2017 gli utenti erano 1,66 miliardi, oggi sono 4,88 e nel 2019 potrebbero essere 6,38 miliardi (+30,73% in più in cinque anni).
Il petrolio del futuro
Contemporaneamente, negli anni successivi agli Accordi di Parigi abbiamo assistito a una spinta molto più risoluta da parte dei paesi industrializzati nella produzione di energia rinnovabile e nella mobilità elettrica, che ha sottratto risorse preziose al settore degli operatori di reti mobili. Si potrebbe pensare che non ci siano abbastanza molecole per soddisfare tutti i nostri desideri, ma l'impegno dei colossi dell'elettronica e di tutte le imprese coinvolte nella filiera è quello di individuare soluzioni per ottimizzare le risorse, soprattutto grazie all'innovazione dei processi industriali. Le batterie agli ioni di litio e i componenti elettronici sono le aree principali in cui le tecnologie degli smartphone e delle energie rinnovabili convergono. E se consideriamo i target fissati a livello mondiale per rendere sempre meno dipendente dalle fonti fossili l'energia che produciamo e consumiamo, si capisce perché ci si riferisca sempre più spesso alle materie prime critiche come al petrolio del futuro. Litio, cobalto, rame, nickel, terre rare e grafite sono necessari sia per la produzione di dispositivi elettronici sia per lo sviluppo di soluzioni per l'energia rinnovabile come le turbine eoliche, i pannelli solari e i sistemi di stoccaggio energetico, di cui tutto il mondo ha un crescente bisogno per contenere il riscaldamento globale. Secondo le stime più recenti, la domanda di queste componenti è destinata a triplicare entro il 2030. Le batterie agli ioni di litio, per esempio, sono essenziali sia per alimentare gli smartphone sia i sistemi di accumulo che servono per lo stoccaggio dell'energia e le auto elettriche. Solo per soddisfare la domanda prevista per gli ultimi due utilizzi, la richiesta di litio potrebbe aumentare di quasi il 90% nei prossimi due decenni. Anche materiali come il rame e le terre rare sono destinati a subire un aumento, che secondo la commissione economica per l'Europa delle Nazioni unite potrebbe arrivare al 40% prima del 2050. Le terre rare come neodimio, praseodimio, disprosio sono indispensabili non solo per gli smartphone e i veicoli elettrici, ma anche per le turbine eoliche, che necessitano di magneti ad alte prestazioni. Così come il rame, usato in abbondanza per i circuiti interni degli smartphone e nelle turbine eoliche, pannelli solari e infrastrutture di trasmissione energetica.
Il dragone avanza
C'è dunque una grande trasversalità di materiali tra la piccola scatola che abbiamo in tasca e le tecnologie che servono per produrre l'energia necessaria a ricaricala. E paradossalmente, oggi, il 14,28% delle persone nel mondo non potrebbe fisicamente possedere un telefono cellulare perché non potrebbe nemmeno ricaricarlo se ne fosse proprietario. Se l'offerta di minerali fosse abbondante e semplice da reperire, non ci sarebbe nessuna pressione sui prezzi e nessun bisogno di ottimizzare il loro utilizzo. Come sappiamo, invece, molte di queste materie prime provengono da un numero limitato di paesi, con la Cina che detiene il monopolio su alcune di queste risorse (come le terre rare), mentre il cobalto viene estratto principalmente nella Repubblica Democratica del Congo, dove la ricchezza mineraria si fonda sullo sfruttamento dei lavoratori nelle miniere, e il litio nel famoso triangolo composto da Cile, Argentina e Bolivia. Anche l'Afghanistan è una terra ricca di risorse minerali vergini, come si ricordava su queste colonne sette anni fa. Un memo interno del Pentagono parlava di Kabul come dell’«Arabia Saudita del litio», ma il controllo dei talebani sulla regione ormai consolidato dal 2021 rende impraticabile qualsiasi forma di collaborazione d'impresa. Non è un caso che l'unico paese capace di farsi avanti con un'offerta generosa per mettere le mani sulle miniere afghane sia la Cina, già ricca di risorse interne ma interessata ad ampliare la sua sfera di influenza. Soprattutto, gli affari che intessono le aziende cinesi si basano su accordi tra il regime di Pechino e quello talebano che non potrebbero essere replicate da altri governi democratici.
E gli USA pensano all’Australia
Un paese che intende giocare un ruolo chiave in questo risiko è l'Australia, che punta a fare da traino alla Minerals Security Partnership, un'alleanza multilaterale sulle materie prime critiche lanciata nel 2022 dagli Stati Uniti proprio per diversificare le catene di approvvigionamento dalla Cina. Canberra ha una solida tradizione nelle miniere di ferro e carbone, ma lo scorso anno il governo australiano ha presentato un piano di investimenti per potenziare l'estrazione dei minerali strategici: le riserve australiane di zinco, uranio e nichel sono tra le più vaste a livello globale e ancora più ricche sono quelle di litio, cobalto e tantalio. Preziosa è anche la miniera australiana dove si estraggono e lavorano concentrati di terre rare, l'unica presente in un paese occidentale.
Una indipendenza (im)possibile?
Ripercorrere questa mappa sotterranea sulle tracce del petrolio del futuro serve anche a comprendere meglio le iniziative più recenti di governi e industria. Negli ultimi due anni il blocco occidentale si è affrettato a cercare nuove alleanze nei settori più strategici e a considerare con maggiore attenzione le riserve domestiche. Dietro al tentativo di un approccio più coraggioso e risoluto non c'è solo l'obiettivo di un decoupling dalla Cina (ovvero l’allentamento dei rapporti commerciali e industriali con Pechino), ma più in generale un maggiore realismo imposto dalla crisi pandemica prima e dall'invasione dell'Ucraina poi, due eventi che hanno mostrato con durezza la fragilità degli equilibri geopolitici e delle supply chain globali. La parola «sicurezza» si è imposta nelle agende dei governi ed è diventata la bussola di molti ambiziosi piani d'azione. Una delle strade tracciate è quella del recupero delle componenti più sensibili attraverso il riciclo. Il vantaggio è quello di costruire un tassello di indipendenza commerciale dai paesi più ostili offrendo un'opportunità di sviluppo industriale. L'Unione europea sembra aver accolto questa sfida, anche per promuovere un'economia circolare che contribuisca a ridurre l'impatto ambientale dei consumi. L'importanza dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) quale fonte di materie prime critiche è stata anche ribadita dal Critical Raw Materials Act, con cui l'Unione europea punta a raggiungere una maggiore autonomia strategica. Uno degli obiettivi è soddisfare il 25% del fabbisogno annuo di materie prime critiche dal riciclo dei rifiuti entro il 2030. Ma la strada è ancora lunga. Mentre i volumi di Raee crescono ogni anno del 2%, la loro raccolta resta debole: su 10,4 milioni di tonnellate prodotte nel 2021, solo 5,6 milioni sono state raccolte per essere riciclate. Non va meglio negli Stati Uniti, dove non esiste una legge federale che ne regolamenti in modo uniforme il recupero dei rifiuti elettronici, con il risultato che le diverse leggi statali finiscono per creare un quadro lacunoso e poco organico.
iPhone ricicla sé stesso
In questo quadro, sono gli stessi colossi tecnologici a promuovere scelte consapevoli per i consumatori e comportamenti di filiera virtuosi. Non mancano i dovuti distinguo. Ma per tornare ad Apple e ai suoi iPhone, l'obiettivo finora raggiunto è quello di avere il 22% dei materiali riciclati nei nuovi prodotti, a partire da tungsteno, alluminio, cobalto, oro e litio. L'impegno verso una produzione a emissioni zero, il riciclo e il controllo sulla catena di approvvigionamento per garantire estrazioni di minerali pulite sono tutti aspetti che rispondono a logiche finanziarie prima ancora che commerciali, ma sono anche presupposti per restare competitivi dal punto di vista industriale. Nell'anno del lancio del primo iPhone, Greta Thunberg aveva quattro anni e il movimento Fridays for future non esisteva ancora. Quell'attivismo si è trasformato e ha cambiato forma e intensità, ma è innegabile che abbia contribuito a indirizzare il modello di sviluppo dei paesi più industrializzati. Nel frattempo, le piazze si sono riempite e poi svuotate, qualcuno ha boicottato gli aerei e preso di mira nemici più o meno colpevoli di inquinare, ma neppure Greta ha mai smesso di usare lo smartphone.