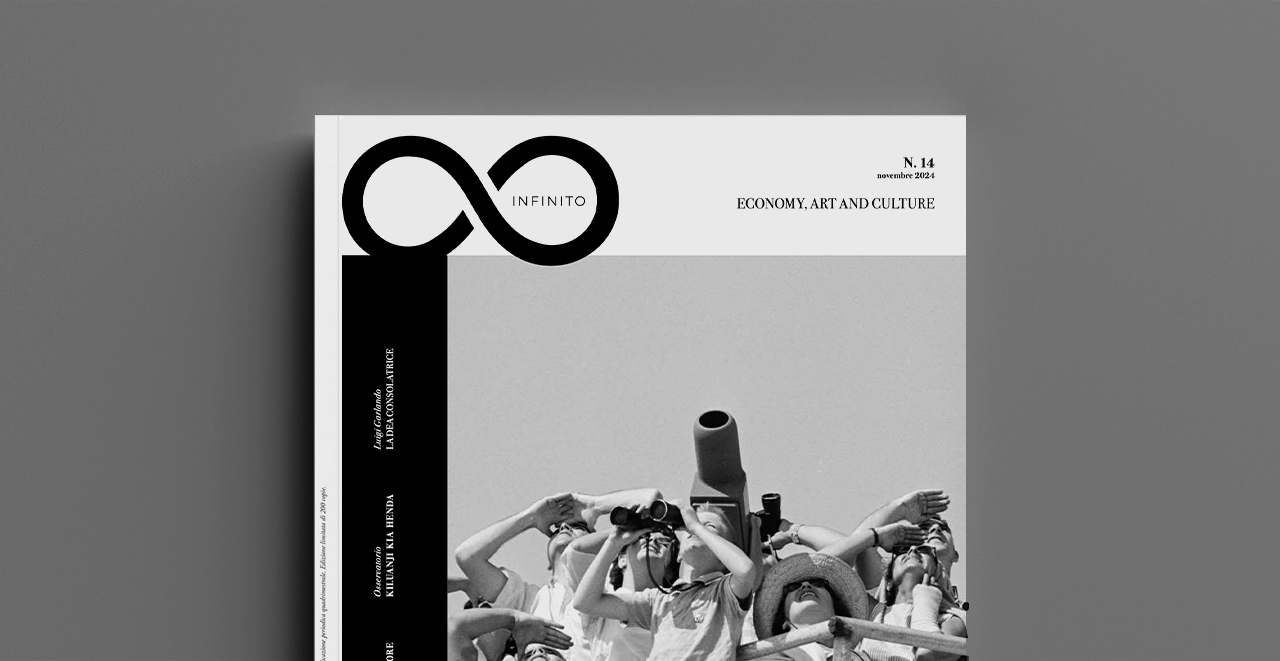Per una nuova lettura aggiornata del pezzo di Gianmaria Tammaro «Benvenuti nel futuro. Storia della televisione da quando mi ricordo a dopodomani» uscito per il numero III di Infinito nel luglio 2018. In quel contributo Tammaro ci illustrava un viaggio, quello dal divismo di Hollywood, per il tubo catodico, verso il futuro, quello delle piattaforme e della loro (in)finita possibilità di creare. E oggi? Cosa ne è stato di quelle opportunità?
Quasi nessuna delle previsioni che avevo fatto nel 2018, con il mio pezzo sulla televisione e sul futuro dell’intrattenimento, si è avverata. In sei anni, è successo di tutto. Le piattaforme streaming sono aumentate, altre hanno chiuso, altre ancora si sono trasformate. Netflix è passata dai 117 milioni di abbonati di allora ai quasi 270 milioni di oggi. Se c’era una guerra per il dominio del mercato dello streaming, l’ha vinta lei. Molte teorie sono tornate in auge, e sono state riprese, approfondite e in parte riviste. Il vero nemico della serialità non è il denaro, ma il tempo. Ed è quello che continua a diminuire. Le persone, bombardate come sono da nuovi contenuti, nuovi input, nuove immagini, devono decidere. La pirateria, paradossalmente, è tornata a crescere e a essere uno degli argomenti cardine della discussione – e questo non solo negli Stati Uniti ma pure in Italia. Le piattaforme che avevano promesso di portarci nel futuro con le loro produzioni sono rapidamente tornate sui loro passi e si sono fatte, se possibili, più tradizionaliste della televisione lineare – questo punto, invece, mi sembra di averlo preso.
Tutto cambia per non cambiare
Se guardiamo all’offerta italiana di Prime Video, è evidente che la linea editoriale sia stata ritagliata intorno a un’idea più classica di intrattenimento: le serie originali si contano sulle dita di una mano, e sempre più spesso vengono cancellate (l’ultimo caso, abbastanza eclatante, è quello di «Prisma», che aveva preso il testimone lasciato da «SKAM» e che l’aveva portato più avanti, immergendosi in un racconto ancora più realistico e attuale delle nuove generazioni). Sky continua a essere uno dei punti di riferimento più importanti del nostro mercato, e quest’anno, con la presentazione di «M. Il figlio del secolo» all’ultima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, ha dimostrato di tenere ancora molto al suo lato più innovativo e sperimentale: nella serie diretta da Joe Wright e interpretata da Luca Marinelli, si mischiano i linguaggi, le visioni e la storia – l’ascesa di Benito Mussolini e del fascismo, già ripercorsa dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati diventa qualcosa di più di un banale spunto narrativo.
La scrittura rimane centrale: nel caso di «M.», la sceneggiatura è firmata da Stefano Bises, uno dei grandi nomi della serialità televisiva italiana, e da Davide Serino. E la libertà che Sky e i produttori hanno deciso di concedere alla squadra creativa è un sintomo evidente di un fenomeno ancora più ampio: se si vuole, c’è ancora spazio per poter sperimentare. Ma Sky è un’eccezione, non la regola. Soprattutto in Italia. Sotto questo punto di vista, Netflix ha frenato. Nell’analisi di sei anni fa, citavo l’accordo epocale con Shonda Rhimes e Ryan Murphy. Nel corso del tempo ne sono stati siglati altri, e quello con Murphy è in scadenza. Ma trovare prodotti realmente rivoluzionari, sia nell’impostazione creativa che produttiva, si è trasformata in una vera e propria sfida. E non possiamo dimenticare, poi, la pandemia: durante quel periodo, c’è stata un’ulteriore spinta di investimenti e di risorse, soprattutto nella serialità.
L’impatto della pandemia sul piccolo schermo e il passaggio dai fumetti ai videogiochi
Tutti erano a casa ed è sembrato ovvio, ai grandi network, spendere ogni risorsa nello sviluppo rapido e nella distribuzione di nuovi titoli. Così facendo, però, il mercato è stato profondamente viziato e i costi di produzione sono arrivati a vette incredibili. E ancora oggi si fa fatica a tornare a budget pre-pandemia. Insomma, la rivoluzione dello streaming, della novità, del tutto ora e subito, dove vuoi, quando vuoi, su qualunque device, è finita. E più che da un punto di vista puramente industriale, questa rivoluzione è finita editorialmente. La serialità è diventata l’ennesima cosa in cui poter investire, l’ennesimo settore in cui esserci per farsi notare più che per fare la differenza, e qualunque valore culturalmente arricchente è stato messo da parte.
Dopo l’epoca dei fumetti, che hanno invaso anche il piccolo schermo, è cominciata l’epoca dei videogiochi: «The Last of Us», prodotta da Hbo e distribuita in Italia da Sky, ne è un chiarissimo esempio. Più compatta e con un numero di episodi limitati, rappresenta il punto di contatto tra due linguaggi che non solo possono comunicare, ma che anzi ne hanno quasi una necessità fisiologica. Su Prime Video, invece, è arrivata Fallout, storia post-apocalittica che ha registrato ottime visualizzazioni per la piattaforma. E in cantiere ce ne sono tante altre di serie come queste. E presto anche il cinema avrà la sua buona dose di film tratti dai videogiochi. La benzina più preziosa, quella che tutti vogliono, è sempre la stessa: le idee. Non basta avere i soldi per controllare il mercato; servono le storie. E le storie, dopo sei anni passati a produrre la qualunque, a rimpinzare l’archivio di qualunque piattaforma, sono in crisi: ce ne sono, certo, ma non possono minimamente rivaleggiare con «I Soprano» o «The Wire», i due titoli da cui, in un certo senso, è partito tutto (e a proposito de «I Soprano»: Hbo ha prodotto un bellissimo documentario su David Chase, il suo creatore, che si offre come una riflessione estremamente interessante e attuale sui meccanismi creativi e artistici).
Che fine ha fatto il genere?
La serie tv ispirata a Il signore degli anelli di J. R. R. Tolkien, «The Rings of Power», è arrivata ed è stata accolta duramente non solo dagli appassionati della saga ma pure dagli spettatori abbonati a Prime Video. Parallelamente, su Hbo, l’universo narrativo creato da George R. R. Martin, lo scrittore de «Le cronache del ghiaccio e del fuoco», continua ad allargarsi: dopo «Game of Thrones» è stata distribuita «House of the Dragon», e prossimamente sarà la volta di «A Knight of the Seven Kingdoms». Il budget di «Game of Thrones», che una volta sembrava così incredibile e pressoché impossibile da raggiungere, oggi è (quasi) la normalità. Ripeto: si spende tanto, in televisione; non c’è nessuna crisi del mezzo. La presenza di tante piattaforme, però, ha portato all’ennesima frammentazione del pubblico. Anche Hbo ha la sua piattaforma ora: Max. C’è stata un’altra fusione, quella tra Warner Bros. e Discovery, e molti progetti o sono stati archiviati definitivamente o sono in attesa – sì, ancora oggi – di conoscere il proprio destino. La prossima big thing è la serie che verrà girata tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo su Harry Potter: nuovi attori, nuova squadra creativa, e una struttura narrativa molto più vicina a quella originale della saga letteraria. I grandi autori hanno perso qualunque interesse, almeno qui in Italia, per la televisione. Paolo Sorrentino, che ha firmato «The Young Pope» e «The New Pope», è tornato sul grande schermo. E dopo una parentesi con Netflix, che ha distribuito il suo penultimo film, «È stata la mano di Dio», ha completamente riabbracciato l’esperienza fisica della sala. Come fu per «Gomorra – La Serie», anche altre serie tv, in questi anni, hanno avuto un passaggio al cinema. Due degli ultimi esempi portano nuovamente la firma di Sky, e sono «L’arte della gioia» di Valeria Golino e «Dostoevskij» dei fratelli D’Innocenzo: sono stati proiettati nella loro interezza, dopo essere stati divisi in due parti, e hanno ottenuto risultati contrastanti (dipendeva molto dalla sala in cui venivano distribuiti e, soprattutto, dal periodo).
Su Prime Video è arrivata «The Bad Guy», diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana e scritta da Ludovica Rampoldi, Davide Serino (sì, lo sceneggiatore di «M. Il figlio del secolo») e dallo stesso Stasi. Forse è stato uno degli ultimi, grandi esperimenti di genere di una piattaforma puramente streaming (quindi senza la controparte lineare). Paramount+, che ha aperto anche in Italia, ha dovuto velocemente rivedere i propri conti e limitarsi, diciamo così, a distribuire titoli stranieri – ne ha prodotto qualcuno, come «Vita da Carlo» di Carlo Verdone, che dopo la fine della prima stagione ha dovuto cambiare casa, ma ne ha anche dovuto rivendere altri. Chi, nel mondo, continua seriamente a provare a sperimentare e a mettersi alla prova è Apple tv+.
La grande mela della tv
Sì, in questi sei anni anche Apple si è allargata al mondo dell’intrattenimento (e, in particolare, alla serialità). E così com’era successo a Prime Video, quando era forte dei soldi e degli investimenti della casa madre, Amazon, sta ancora approfittando del momento della novità: spende tanto e in progetti tra loro diversissimi – contrariamente ai suoi competitor, ha cominciato abbastanza presto a cancellare le serie che non rispondevano alle sue aspettative, ma l’essere fondamentalmente una compagnia che si occupa di altro le ha dato modo di approcciare l’audiovisivo da una prospettiva diversa: investire per creare la cosa migliore possibile e non per accontentarsi. Serie come «Slow Horses», «Pachinko» e «Severance» rappresentano, in questo momento, l’apice della piramide alimentare del piccolo schermo.
L’animazione, la nuova El Dorado della serialità
Se c’è una tendenza vera, che andrebbe presa e analizzata singolarmente, è quella dell’animazione. Alcuni dei più grandi successi di questi anni, tra streaming e televisione lineare, sono prodotti animati. «Arcane,» «Rick and Morty» e anche le serie italiane di Zerocalcare, «Strappare lungo i bordi» e «Questo mondo non mi renderà cattivo», hanno ribadito quanto questo linguaggio sia più immediato e universale rispetto al live action. E mentre tutti i network e le major cercavano di sviluppare una piattaforma streaming generalista, per contenuti e offerta, Sony ha avuto l’intuizione di investire in «Crunchyroll», che oggi è uno dei portali più importanti per quanto riguarda l’animazione giapponese. Per riprendere il discorso che facevo poco fa, anche queste serie (specialmente queste serie) hanno una distribuzione cinematografica: sono eventi limitati, per carità, eppure resta evidente l’interesse nel provare a convertire un pubblico profondamente e sostanzialmente televisivo in un pubblico cinematografico. E questo perché, nella verticalità dell’animazione, ci sono una fidelizzazione e una capillarità maggiore tra gi spettatori – in quanto appassionati, sono pronti a spendere cifre rilevanti per vedere sul grande schermo una serie che, poi, potranno vedere dopo qualche mese in streaming, seduti comodamente a casa. Grazie all’animazione, gli equilibri mondiali si sono leggermente spostati: ora uno dei mercati più importanti, per quanto riguarda la supervisione e la produzione di serie e film, è il Giappone. E non sono poche le operazioni, di network e canali occidentali, che provano a sfruttare un certo stile o una certa impostazione tecnica.
Che futuro ci aspetta?
Parlare oggi di serialità significa prepararsi a fare costantemente avanti e indietro tra la propria realtà, con i propri riferimenti e le proprie risorse, e i mercati stranieri. Lo streaming ha mostrato chiaramente quanto sia facile e immediata una distribuzione su larga scala attraverso internet. I tempi si sono dimezzati. E non è più così raro trovare una serie solo in lingua originale con i sottotitoli italiano: l’industria del doppiaggio non riesce, pur volendo, a stare al passo con tutte le nuove uscite (in questi sei anni, c’è stata anche una grossa polemica sul doppiaggio e l’adattamento della serie anime «Evangelion», distribuita da Netflix, che è stata costretta a tornare sui suoi passi e a commissionarne di nuovi). Queste continue compressioni e dilatazioni hanno portato a una rottura dei piani e delle strategie a lungo termine dei network e delle piattaforme streaming. C’è il tentativo di riorganizzarsi e di unire le forze – non solo dal punto di vista economico ma pure, e forse soprattutto, dal punto di vista strutturale ed organizzativo. Quello che dicevo sei anni fa, e cioè che non si può chiedere allo spettatore di iscriversi a così tante piattaforme, sottoscrivendo abbonamenti che hanno un valore di diverse centinaia di euro ogni anno, è sempre più evidente. Non sono stati sviluppati dei portali ibridi dover poter ottenere i servizi delle varie piattaforme pagando un unico abbonamento, ma si sono create delle dinamiche precise che hanno portato alla fusione di gruppi più grandi e internazionali (ho citato poco fa quella tra Warner Bros. e Discovery; presto ce ne saranno altre). Lo streaming, oggi, non è più un elemento estraneo o da guardare con diffidenza; fa parte dell’industria audiovisiva, ed è così anche in Italia. Se è vero che i soldi e gli investimenti sembrano essere aumentati, o almeno sembrano aver raggiunto un altro standard rispetto al passato, è pure vero che la fatica nello sviluppare storie nuove e originali è diventata quasi insostenibile.
Per questo, più che provare a crescere, le piattaforme stanno provando a mantenere stabili i loro abbonati e a non perderli, e per farlo sono disposte a scendere a compromessi e a ritrattare le promesse che avevano fatto durante il loro lancio e il loro periodo di affermazione: si ritorna a un’offerta più generalista, meno variegata, pensata per un pubblico più ampio e non per verticalità distinte. E non c’entra, come pure a volte si prova a dire, il «politicamente corretto». I tempi sono cambiati ed è cambiata la sensibilità media degli spettatori. Ma l’appiattimento generale dell’offerta ci dice un’altra cosa, una cosa totalmente differente: la rivoluzione è finita.