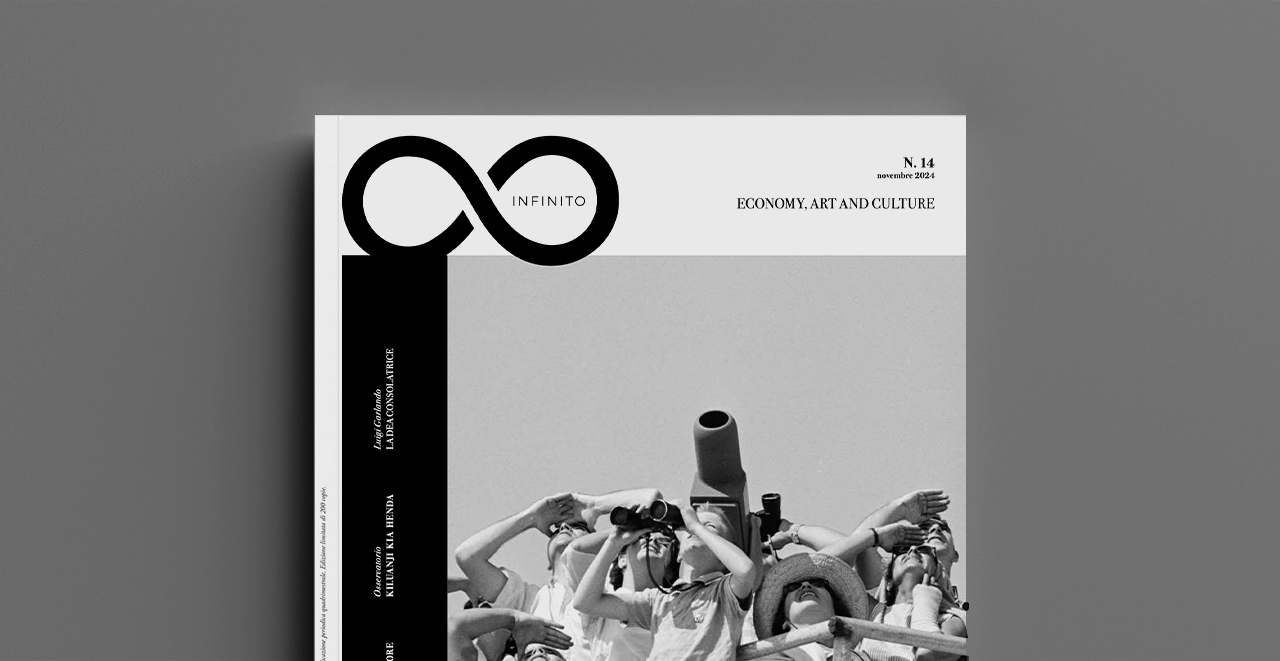Per una nuova lettura aggiornata del pezzo di Fabiana Giacomotti «L’Italia della moda» uscito per il numero VII di Infinito nel novembre 2019. In quel contributo Giacomotti ci portava nella nuova Italia del fashion. Da Xu Qiulin (in arte Giulini) di Prato all’argentino Burlon, creatore di “County of Milan” il Bel Paese sembrava una palestra inimitabile per la moda. È ancora così oggi? È questa la domanda a cui risponde Fabiana Giacomotti in questo Infinito XIV.
Il vero volto
Vorrei poter scrivere che è colpa del Covid, ma non è così. L’infernale tsunami pandemico del biennio 2020-2021, che nella filiera della moda italiana sta mostrando adesso i propri effetti a lungo termine nella forma più evidente di un’esposizione finanziaria importante con lo Stato, rappresenta infatti solo un aspetto del profondo cambiamento in atto in un sistema che solo un lustro fa definivo su queste pagine come una land of opportunities. Fino a cinque anni fa, e benché fosse già terra di conquista di molti gruppi stranieri, l’Italia era infatti un piccolo Eldorado per i giovani stilisti, italiani e stranieri, a caccia di opportunità per mettersi alla prova, per sperimentare le proprie capacità, per iniziare a costruire la propria carriera presso le moltissime aziende, piccole e grandi, di façon o di brand, di cui la penisola è disseminata. Lo è ancora, per il momento. Ma lo è in parte, lo è sempre meno, lo è con difficoltà. La moda italiana ha dovuto rallentare l’ingaggio di giovani stilisti e la sperimentazione, per focalizzarsi sulla ricerca dei giovani artigiani e di una modalità produttiva che possa permetterle di restare competitiva in un settore che va mostrando i limiti del rapporto troppo stretto con la finanza e il marketing, crescendo a dismisura e distorcendo i fondamentali: per troppo tempo, infatti, i marchi hanno scommesso sul valore del brand stesso, spacciando per qualità quello che non lo era, e massimizzando gli utili con una delocalizzazione senza freni, che smentiva le premesse e soprattutto le promesse di vendita e di valore. Al contempo, i clienti mondiali di oggi, soprattutto i più giovani, hanno acquisito competenze sufficienti a calcolare il valore dei beni che acquistano; spannometricamente ma con una certa precisione perfino sui multipli accettabili, e a percepire le differenze fra il capo o l’accessorio acquistato oggi e lo stesso capo realizzato con le tecniche di un tempo. Questa nuova competenza non è dovuta affatto a una coscienza acquisita in famiglia, la generazione dei genitori di oggi è, anzi, tuttora la più esposta e permeabile alla seduzione della marca, ma a una frequentazione sempre più attenta dei negozi e delle piattaforme vintage verso i quali, questi giovani e giovanissimi sono stati spinti sia da una maggiore coscienza ecologica, sia da una disponibilità economica ridotta e relativa.
Il mondo non basta
A poco a poco, il mondo sta riacquisendo la competenza in materia di tessuti, pellami, taglio, manifattura che era patrimonio comune fino a tre generazioni fa. Ogni giorno ci viene dimostrato che il «revenge shopping» post-pandemico, sostenuto da un biennio di risparmi, è durato meno di quanto i brand si aspettassero, e che la scelta di rivedere verso l’alto del 20 o 30% all’anno i costi degli accessori più ricercati, puntando sulla sola clientela affluente, ha eliminato del tutto dall’accesso al lusso la fascia media del pubblico che, pure impoverita, avrebbe potuto continuare a desiderare almeno una borsa nuova all’anno e che ora non può più permettersi nemmeno quella. Concentrare ogni strategia sui super-ricchi dunque non ha pagato come atteso, e non è detto che lo farà in futuro: credere che, oltre alla ripresa del Giappone, paesi a benessere crescente come la Thailandia, o le Filippine, o l’India della quale sento parlare da almeno vent’anni ma che non diventerà mai l’Eldorado della moda a causa delle forti divisioni sociali, vorranno acquistare esclusivamente brand occidentali, è una pia illusione (la moda, per crescere, ha bisogno di fluidità e di mobilità sociale, non di un rigido sistema di caste, la storia occidentale insegna: abbiamo iniziato a crescere quando si è affermata la borghesia e sono saltate le leggi suntuarie). I cento milioni di nuovi super-abbienti che tutte le analisi di settore danno per sicuri nei prossimi cinque anni rappresentano certamente una bella speranza, che però non basta a compensare il presente, in decrescita del 4% nelle analisi più misericordiose: essere convinti che i ricchi vogliano riempirsi i guardaroba di borse e scarpe, senza magari destinare tempo e denaro a viaggi, arte, beneficenza, è la seconda di queste illusioni che rischia di essere disattesa dalla realtà. Uno degli altri fattori limitanti è di ordine psicologico: sulla moda, secondo fattore di inquinamento mondiale, inizia ad aleggiare uno stigma ecologico-sociale che spinge molti, giovani soprattutto, a rivolgersi al mercato del vintage, lo stesso che sta insegnando loro a distinguere la qualità vera da quella percepita, e molti altri a sfoggiare con orgoglio gli abiti e gli accessori della mamma o della nonna, talvolta rigenerati e talvolta nemmeno.
Per un’opera d’arte o per noi stessi
«Suscitare nuovamente il desiderio», «tornare desiderabili», è stato il grande mantra delle sfilate primavera-estate 2025, a New York, Milano e Parigi. Però, mentre il foltissimo pubblico dei modaioli continua a viaggiare da una sfilata e da un cocktail all’altro, inebriato dal proprio piccolo privilegio e ostinatamente cieco nei riguardi dell’evoluzione in corso, sembra sempre più evidente il cambio dei desideri del pubblico: una dinamica testimoniata dai dati relativi ai viaggi, sold out già adesso tutte le mete più desiderabili per Natale, e dal grande successo della cosmetica e della profumeria, per la prima volta entrata a far parte delle analisi del comparto moda-abbigliamento, forse per mitigarne le performance negative. I dati diffusi nel corso della Beauty Week milanese di fine settembre, che è seguita a quella della moda, parlano di un comparto in grande espansione, grazie alla maggiore attenzione per sé, per il proprio benessere, seguito allo choc pandemico: nel 2023, il fatturato totale del settore cosmetico italiano ha superato i 15,1 miliardi di euro, in crescita del 13,8% rispetto al 2022, e sono positive anche le stime per il 2024 che vedono il giro di affari oltrepassare i 16,6 miliardi di euro, in crescita del 9,8% sul 2023. In sintesi: si preferisce affollare le spa, le palestre e i percorsi wellness al posto delle boutique. Questo spiega anche il clamoroso boom di fatturato, una vertiginosa crescita del 75% di Miu Miu nell’ultimo anno: nei paesi più toccati dal Covid, a partire dalla Cina, il brand del gruppo Prada ha proposto infatti linee specifiche per questa nuova esigenza, superando sia la refrattarietà del pubblico nei riguardi di nuovi acquisti, sia la stretta del governo di Beijing nei confronti dell’acquisto di beni occidentali. Gli analisti più accreditati, come Erika Andreetta di PwC, sono convinti che segmenti quali l’athleisure resteranno una delle grandi tendenze di questi anni, insieme con il desiderio per il capo eccezionale, unico, da collezionare come fosse un’opera d’arte. A questa fascia di connaisseur, che frequentano le sfilate come gallerie d’arte, sono rivolte le proposte di Schiaparelli, di Loewe, di Courrèges, del nuovo astro nascente Duran Lantink, premiato di recente da Lvmh.
Esiste un futuro del Made in Italy?
Ma, mentre fra i grandi gruppi infuria la battaglia per mettere sotto contratto le celebrities, fotografarle in prima fila, stringere con loro collaborazioni, partnership, testimonianze pubblicitarie, una strategia che avvicina sempre di più la moda all’entertainment e della quale è prova diretta ed evidente la creazione da parte della famiglia Arnault di una casa di produzione cinematografica così come l’acquisizione della totalità delle azioni del settimanale «Paris Match», è chiaro che per la moda italiana, cioè per la vastissima compagine di piccole e piccolissime aziende cresciute negli ultimi quaranta-cinquanta anni come façoniste sull’onda di una domanda sempre crescente, ma mai davvero specializzate, mai capaci o lungimiranti abbastanza per investire su un proprio marchio o dotarsi di un management all’altezza, sia suonato il redde rationem. Se il governo Meloni, assediato da più tavoli di crisi di quanti possa reggerne, a fronte di un calo produttivo che in settori come la pelletteria supera il 18%, pensa a un piano di salvataggio per i nomi più rilevanti, più strategici, forse anche più meritevoli (che è sempre una valutazione difficile e per la quale ci vorranno competenze specifiche,) è evidente che vada ripensato questo sistema produttivo, nato anche molto spontaneamente, nei piccoli appartamenti e nei casali di campagna, a cavallo e subito dopo le due guerre mondiali e da allora mai davvero aggiornato. È arrivato il momento di mettere mano ai distretti, fra quelle decine di migliaia di piccole aziende che in questi anni, e nei casi migliori, sono state fatte oggetto di molte attenzioni da parte dei grandi gruppi. La verità che nessuno vuole raccontare è che nel giro di pochi anni, il famoso Made in Italy della filiera, le manifatture specializzate, saranno entrate a far parte dei grandi gruppi, sperabilmente italiani come Zegna o Prada che già ne hanno acquisite molte, ma è più probabile straniere, mentre tantissime altre, che avevano raggiunto una certa o anche una discretissima prosperità (talvolta grazie anche a speciali incentivi fiscali sulla lavorazione, vedi il calzaturiero della gomma nelle Marche), dovranno rassegnarsi a cambiare, ad accorparsi o a chiudere. C’è ancora tempo per intervenire, purché se ne abbia la voglia e la volontà. Ma è chiaro che, oltre le star in passerella, il perimetro della moda vada restringendosi, e che i debiti aumentino anche per nomi insospettabili.