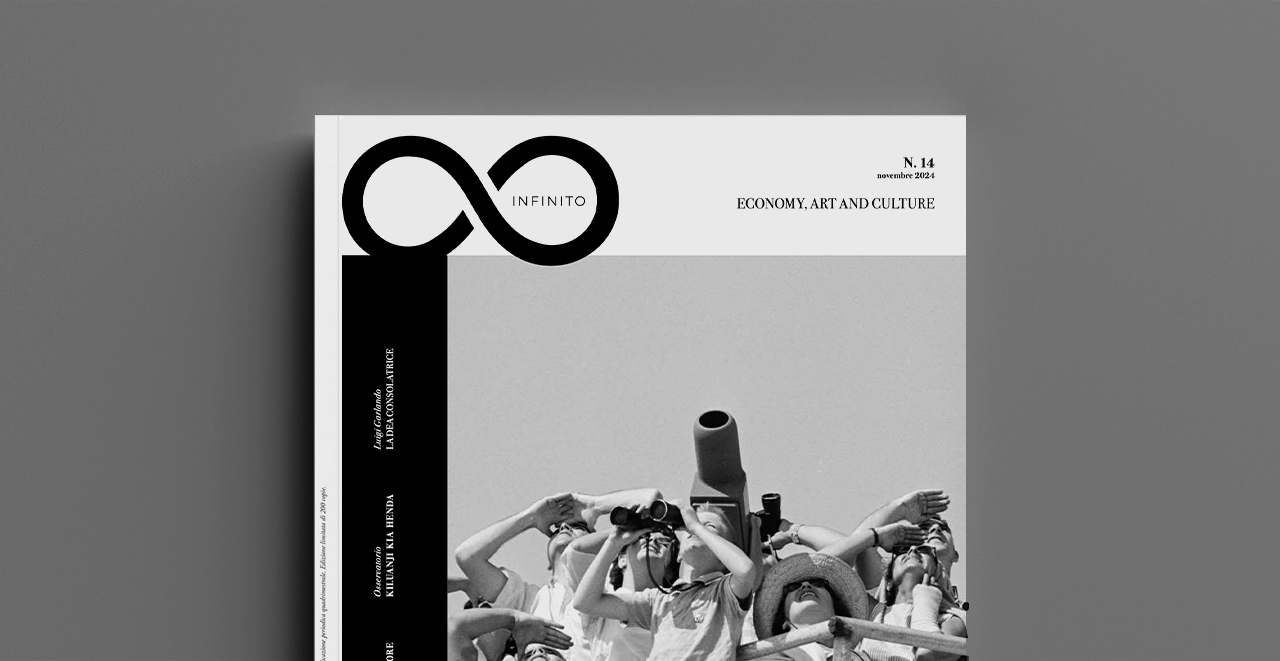Per una nuova lettura aggiornata del pezzo di Infinito «La Gioconda con l’hijab», con intervista allo storico e studioso di Leonardo Da Vinci Pietro Marani, uscito per il numero VI di Infinito nel luglio 2019. L’articolo traccia la storia dello scontro per l’egemonia culturale dell’area, dove il Qatar già dal 2007 (anno dell’accordo con il Louvre che porterà all’apertura del Louvre di Abu Dhabi concepito da Jean Nouvel nel novembre 2017) ha iniziato a costruire un costoso doppio binario culturale tra arte occidentale e tradizioni locali, passando per i Mondiali di calcio del 2022. Ma il Qatar, leggiamo nell’articolo, non è l’unica potenza a muoversi: l’acquisto da parte di Mohammed bin Salman del Salvator Mundi di Leonardo Da Vinci per 450 milioni di dollari segna un punto nelle strategie a ambizioni culturali saudite. L’articolo, poi, ripercorre la storia del dipinto con le parole di uno dei più grandi esperti di Leonardo al mondo, Pietro Marani, che ebbe il privilegio di vederlo nel 2009 e approfondirlo poi nel 2011 e che confermerà ad Infinito che «È, infatti, la qualità della materia a rendere uniche le sue opere. Il suo modo di stendere i pigmenti. La pittura di Leonardo è fatta di niente. La materia appoggiata alla superficie dalle pennellate è talmente leggera da scomparire e definire al tempo stesso. Mi riferisco qui alla qualità delle parti buone, ovvero tutto ciò che sta intorno alla testa – dove invece gli interventi successivi hanno compromesso definitivamente l'originale, di cui non resta niente. Sono di Da Vinci le mani, tutte e due, alcuni riccioli, il globo di cristallo di rocca, fatto di nulla, appunto, con qui frammenti vegetali al suo interno, e i panneggi. Quindi sì, avvallo l'attribuzione: in origine, era un buon Leonardo, adesso rimasto in condizione frammentaria, in parte manchevole».
Qatar e Arabia Saudita: le scommesse di Usa e Cina dopo il 7 ottobre
Nulla di nuovo sotto il sole. Il calcio non è solo calcio e Damien Hirst non è solo arte. In un quadro decisamente complesso come quello che ci viene offerto in questo 2024, dopo la strage del 7 ottobre 2023 ad opera di Hamas con l’operazione di morte denominata «alluvione Al-Aqsa», molti degli occhi del mondo geopolitico sono rivolti a due attori del Golfo che hanno di recente trovato una nuova armonia in cui coesistere, Qatar e Arabia Saudita. I rapporti tra i due paesi, dopo la pesante crisi del 2017-2021, vivono oggi una sinergia sulla quale si innesca la sfida a distanza tra gli Stati Uniti e la Cina e le reciproche scommesse in campo di politica estera tra l’amministrazione Biden e Xi. In un quadro generale che vede le due potenze interessate a creare un solido periodo di pace nella regione, appaiono piuttosto divergenti le modalità e le strategie messe in campo per raggiungerlo. Da un lato Washington, che ha fin qui cercato di rafforzare i suoi legami con Israele e le monarchie del Golfo, con l’obiettivo di avviare un progressivo disgelo tra Tel Aviv e Riyad. Dall’altro Pechino, che scommette tutto sulla mediazione tra Iran e Arabia Saudita, e punta sul rinnovato rapporto tra Xi Jinping e Mohammed bin Salman (Mbs). Risulta difficile oggi immaginare quale delle due strategie pagherà i migliori dividendi, considerando le imminenti elezioni americane, e soprattutto l’evoluzione del conflitto nella striscia di Gaza che prosegue nella sua ineludibile traiettoria di coinvolgimento attivo di altri stati. In tutto questo c’è poi il Qatar, che ha l’onere di essere uno dei più credibili negoziatori del conflitto, posizione scomoda e rischiosa dall’alta posta, nonché circostanza destinata a legarlo a tempo indeterminato agli Stati Uniti. La monarchia della famiglia Al Thani è, infatti, una pedina fondamentale per Washington nel Medio Oriente, resa più autorevole dal progressivo spostamento di peso di Joe Biden rispetto al mandato Trump, che aveva visto il presidente repubblicano creare un feeling diretto con Mohammed bin Salman. Pur rimanendo i Sauditi, infatti, il principale alleato di Washington in Medio Oriente, è innegabile come la Casa Bianca abbia iniziato a vedere in Al Thani una affidabile controparte anche nel braccio di ferro con Pechino, schierata, appunto, con l’Iran, e impegnata nel tentativo di attrarre in questa sfera di interesse gli altalenanti Sauditi. Così, se da una parte, sul piano internazionale, il Qatar continua a svolgere il ruolo del mediatore tra Israele e Hamas, dall’altro Doha ha stretto rinnovati legami economici con l’Arabia Saudita e ha portato l’emiro a compiere recentemente visite di stato senza precedenti nel Mediterraneo orientale (Cipro e Grecia) e in Asia (Filippine, Bangladesh e Nepal). L’emirato ha ora lo sguardo rivolto alla crescita dell’economia, coniugando lo sviluppo di nuove risorse energetiche (North Field West) ai settori più innovativi individuati dalla nuova National Development Strategy per la diversificazione delle entrate governative.
«Molti analisti prevedono che nel medio periodo (2026-30) l’economia del Qatar dovrebbe crescere del 4,4% circa, soprattutto a causa dell’export di gas naturale liquefatto (Gnl). Doha sta infatti pianificando il rafforzamento dell’industria gasiera, con l’obiettivo di aumentare estrazione ed esportazione, per consolidarsi ai vertici del mercato mondiale di Gnl. […] Parallelamente al settore energetico, il Qatar continua a investire nello sviluppo del settore non oil&gas, ovvero nell’economia non legata agli idrocarburi. Nel gennaio 2024 Doha ha lanciato la terza fase della National Development Strategy, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi della Vision 2030 qatarina cominciata nel 2008. Il target è arrivare al 4% di crescita annua entro il 2030 coniugando energia e altri settori economici. […] Sono molti i settori economici al centro della strategia di crescita di Doha: turismo e logistica, agricoltura e food, salute e istruzione, manifattura (petrolchimica), nuove tecnologie e servizi finanziari, digitalizzazione. Tra questi, la logistica è già un’affermata realtà: il Qatar –si legge nella National Development Strategy – intende ora rafforzare la sua posizione di hub globale, puntando sul trasporto aereo e la distribuzione dei prodotti di e-commerce. Già nella prima metà del 2023 più di venti milioni di passeggeri sono transitati dall’aeroporto internazionale Hamad di Doha. Inoltre, i sistemi di gestione delle infrastrutture portuali saranno poi ulteriormente digitalizzati, un percorso acceleratosi nella fase iniziale della pandemia da Covid-19. […] Nel corso della quarta edizione del Qatar Economic Forum 2024, avvenuta tra il 14 e il 16 maggio, il governo qatarino ha messo al centro i progressi del paese in tema di trasformazione digitale, anche attraverso l’innovazione e lo sviluppo di tecnologie e intelligenza artificiale, cui l’esecutivo ha destinato un cospicuo pacchetto di incentivi statali. Settori che non appartengono alla tradizionale economia dell’emirato, ma sui quali il governo vuole puntare anche per creare occupazione per i cittadini qatarini – che fino a ora hanno privilegiato l’impiego pubblico – nel quadro delle politiche di nazionalizzazione del lavoro comuni a tutte le monarchie del Golfo. Nel prossimo decennio, si prevede che più di 50.000 cittadini qatarini entreranno a far parte della forza lavoro e il settore pubblico non sarà più in grado di assorbirli».[1]
L’arte conta di più: i due modelli di Qatar e Arabia Saudita
Nello scacchiere geopolitico entrano poi altri comparti delle società umane, spesso destinati a rappresentare viatici molto solidi verso nuovi scenari. L’arte è uno di questi. Infatti, dopo gli straordinari mondiali di calcio del 2022, che hanno visto sollevare la coppa in albiceleste all’erede designato di Maradona, Lionel Messi, quello che rimane è la sfida all’egemonia culturale della regione sull’asse Doha-Riyad. Da una parte la famiglia Al Thani ha da tempo pianificato il proprio ingresso sul palcoscenico della cultura contemporanea, costruendo una sorta di doppio binario parallelo tra arte occidentale e tradizioni locali. Oggi Doha è infatti un interlocutore credibile, solido e riconosciuto nel contesto della comunità scientifica europea ed americana. Non sono solo gli accordi con i giganti dell’arte del vecchio continente, come quello con il Louvre, o lo shopping di opere d’arte (spesso di necessaria e legittima secondaria bellezza) intrapreso da Sheikha Mayassa Al Thani per riempire la rosa del deserto di Jean Nouvel, e arricchito dalle laute commissioni a blue-chip artists occidentali per opere spesso dimensionalmente impressionanti, ma è il reticolo di relazioni che ormai si è costituito tra la famiglia reale in persona e le figure chiave della cultura contemporanea occidentale, tra direttori di musei, ministri e collezionisti di fama. Ne sono esempi pratici la firma del protocollo di cooperazione tra il Qatar e la città di Venezia, annunciato lo scorso mese di giugno 2024 in piena Biennale di Venezia Arte. L’intesa è volta a migliorare la collaborazione nei settori culturale e socioeconomico, le condizioni di conoscenza e incoraggiare reciprocamente gli investimenti economici, in particolare nei settori dell'arte, della conservazione, della sostenibilità, dello sport e dell'intrattenimento. L'accordo venne annunciato il giorno in cui Qatar Airways ha ripreso il servizio diretto tra Doha, l'hub internazionale per l'Asia, l'Africa e l'Oceania, e l'aeroporto Marco Polo di Venezia, e prevede la donazione di 50 milioni di euro al Comune «per soddisfare le pressanti esigenze della Città nella gestione di un patrimonio unico ed estremamente complesso, che trascende i confini e rappresenta un tesoro per l'umanità». Così come i rumors sempre più insistenti che vedrebbero la famiglia Al Thani portare in una città italiana la loro fondazione dedicata agli studi arabi. Sulla strada del Qatar però, da qualche anno, c’è Mbs. L’Arabia Saudita ha tratto il proprio dato con l’acquisto del Salvator Mundi nel 2017, 450 milioni di euro per un’opera che dall’asta di Christie’s è sparita nel nulla in attesa di un museo a Riyad che la conterrà. Da quella data, tuttavia, il dado ha continuato a correre. Mbs ha deciso di rilanciare nel calcio, dove dopo i mondiali targati Qatar, arriveranno quelli marchiati Riyad 2034, corredati dalla crescita esponenziale del mercato calcistico interno con la Saudi Pro League che ingaggia a cifre spesso insensate campioni del calcio europeo (e che ha affidato a Roberto Mancini la squadra nazionale). E sul piano dell’arte? Non potendo rincorrere Doha sulla strada dell’istituzionalizzazione, Mbs ha deciso di varare un piano nazionale piuttosto aggressivo sulle nuove forme d’arte contemporanea. Nel 2022 ha lanciato la prima edizione della Biennale d’Arte dell’Arabia Saudita a Diriyah, arrivata in questo 2024 alla sua seconda, e sempre dirette da direttori occidentali (Philip Tinari la prima, e Ute Meta Bauer la seconda). È sempre del 2022 l’annuncio dell’apertura di dieci musei nell’area della capitale, uno dei quali dedicato alla fotografia e affidato al curatore italiano Valentino Catricalà, che oggi gira per mezzo mondo a comprare opere con cui costruire la collezione.
Dell’occidente c’è lo sguardo
Questo pezzo è iniziato nel segno dell’Ecclesiaste. Non c’è nulla di nuovo sotto il sole. Ed è così. Nello scacchiere Medio Orientale una cosa sembra non cambiare: lo sguardo a ovest. Se nelle influenze geopolitiche Riyad pare compiere un moto pendolare perpetuo tra Cina e Stati Uniti, nelle scelte culturali lo sguardo di Qatar e Arabia Saudita è fisso all’occidente. Dalle opere dei maestri impressionisti o della pop art americana, alle committenze a Damien Hirst, Jeff Koons, Richard Serra e moltissimi altri, agli architetti, ai direttori e direttrici, ai calciatori, tutto parla in gran parte occidentale. Al netto delle Biennali o della sconvolgente bellezza di un’opera di acciaio specchiante nel deserto, la considerazione che sottende a tutto questo è che stia prendendo corpo un vero asse ombelicale con l’occidente ed in particolare con l’Europa. Un asse che potrà forse, nel corso dei decenni, diventare se non una vera e solida alleanza, per lo meno un tavolo sempre aperto d’incontro. Come nota Federico Rampini nel suo libro Il nuovo impero arabo (Solferino, 2024), «l’altra faccia della tragedia israelo-palestinese è a poca distanza: è la rapida evoluzione in atto in Arabia saudita, che allarga su scala più vasta gli esperimenti già avviati a Dubai o nel Qatar. Quell’area compresa tra il Golfo Persico e il Mar Rosso è un gigantesco cantiere di sviluppo, attira un boom di investimenti e di imprese straniere, anche italiane. […] Ma cosa c’è dietro? Una delle chiavi è la laicizzazione in corso, che riduce i poteri del clero islamico, liberalizza i costumi e migliora i diritti delle donne. Il nuovo impero arabo che resta un regime autoritario (su cui la guardia deve restare alta) vuole rilanciare il proprio ruolo mondiale, memore di quella che fu l’epoca d’oro della sua civiltà. E che sembra uscire dal vittimismo antisraeliano spezzando la catena dell’odio nei confronti dell’Occidente (e il suo finanziamento) che ha portato alla diffusione della Jihad e della violenza fanatica». Insomma, se chiami Damien Hirst a realizzare la sua The Miraculous Journey, la serie di 14 sculture in bronzo che mostrano lo sviluppo di un feto umano nell'utero e che termina con una scultura alta 46 piedi di un bambino, oggi paghi svariati milioni di euro, domani potresti scoprire che quell’utero ha generato un vero nuovo Salvatore in grado di unire Medio Oriente e Occidente.
[1] Qatar, le fatiche del mediatore. https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/qatar-le-fatiche-del-mediatore-179880