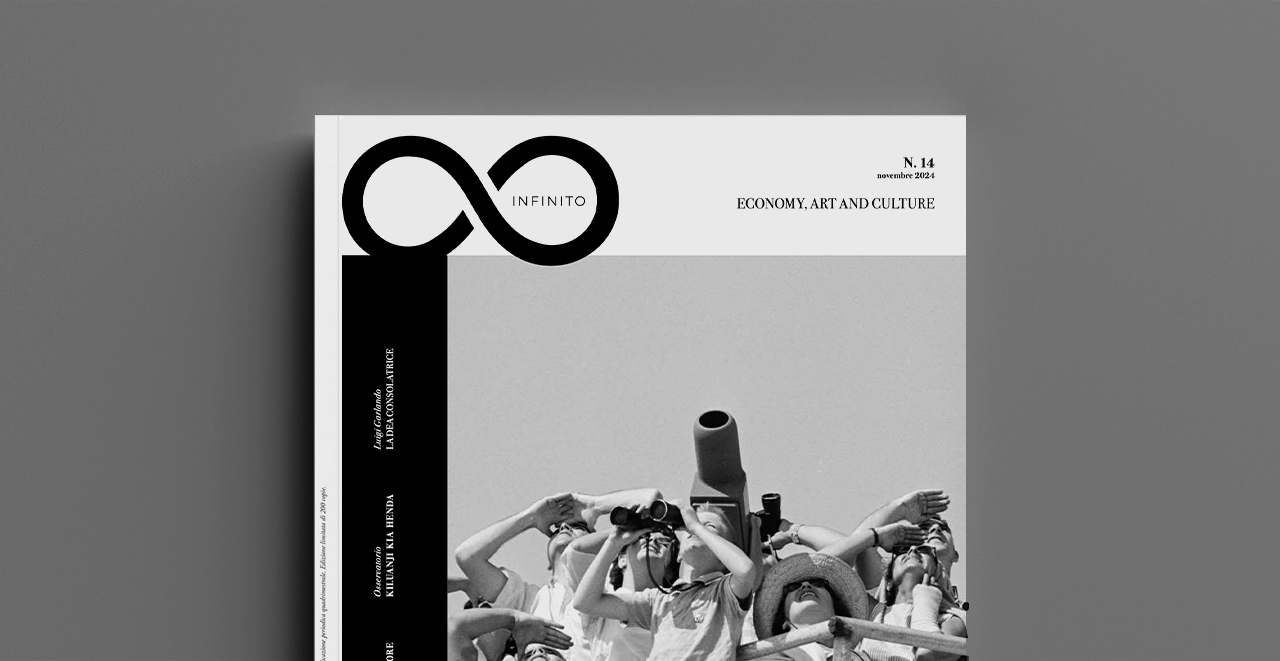Per una nuova lettura aggiornata del pezzo di Marco Bellinazzo «Qatar caput mundi» uscito per il numero VI di Infinito nel luglio 2019. In quell’occasione Marco Bellinazzo scriveva come il Qatar avesse portato per la prima volta il campionato mondiale di calcio nell’universo arabo. Di come il calcio e – più in generale – lo sport, fossero stati nell’ultimo decennio l’acceleratore temporale in grado di spalancare le porte del Golfo, scavalcando secoli di arretratezza e chiusura e trascinando, non senza resistenze, un’intera area geografica e spirituale dal medioevo alla contemporaneità. A distanza di un mondiale e cinque anni al Qatar si aggiunge l’Arabia Saudita, in uno scacchiere, quello arabo e mediorientale, sempre più intricato.
La coppa del mondo?
Ai Giochi di Parigi, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Qatar hanno vinto una sola medaglia. Un bronzo. Ha fatto meglio il Bahrein che di podi ne ha conquistati quattro, aggiudicandosi ben due titoli olimpici. Cinque medaglie sulle oltre 5mila assegnate alle ultime Olimpiadi rappresentano un bottino fin troppo esiguo per i paesi del Golfo, invero «padroni» indiscussi dello sport mondiale nel XXI secolo, da quando, cioè, le autocrazie che li governano hanno deciso di reinvestire i proventi della commercializzazione degli idrocarburi in ambiziosi programmi di riforme economiche e sociali. I piani Vision 2030 elaborati prima negli Emirati e in Qatar e dopo, ma ancora più prepotentemente in Arabia Saudita, hanno inserito lo sport nei piani di rifondazione e progresso. Negli ultimi vent’anni, così, in quest’area geografica sono stati attirati a suon di petrodollari i principali eventi, dal nuoto all’atletica, dalla Formula 1 al tennis, inclusa l’organizzazione della più globale tra le manifestazioni sportive, ovvero i mondiali di calcio, disputati in Qatar nel 2022 e destinati ad essere ospitati in Arabia nel 2034.
L’opinione pubblica internazionale, tifosi e appassionati di calcio hanno, assistito inoltre, nell’estate 2023 all’invasione dei capitali sauditi con l’ingaggio di decine di giocatori appartenenti ai più blasonati campionati europei. Una razzia di stelle e brand che non ha quasi incontrato resistenza. Le squadre della Saudi League le principali controllare direttamente dal Pif, il fondo governativo di Riad, si sono impegnate a versare stipendi paragonabili a quelli della Nba, del tutto sproporzionati rispetto alle entrate di un torneo che non ha ricavi diretti, se non quelli assicurati da sponsorizzazioni ed elargizioni di aziende governative.
Un profluvio di acquisti per oltre un miliardo di dollari che si è ridotto a poco più di un terzo nell’estate 2024 contrassegnata non tanto da un ridimensionamento quanto da un fisiologico assestamento nell’edificazione della Saudi League e soprattutto dall’ufficializzazione della candidatura di Riad alla Coppa del mondo in calendario fra dieci anni. A corredo della quale è stato presentato un dossier accompagnato dallo slogan «Crescere. Insieme» che prevede la costruzione di 11 nuovi stadi su un totale di 15, distribuiti nelle cinque città designate per accogliere le gare: Riyadh, Jeddah, Al Khobar, Abha e Neom, avveniristico insediamento destinato a cambiare il volto urbanistico del Regno. Nella Capitale, in particolare, sorgeranno otto impianti, tra cui il nuovo King Salman Stadium, che ospiterà oltre 92.000 spettatori con la partita di apertura e la finale del torneo e lo stadio Prince Mohammed bin Salman, ideato per avere tribune su tre livelli con vista panoramica su una delle scogliere di Tuwaiq.
«Stiamo lavorando per trasformare il sogno dell’Arabia Saudita di ospitare la Coppa del Mondo FIFA in una realtà tangibile – ha sottolineato il Principe Abdulaziz bin Turki bin Faisal Al Saud, plenipotenziario del Regno in ambito sportivo e non solo. Questi piani garantiranno il successo dell’Arabia Saudita come prima nazione a ospitare un torneo da 48 squadre in un unico paese».
Le ragioni di un nuovo scacchiere
Ma quali sono le ragioni reali che stanno dietro questi investimenti? Perché - questo dovrebbe essere ormai evidente - non si tratta soltanto di far emergere la lega calcistica saudita tra le prime dieci al mondo, né di vincere una competizione internazionale e neppure di organizzare la Coppa del mondo.
Le mire saudite sul calcio - e più in generale sullo sport - sembrano rispondere a obiettivi più compositi e per certi aspetti più radicali di quei concetti di soft power e sportwashing che pure sono stati adoperati per razionalizzare altri analoghi fenomeni che nel recente passato hanno avuto come driver la Russia, la Cina o gli Usa. Esse convergono verso la costruzione di una nuova identità saudita, panaraba e in ultima istanza, islamica.
Quella immaginata dal principe e capo del governo Moḥammad bin Salmān (Mbs), in altre parole, è un’epopea che rimetta Riad al centro dell’universo arabo e mussulmano e contestualmente dello scacchiere geopolitico globale. L’Arabia Saudita non vuole essere più solo la pompa di benzina del mondo, ma il faro di una nuova civiltà in cui tecnologia e innovazione convivano con la tradizione religiosa e il cui patto sociale si regga su libertà e opportunità concesse dall’alto da una monarchia illuminata. Una nuova civiltà in cui la religione sia sempre più un fatto personale piuttosto che pubblico e in cui l’ingerenza dei dettami morali nell’esistenza dello Stato e delle persone sia sempre più marginale.
Mbs intende modificare le regole della società saudita sia pure nel segno della continuità, concedendo le aperture necessarie a dare nuova linfa alla dinastia dei Saud. Per questo ha bypassato le tradizionali catene di comando ed ha estromesso tutta una linea generazionale, quella dei cinquantenni-sessantenni, dai posti cardine di governo, favorendo il ricambio operato da trentenni e quarantenni (anche di sesso femminile). Così ha ridimensionato la presenza opprimente della polizia religiosa, invitata già nel 2016, all’alba della sua ascesa al trono, ad «essere gentile» ed ha importato in Arabia Saudita quei «pezzi» di Occidente ai quali le giovani generazioni saudite e arabe hanno accesso attraverso i new media e i loro device.
Patto generazionale
La «rivoluzione» di Mbs, infatti, è cementata attraverso un patto con le giovani generazioni che rappresentano oltre il 70% della popolazione, in maniera tale da cementare quel consenso indispensabile per rendere non traumatico il passaggio di consegne che avverrà alla morte di suo padre, l’ottantenne re Salman. E che soprattutto disinneschi due rischi per il nuovo establishment saudita: da un lato, lo spettro di nuove primavere arabe, proteste di piazza che riaccendano le richieste di riforme democratiche dal basso; dall’altro lato, l’incancrenirsi di fenomeni di radicalizzazione e derive jihadiste, soprattutto da parte dei giovani a basso reddito. Un pericolo quest’ultimo connesso anche al malcontento del clero wahabita, alleato e garante della monarchia saudita dopo la rivoluzione khomeinista del 1979 nell’Iran sciita, ma la cui presenza nella vita del paese oggi si trova ad essere sempre più limitata.
Per tenere a bada questi pericoli, tuttavia, le libertà non bastano ed è fondamentale incrementare la crescita economica, andando oltre lo sfruttamento degli idrocarburi e il parassitismo pubblico, incentivando un certo grado di privatizzazione delle aziende. Il buon andamento dell’economia, l’incremento del Pil e la modernizzazione sono cruciali per far emergere una classe media autosufficiente, consapevole del nuovo status e disposta ad appoggiare Mbs in cambio di un «equilibrato» riconoscimento di diritti.
L’entertainment, la cultura, lo sport, il turismo, dunque, rappresentano le nuove frontiere, il West alla cui conquista la nuova Arabia Saudita si è lanciata per modellare la sua nuova identità nazionale. Una identità che si proietta anche a livello internazionale. Nello scacchiere globale Riad sta cercando di ritagliarsi un ruolo sempre meno vassallo dell’Occidente e sempre meno bisognoso del protettorato americano. Una sorta di ruolo guida per l’intero mondo arabo e in futuro per quello islamico.
Al-Nassr vs Persepolis
Una strategia politica che Mbs ha modificato e messo a punto nel corso del tempo, dimostrando uno spiccato senso della realpolitik, un misto di cinismo e pragmatismo che ha portato a conversioni notevoli. A un atteggiamento aggressivo verso i vicini palesato fin dal suo insediamento ai vertici del potere saudita ha sostituito progressivamente un’attitudine più conciliante: nel gennaio 2021 ha posto fine all’embargo contro il Qatar che lui stesso aveva voluto tre anni e mezzo prima; nel gennaio 2023 si è posto come mediatore nella guerra civile in Yemen (scoppiata nel 2014 e che lui stesso ha fomentato sostenendo le ragioni sunnite contro il movimento ribelle sciita Houthi); nel corso dello stesso anno, ad aprile, ha propiziato uno storico accordo con l’Iran per la ripresa dei rapporti diplomatici (raggiunto anche grazie alla mediazione della Cina). Il 19 settembre 2023 si è così disputato a Teheran uno storico match della Champions league asiatica tra l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e il Persepolis, senza bisogno di un campo neutro, come accadeva da anni ogni volta che si sfidavano club sauditi e iraniani.
Su questi cambiamenti hanno inciso le scorie mediatiche dell’omicidio di Jamal Khashoggi perpetrato nell’ottobre 2018 all’interno del consolato saudita a Istanbul da parte di ufficiali dell'intelligence di Riad, di cui secondo la Cia Mohammad bin Salman sarebbe stato il mandante. Questo «incidente» che costituisce l’apice, in negativo, di una politica di repressione che Mbs ha messo in atto soprattutto nei primi anni imprigionando blogger, attivisti per i diritti umani, religiosi, accademici, membri della famiglia reale e uomini d’affari, potrebbe avergli reso chiaro che non conviene tacitare i dissidenti con la violenza, ma che le critiche vanno sommerse sotto il suono delle fanfare e la celebrazione dei successi. In questo senso, come sottolineano i suoi detrattori, la grancassa sportiva e calcistica può rivelarsi molto utile. Come è accaduto nell’agosto del 2023 quando l’eco dei faraonici colpi di calciomercato messi a segno dai club della Saudi League hanno quasi tacitato le denunce di Human Rights Watch sulle uccisioni sommarie da parte delle guardie di frontiera saudite dei migranti etiopi in Yemen e le polemiche sulle oltre 100 condanne a morte eseguite in Arabia Saudita nei primi otto mesi dell’anno (sono state 147 in tutto il 2022).
La guerra sulla strada
Con le mosse degli ultimi tempi e altre di minore magnitudo, Riad ha anche messo in chiaro la volontà di essere più autonoma nell’intessere relazioni con le grandi autocrazie orientali, Russia e Cina, e di porsi come una delle locomotive planetarie, facendo da battistrada al rafforzamento dei Brics, che dalle storiche economie emergenti - Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica - si è allargata, secondo quando è stato deciso durante il summit a Johannesburg dell’agosto 2023, proprio all’Arabia Saudita, e ai suoi più stretti alleati, Egitto e Emirati Arabi Uniti, oltre che all’Iran e all’Etiopia, arrivando così a rappresentare un terzo del Pil e oltre 40% della popolazione del pianeta. Sempre ad agosto 2023, a Gedda, l’Arabia del resto ha ospitato una conferenza di pace sull'Ucraina con i rappresentanti delle potenze emergenti e dei Paesi occidentali e della Cina. Mentre tre mesi prima nella città sul Mar Rosso Mbs aveva convocato una riunione straordinaria della Lega Araba, riammettendo il dittatore siriano Bashar al-Assad nel tavolo dei partecipanti.
Ad ogni modo, queste operazioni di nation building e di pacificazione regionale, che avevano visto anche un riavvicinamento tra la stessa Arabia Saudita e Israele, si sono incagliate il 7 ottobre 2023, con l’attacco di Hamas a Israele e il conseguente sanguinoso conflitto (anzi, non è sbagliato affermare che questi tragici eventi sono stati provocati anche per bloccare le dinamiche ispirate dal nuovo corso saudita).
L’impressione è che con la piena e definitiva deflagrazione del bipolarismo novecentesco, una faglia sempre più profonda si stia aprendo tra le democrazie occidentali e le autocrazie orientali. Una faglia mobile che ha sostituito l’ex Cortina di Ferro, caratterizzata più da modelli giuridico-sociali che da principi ideologici. E per molti versi è come se l’universo arabo-islamico, che annovera una popolazione di circa due miliardi di persone e che va dal Marocco all’Indonesia, stia oscillando nel mezzo di questa faglia alla ricerca di una propria dimensione. Ecco perché diventa fondamentale riuscire ad attrarlo e non lasciarlo scivolare verso modelli antidemocratici e autoritari, incoraggiandone le progressive aperture. Ed ecco perché lo sport contemporaneo, con tutte le sue implicazioni economiche e mediatiche, gioca un ruolo determinante in questi scenari.