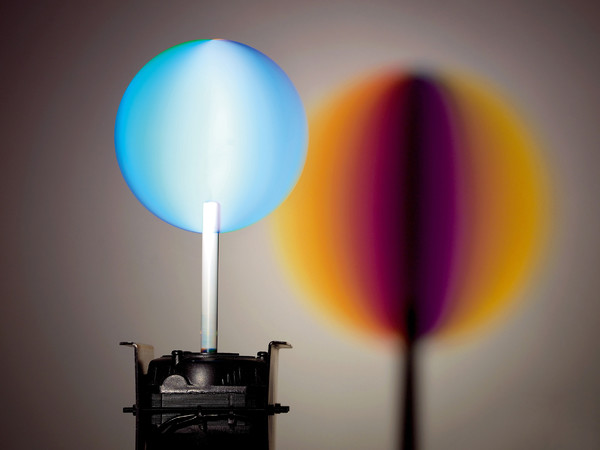La precisa lettura di cosa sia il lavoro di Peter Dreher (Mannheim, 1932) l’ha data lui stesso quando dice che «per dipingere un quadro nella sua massima semplicità lo si deve svuotare del suo valore e di ogni significato. Lo si deve dipingere ancora una volta. E ancora un’altra, e un’altra, cento, mille volte. Così rimane il quadro che non sarà nient’altro che un quadro. Un oggetto come un qualunque altro oggetto». Per un intellettuale che ha toccato la putrescenza del nazismo, l’arte è stata probabilmente anche questo: una via verso un rifugio. Dal 1972 Peter Dreher dipinge ogni giorno quel quadro, un bicchiere su un tavolo del suo studio, su cui si riflette una finestra: sempre la stessa prospettiva, nelle sue reali dimensioni di bicchiere, un olio su tela. Dal 1974 questo personalissimo esercizio interiore, gentile mantra, diventa un vero e proprio ciclo (“Tag um Tag ist guter Tag”, la cui traduzione inglese potrebbe essere “Day by day good day”). Un’ossessione pacata che sembra voler sottrarre il gesto al tempo che incede, perché quel bicchiere, per chi avesse modo di vedere una selezione di quelle tele attraverso questi lunghi quarant’anni, è sempre lo stesso, anche se possiamo immaginare la mano che lo dipinge più artritica, il mondo attorno così diverso. Questa ripetizione ha anche a che vedere con qualcosa d’altro e come nota Hans Ulrich Obrist, è una via tendenziale a una personalissima forma di astrazione. Come se quel bicchiere ormai per Peter Dreher non esistesse più in quanto tale, le sue molecole fossero una casuale composizione reticolare a forma di contenitore riflettente e semi-trasparente e che solo per convenzioni, a lui stesso del tutto estranee, per miliardi di persone venisse definito “bicchiere”. Non solo; si può immaginare che Peter Dreher sia arrivato a conoscere ogni millimetro di quella tela sempre uguale a sé stessa, che lui stesso possa stendere un prontuario, un elenco di regole per dipingere un bicchiere, un precisissimo vademecum per il “gesto” della pittura, di come l’animo, più della mano, debba accorarsi per trovare l’inflessione così banale eppure così alta per accostare il pennello alla tela in un modo che avrebbe senso definire soltanto “buono”. E in fondo a una fatica così grande, e sicuramente così liberatoria, dipingere lo stesso bicchiere ogni giorno della propria vita, arrivati a tal punto a soddisfare e conoscere questa intima ossessione, non può che arrivare un “qualcosa”. Come fosse una poesia, o una creazione, non è importante definirlo. Quello che è sufficiente per noi che guardiamo quei bicchieri in fila indiana sulla parete è osservare un evento: arrivati al fondo della questione, come è arrivato Peter Dreher, scarnificata l’idea sino al suo osso, pulito il diamante sino al suo più puro perimetro, esiste l’idea. Per qualcuno è un’invenzione che cambierà anche solo impercettibilmente il corso della vita, per altri una poesia in versi, un quadro, una scultura, una composizione in musica: solo quando si conosce tutto di una certa cosa è possibile rappresentarla e definirla. Come a dire: il bel gesto non è una poetica astrazione acrobatica di talento, ma il prodotto ripulito e levigato di un lunghissimo ripetersi nevrile e sfiancato che, come una freccia, non può che trafiggere il suo cuore. A questo, in definitiva, serve il lavoro di Peter Dreher sulla terra, a farci comprendere quando può apparire un’opera e quando solo il suo flebile fantasma confuso.
Quel mantra gentile
Il cugino di Daverio
Dipingere ogni giorno lo stesso bicchiere, l’ossessione gentile del pittore Peter Dreher per arrivare all’illuminazione.

Il cugino di Daverio
Esiste una possibilità che sia io o che non lo sia. Scrivo, qui, di arte che verrà.