Il 27 novembre del 2020 al Cairo i tempi migliori non sono ancora arrivati. La finale della Champions League africana, che avrebbe dovuto tenersi il 29 maggio a Douala, in Camerun, ma che era stata spostata di giorno e di luogo per via della pandemia di Covid-19, si gioca a porte chiuse. C’è un contrasto stridente tra l’attesa che circonda la partita, la narrazione che se ne fa ancora prima che cominci, e le immagini desolanti che arrivano dallo Stadio Internazionale del Cairo completamente vuoto. La chiameranno la finale del secolo, o la partita africana del secolo, ed è impossibile non chiedersi cosa sarebbe stata questa partita, se non ci fosse stata una pandemia di mezzo. Al Cairo si affrontano le due squadre più importanti d’Egitto e forse anche di tutto il resto del continente, rivali da sempre, ma ciò che fa più rumore è l’assenza. Da una parte lo Zamalek, fondato agli inizi del ’900 a Giza da un avvocato belga che era tra i consiglieri dei sultani d’Egitto. Dall’altra l’Al Ahly, nato all’incirca negli stessi anni per dare una squadra agli studenti dei licei, che diventeranno i protagonisti della rivoluzione egiziana contro l’occupazione britannica. L’Al Ahly non ha mai perso questa sua carica politica. Nel febbraio del 2012 l’uccisione di 74 suoi tifosi durante una partita contro l’Al Masry a Port Said sarà uno dei capitoli più importanti e cruenti della caduta del regime di Hosni Mubarak. I gruppi organizzati della tifoseria dell’Al Ahly accuseranno la polizia egiziana di essersi rifiutata di aprire i cancelli dello stadio mentre i tifosi dell’Al Masry facevano mattanza, secondo loro per l’opposizione feroce e scanzonata al regime militare che fino a quel momento aveva retto l’Egitto. Mohamed Salah, quando arrivò in Serie A per indossare la maglia della Fiorentina, scelse il 74 per questo motivo. La finale del secolo restituisce sul campo la bellezza che manca sugli spalti. Dopo il gol su calcio d’angolo di El-Soleya, alla mezzora per lo Zamalek pareggia Shikabala, uno slalom gigante tra tre difensori avversari che si conclude con un tiro dal limite dell’area che sbatte sotto il sette opposto. All’86esimo la partita sembra scivolare sulla paura di perdere verso i supplementari quando una ribattuta di testa della difesa dello Zamalek viene controllata di coscia al volo da Mohamed Magdy e adagiata sulla rete dietro il palo più lontano con un tiro di collo potente e dolce allo stesso tempo. È il trionfo dell’Al Ahly e del suo allenatore, Pitso Mosimane, il primo africano non egiziano di sempre a guidare la squadra.
Mosimane: l’uomo dei miracoli.
L’Al Ahly ha avuto una lunga storia di allenatori europei (soprattutto inglesi, portoghesi e olandesi) e all’inizio del 2020 ancora non sa che lo scetticismo con cui accoglie questo allenatore sudafricano dagli occhi tristi e la lingua tagliente si sta per trasformare in uno dei periodi più vincenti della sua storia. Nelle settimane successive alla finale del secolo l’Al Ahly vince anche la Coppa d’Egitto, la medaglia di bronzo alla Coppa del Mondo per club (dove viene fermato solo in semifinale dal Bayern Monaco) e la Supercoppa africana (2-0 sui marocchini del RS Berkane). Dopo meno di otto mesi dal trionfo contro lo Zamalek, per via della compressione del calendario dovuta all’interruzione per la pandemia, l’Al Ahly è di nuovo in finale di Champions League, questa volta contro i Kaizer Chiefs, una delle squadre più titolate del Sudafrica che Mosimane tifava da bambino. Segnano di nuovo El-Soleya e Magdy ma questa volta la vittoria è senza appello. Nello stadio Mohammed V di Casablanca, ancora vuoto per via della pandemia, finisce 0-3. In meno di un anno Mosimane ha vinto i due più importanti trofei continentali (uno di questi due volte) e una medaglia al Mondiale per club, ma la FIFA nel gennaio del 2022 non lo inserisce nemmeno tra i sette candidati per l’allenatore dell’anno. Qualche giorno dopo il giornalista inglese Rory Smith sul New York Times lo intervista per cercare una ragione.
«Non è solo l’Africa ad essere sottovalutata», dice Mosimane «è come se non contasse molto quando non vinci nelle competizioni più ricche, o in quelle che hanno il pubblico più numeroso». C’entra anche il colore della pelle, lo dirà chiaramente in un’altra intervista, al The South African. «Volete dirmi che di tutti gli allenatori neri in Inghilterra nessuno può allenare? Di recente ho parlato con Dwight Yorke, una leggenda del Manchester United e dell’Inghilterra, e me l’ha detto chiaramente: Pitso non pensarci nemmeno. Se noi che abbiamo segnato così tanti gol per queste squadre non siamo ancora allenatori nonostante siamo qualificati per farlo, allora per te sarà dura venire qua».
Per Mosimane «l’Europa non è ancora pronta per gli allenatori africani», ed è chiaro che intenda in primo luogo neri. Il 30 maggio di quest’anno l’allenatore sudafricano torna allo stadio Mohammed V di Casablanca, questa volta rosso sangue e denso di fumo per i tifosi della squadra marocchina del Wydad. È la terza finale di Champions League di seguito, qualcosa che in Europa è riuscita solo a Zinedine Zidane (tre vittorie su tre) e a Marcello Lippi (una su tre). Mosimane si fermerà a due, costretto a vedere da avversario perdente cosa avrebbe potuto essere vincere una finale con uno stadio pieno al Cairo. Alla luce dei festeggiamenti dei tifosi del Wydad assumono un significato doloroso le parole che aveva detto qualche mese prima al New York Times: «I sudafricani amano il calcio, ma non quanto gli egiziani». Qualche giorno dopo si dimetterà da allenatore dell’Al Ahly, come un malinconico eroe di un film noir. Mosimane sui tifosi sudafricani può parlare con cognizione di causa. Nel 2016 aveva riportato la Champions League in Sudafrica per la prima volta dal 1995, quando era stata vinta dagli Orlando Pirates, portando al suo apice la velocissima ascesa dei Mamelodi Sundowns. Il club è stato fondato solo negli anni ’70 ma oggi è già tra quelli più ricchi e conosciuti di tutto il continente, per valore di mercato è secondo dietro solo all’Al Ahly. Nato nell’omonima cittadina a nord-est di Pretoria voluta dal governo dell’apartheid e originariamente per soli neri, i Mamelodi Sundowns sono chiamati i brasiliani per via della loro divisa praticamente identica a quella della Seleçao e per il gioco spiccatamente tecnico. Dal 2014 vincono la Premier League sudafricana quasi ininterrottamente (le uniche eccezioni sono state le stagioni 2014/15 e 2016/17, quando comunque ha raggiunto il secondo posto) ma il loro dominio sul calcio del Paese affonda le sue radici ancora prima, al 2004 per la precisione. In quell’anno vengono acquistati da Patrice Motsepe, oggi il nono uomo più ricco d’Africa e il primo africano nero a riuscire a entrare nella lista di Forbes delle persone più ricche del mondo, allora ancora solo un imprenditore uscito dal settore minerario che non ha nessuna conoscenza del mondo del calcio.
Motsepe: storia di un uomo che cambierà le sorti del calcio africano.
Motsepe è nato in una delle provincie che compongono l’enorme tessuto urbano di Pretoria e cresce nel piccolo alimentari del padre, che è molto popolare tra i minatori neri della zona. La sua ascesa coincide quasi perfettamente con l’uscita del Sudafrica dall’apartheid. Nel 1994, l’anno in cui Nelson Mandela viene eletto primo presidente nero del Paese, Motsepe diventa il primo socio nero di un importante studio legale. Il suo ingresso nel settore minerario è facilitato dalle leggi sull’emancipazione economica dei neri volute dal nuovo governo che obbligano le aziende minerarie ad essere detenute da neri almeno al 26%. La sua ricchezza, però, proviene dall’acquisto di alcune miniere d’oro a prezzo di saldo nel 1997, che diventeranno il germe della società che farà la sua fortuna, la African Rainbow Minerals. «I miei amici mi chiamano capitalista nero», ha dichiarato una volta contenendo a stento la sua soddisfazione, forse ricordando i suoi primi passi nel nuovo Sudafrica. Oggi che il cerchio è chiuso, la sua famiglia è una delle più potenti di tutto il Paese, e non solo per via della sua ricchezza. Suo cognato, Cyril Ramaphosa, è presidente del Sudafrica dal 2018 e c’è chi dice che il percorso che ha intrapreso Motsepe nel mondo del calcio sia un segno della sua volontà a succedergli quando verrà il momento. La trasformazione dei Mamelodi Sundowns nella squadra più vincente e conosciuta del Sudafrica è solo il primo passo. Nel novembre del 2020, mentre al Cairo si gioca la finale del secolo, Patrice Motsepe annuncia di volersi candidare a presidente della Confederazione Africana di Calcio (CAF), e inizialmente non è chiaro come farà a ottenere il consenso necessario per farsi eleggere in un’istituzione in cui è praticamente uno sconosciuto. Motsepe, però, ha connessioni più in alto. Il suo nome è raccomandato per esempio dal controverso presidente del Rwanda, Paul Kagame, uscito vincitore dalle contese politiche che animarono il terribile genocidio degli anni ’90 e oggi demiurgo autoritario di una delle economie più dinamiche del continente. Kagame è un tifoso pazzo dell’Arsenal ed è soprattutto grazie a lui se la NBA si è convinta a inaugurare una propria costola in Africa, la Basketball Africa League, una lega continentale di basket la cui stagione inaugurale, lo scorso anno, si è tenuta proprio a Kigali, in Rwanda. Oltre che da Kagame, il nome di Motsepe è raccomandato anche da Gianni Infantino, presidente della FIFA che ha bisogno dei 54 voti della confederazione africana per potersi assicurare la rielezione il prossimo anno (che tra l’altro si terrà durante il 73esimo congresso della FIFA, che si svolgerà proprio a Kigali). Motsepe e Infantino si conoscono almeno dal 2017, proprio nelle settimane in cui lo storico presidente della CAF, il camerunese Issa Hayatou, viene destituito per un’accusa di corruzione legata alla vendita dei diritti televisivi dei Mondiali. Secondo molti, da quel momento Infantino sceglie Motsepe come suo delfino in Africa proprio perché non ha particolari connessioni con il mondo delle istituzioni calcistiche africane, ed è quindi poco influenzabile se non da lui e dalla FIFA. La rivista sportiva d’inchiesta norvegese Josimar lo definisce in maniera brutale «il miliardario burattino», in un pezzo dello scorso anno in cui viene anche citato Ishmael Bhamjee, storico presidente della federazione di calcio del Botswana e rappresentate della CAF nel comitato esecutivo della FIFA, secondo cui con Motsepe il calcio africano sarebbe stato di fatto controllato da Infantino (Bhamjee è morto pochi giorni prima della pubblicazione del pezzo dopo aver contratto la Covid-19). Motsepe e Infantino si fanno vedere insieme diverse volte ancora prima che il miliardario sudafricano diventi presidente della CAF. Nel gennaio del 2020, durante una cena del World Economic Forum di Davos, si fanno fotografare accanto a Donald Trump, ancora presidente degli Stati Uniti. In quell’occasione Motsepe dichiara pubblicamente che «l’Africa lo ama». Pochi giorni dopo, a seguito di una serie di reazioni sdegnate, è costretto a ritrattare.
Una Superlega africana?
L’idea di una Superlega africana nasce in quel periodo, giusto qualche settimana prima. Infantino si presenta a Lumumbashi per l’80esimo compleanno del TP Mazembe, la squadra più importante della Repubblica Democratica del Congo e la prima africana a raggiungere la finale del Mondiale per club (nel 2010, quando venne sconfitta per 3-0 dall’Inter) e poi, stretto in un imbarazzante divisa rossa, partecipa a una partita commemorativa con diverse leggende del calcio africano e non, tra cui Eto’o e Djorkaeff. È in quella occasione che Infantino suggerisce la creazione di una Superlega africana, che a suo avviso potrebbe generare almeno 200 milioni di dollari di profitti l’anno. L’idea circola carbonara per settimane e mesi, si staglia come un punto di fuga all’orizzonte che non può essere mai raggiunto, e si trasforma in dichiarazioni più ufficiali solo nel marzo del 2021, forse non casualmente proprio nei giorni in cui Patrice Motsepe viene eletto presidente della CAF. A verbalizzarla per la prima volta è l’amministratrice delegata della squadra tanzaniana Simba SC, Barbara Gonzalez, che sul suo account Twitter annuncia che «lo sviluppo della Superlega africana con 20 membri permanenti è in corso» e che non vede l’ora di rendere la sua squadra una delle partecipanti. La fortuna della CAF è che proprio nei giorni successivi quasi lo stesso identico progetto viene proposto in Europa, distogliendo l’attenzione e permettendole di prendere tempo per formulare meglio la proposta. Un alto funzionario della confederazione africana, Ahmed Yahya, lo ammette implicitamente quell’estate, dichiara che l’errore in Europa è stato quello di annunciare il progetto «fuori dalle strutture calcistiche [esistenti, ndr] e in aperto conflitto con la UEFA».
Non è però ancora chiaro che cos’è la Superlega africana: in cosa si differenzia?
Il vaso di Pandora ormai è aperto e il fatto che la CAF non prenda una posizione ufficiale non fa che accelerare le voci. Nel febbraio di quest’anno ci scherza su anche Pitso Mosimane. «Mi chiedete cosa succederà con la Superlega africana. Che vi devo dire, sono interessato anche io, mi piacerebbe sapere qualcosa di più, avrei bisogno che qualcuno mi spiegasse, magari qualcuno di voi può mandarmi qualcosa che mi illustri di cosa si tratta». Bisognerà aspettare ancora mesi per annuncio ufficiale della CAF, che arriva solo l’11 agosto. Finalmente da quel giorno la Superlega africana è realtà, o quasi, perché la prima edizione si terrà tra un anno. «Questo è uno dei progetti più eccitanti della storia del calcio africano», esulta Motsepe. Infantino, come preoccupato dalle recenti faide legali europee, ricorda che la Superlega africana nasce «all’interno della piramide calcistica internazionale» e che farà «brillare il calcio africano nel continente e oltre». Il montepremi totale sarà di 100 milioni di dollari, oltre 11 solo per il vincitore (contro i 2.5 assegnati al vincitore dell’attuale Champions League). Quello dei soldi promessi è un tema di tutte le superleghe, ma con quella africana diventa ancora più delicato. La CAF è un’istituzione finanziariamente in difficoltà che recentemente ha stracciato un contratto da un miliardo di dollari per i diritti TV delle sue competizioni con il gruppo francese Lagardère, e allora dove prenderà i soldi? Al di là della carota del montepremi, comunque, la CAF dimostra però di aver davvero imparato dai recenti tumulti europei. I membri della Superlega intanto saranno 24 e non 20, e soprattutto non saranno permanenti, ma si potrà entrare e uscire con playoff di promozione e retrocessione alla fine di ogni stagione. Nessun club, poi, potrà entrare senza dotarsi prima di una propria squadra femminile e di un vivaio, entrambe cose non scontate ovunque in Africa. Le squadre saranno divise in tre gruppi da otto, caratterizzati geograficamente: uno per l’Africa settentrionale, uno per quella centro-occidentale e uno per quella sud-orientale. Nessun Paese potrà avere più di tre squadre. Ma allora chi parteciperà? Sulle squadre che faranno inizialmente parte della Superlega cominciano i primi problemi, perché la CAF ha rimandato la decisione dichiarando che verranno scelte in base al ranking per un periodo di tempo ancora da specificare. Se si prende quello degli ultimi cinque anni, però, si noterà come 15 delle prime 24 posizioni sono occupate da squadre nord-africane, di cui quattro egiziane, tre marocchine, tre tunisine e tre algerine. E quindi chi sarà la grande esclusa tra le squadre egiziane? E quali altre squadre rimarranno fuori calcolando che i posti a disposizione sono solo otto? La Superlega africana rischia di spezzare alcuni derby storici del calcio africano, come quello di Tunisi tra Esperance e Club Africain, quest’ultima fuori dalle prime 24 posizioni del ranking CAF. «L’Espérance e il Club Africain sono due facce contrapposte di una città complessa» ha scritto Roberto Scarcella su L’Ultimo Uomo, ma dall’anno prossimo in poi questa simmetria potrebbe sporcarsi, non combaciare più alla perfezione. La Superlega porta con sé anche il pericolo opposto, quello di svuotare il significato di una rivalità attraverso la sua riproduzione su scala industriale. Il derby tra Al Ahly e Zamalek avrebbe lo stesso peso se si ripetesse ogni anno non un paio di volte, ma, che so, una decina? Il ranking CAF è uno specchio affidabile del modo diseguale in cui si è sviluppato il calcio in Africa fino ad adesso e in questo modo i tre gironi rischiano di diventare una sorta di Serie A, Serie B e Serie C della Superlega. Il pericolo, in questo senso, è che solidifichi e addirittura accentui gli squilibri già esistenti anziché rafforzare l’intero movimento, come si preoccupano di ripetere instancabilmente tutti gli addetti della CAF e della FIFA che vogliono promuovere il progetto. Forse il difetto più grande della Superlega, quindi, è di trattare il calcio africano in maniera paternalista. Per esempio, si specifica che il torneo affiancherà e non sostituirà le coppe già esistenti, come la Champions League e la Confederation Cup (che forse andranno incontro a un taglio della fase a gironi), forse supponendo che il problema dell’ingolfamento del calendario, di cui tutti gli allenatori in Europa si lamentano, in Africa non esista. La CAF ha inoltre dichiarato che darà 3.5 milioni a tutte le squadre per i costi di viaggio e alloggio, un problema atavico del calcio africano (e dei suoi tifosi), senza contare le grandi disuguaglianze che esistono anche tra i club più grandi. Pitso Mosimane, commentando la Superlega, ha fatto notare come gli ultimi due club che ha allenato, tra i più grandi e ricchi d’Africa, avessero disponibilità molto diverse: l’Al Ahly ha il suo aereo per spostarsi, mentre i Sundowns utilizzano voli commerciali. E se questa è la situazione all’interno della Superlega, cosa succede fuori?
La Superlega è davvero il futuro del calcio africano (ed europeo)?
Se ricordate, questo era il timore più profondo che suscitava anche la Superlega europea, un progetto che puntava ad accentrare la ricchezza nelle mani dei club più ricchi e potenti con il rischio che la cosiddetta base della piramide finisse per spezzarsi. Con base della piramide si intendono non solo le squadre escluse al primo livello del calcio nazionale ma anche quella miriade di squadre e accademie dei livelli più bassi senza cui il calcio come ecosistema non potrebbe funzionare come oggi, e se in Europa è stata indebolita da disuguaglianze che hanno reso i club che stanno in cima sempre più pesanti da sostenere, in Africa si regge con gli stuzzicadenti. Come abbiamo visto ci sono grandi differenze tra Paese e Paese, ma il minimo comun denominatore è che moltissimi club non hanno le risorse per affrontare viaggi internazionali, spesso nemmeno per pagare gli stipendi. Stipendi che a loro volta variano molto, passando dai circa 30mila dollari mensili medi della Tunisia ai circa 1250 della Nigeria, il Paese più popoloso del continente con una delle Nazionali più iconiche che però dentro la Superlega rischia di essere rappresentata da un solo club (probabilmente l’Enyimba). Questo progetto è davvero quello che serve, quindi, in un contesto come questo? «Non c’è nessuna prova che il calcio africano trarrà beneficio della Superlega al di là dei pochi che ci entreranno», ha scritto il presidente del sindacato dei calciatori sudafricani, Thulaganyo Gaoshubelwe, in un comunicato molto duro. Quella di Gaoshubelwe è la visione di chi, soprattutto in Sudafrica, accusa Infantino di fare, attraverso Motsepe, nient’altro che neocolonialismo, portando la CAF a credere che «l’Africa debba ‘imparare’ dall’Europa», nonostante non sia affatto scontato che la Superlega possa davvero far crescere il calcio africano nel suo complesso. È l’altra faccia della luna del dibattito sull’Africa, dove quella luminosa è rappresentata da chi invece la descrive in maniera ottimistica come il continente del futuro che, senza la zavorra delle fratture e dei litigi in cui è rimasta impantanata l’Europa, è pronta a lasciarsi i vecchi retaggi alle spalle. Da lontano sembrano due punti di vista inconciliabili, ma non è detto che nei fatti lo siano davvero.



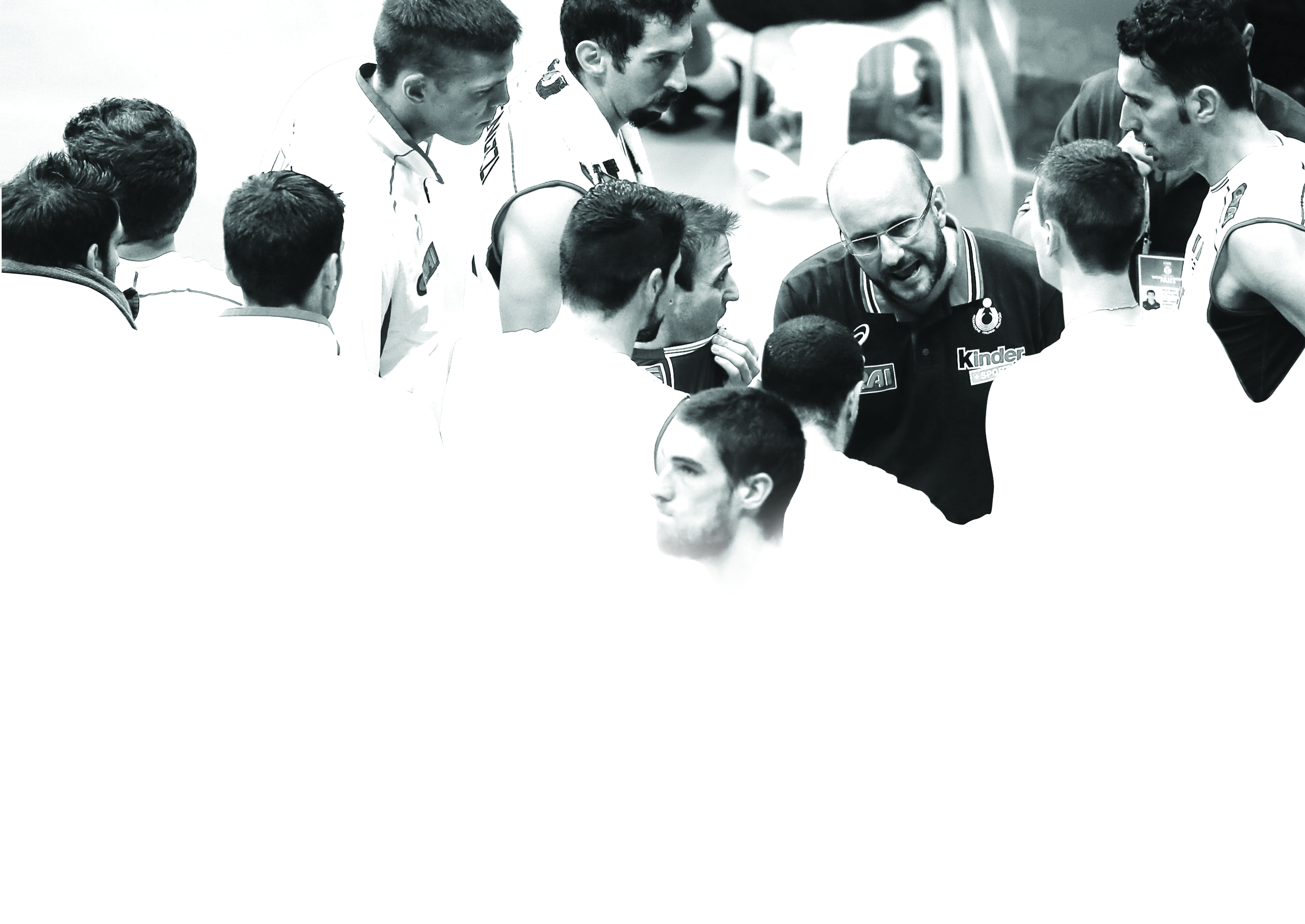



_upR9F.jpg)
_Dd4VV.jpeg)
