Il primo carico di frumento in arrivo dal Mar Nero è giunto in vista della costa etiope alla vigilia di Ferragosto, accendendo la fiammella della speranza di fronte al rischio della tempesta perfetta innescata dalla guerra in Ucraina. Nel 2021 l’Etiopia aveva acquistato dall’Ucraina cereali, derivati e macchinari industriali per oltre 200 milioni di euro, dalla Russia invece cereali ed articoli derivati per un ammontare di 40 milioni di euro. La guerra tra i due paesi, tra i maggiori produttori mondiali di cereali, ha interrotto la catena di approvvigionamento, ha causato un innalzamento generalizzato dei prezzi e una carenza di prodotti primari, come il grano e l’olio di semi, mai registrata fino ad oggi. Ma la dipendenza dall’import di cereali dall’Ucraina e dalla Russia, è solo la prima delle tante conseguenze che il conflitto europeo può avere sugli equilibri del Continente, quasi all’improvviso tornato al centro della scena, vuoi per l’immenso patrimonio di materie prime, vuoi per il peso economico e strategico di un’area chiave per gli equilibri tra le superpotenze, Cina e Usa, ma ancor di più per le residue ambizioni dell’Europa di poter recitare un ruolo di leader, culturale ancor più che economico, nel mondo futuro.
GLI USA CERCANO DI RECUPERARE IL TERRENO PERDUTO
L’Africa è il Continente che può far la differenza tra i blocchi in competizione. E non è certo per caso se si moltiplicano le iniziative diplomatiche dei big, anche da parte americana, dopo lo sciagurato disinteresse dell’era Trump («L’Africa è il buco del sedere del mondo» ebbe a dire l’ex presidente). Dopo un secolo, dominato dall’energia fossile e dall’attenzione al Medio Oriente, l’auto elettrica ed altre applicazioni del mondo digitale hanno risvegliato l’attenzione per i tesori del Continente nero. Il segretario di Stato Anthony Blinken ha più volte visitato nel 2021 gli stati chiave per gli equilibri del Continente, dal Sud Africa alla Repubblica Democratica del Congo: il primo è il partner commerciale più importante della regione che ospita almeno 600 aziende americane. Il Congo è invece il Paese più grande dell’Africa subsahariana, ha immense risorse (a partire dal pregiatissimo cobalto) e notevole potenziale idroelettrico: ma è instabile, tutt’ora dominato da almeno cento diverse milizie ed estremamente povero. Aiutarlo a trovare la pace è dunque la missione che si è data Washington nella speranza, è ovvio, pure di sfruttarne meglio il potenziale economico nell’ambito del piano approvato dal Congresso con un titolo che è un programma: «Countering Malign Russian Activities in Africa Act». Ovvero la rinnovata attenzione statunitense per l’Africa è strettamente legata all’attivismo di Mosca che dal 2019 ha siglato più di venti accordi di cooperazione con gli stati della regione. Di qui un fiume di denaro che transiterà anche dalla MCC, la Millennium Challenge Corporation che ha già investito oltre 9 miliardi, coinvolgendo partner pubblici e privati. Ma lo sforzo massimo ci sarà a metà dicembre, quando il presidente Joe Biden ospiterà decine di leader africani.
MA LA META’ DEI PAESI NON CONDANNA MOSCA
In questo modo Washington tenta di recuperare l’ostilità verso l’Ovest emersa in occasione del voto alle Nazioni Unite sull’invasione dell’Ucraina. In quell’occasione un terzo dei Paesi africani si è astenuto: 17 schede bianche mentre l’Eritrea si schierava con Mosca. Se si considerano anche gli 8 Paesi assenti al voto, si sale a 26, ovvero poco meno della metà delle 54 nazioni che compongono il Continente. C’è di fatto un’Africa che guarda a oriente e che lo fa non soltanto per la Russia. Al voto si sono astenute anche Cina e India, nazioni “continente” che come la Russia hanno provato a giocare un ruolo sempre più attivo in Africa, innanzitutto sul piano economico. E se la Russia ha spinto l’acceleratore sul tema della sicurezza andando a incidere su vecchi equilibri, in particolare ai danni della Francia (si veda in Mali o in Centrafrica), e sul tema dell’energia, muovendosi sul gas e sul nucleare, la Cina è sua volta un attore ormai imprescindibile, specie nel complesso gioco delle materie prime. Certo, l’Unione Europea presa nel suo insieme conta ancora più della Cina nell’interscambio, ma la sua è una posizione di difesa, in progressivo arretramento.
WAGNER, I SOLDATI DI VENTURA DI PUTIN
Vladimir Putin ha giocato fin da subito la carta africana per smentire l’idea di un isolamento della Russia dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. In particolare, la diplomazia del Cremlino ha puntato sull’arma dell’export del grano, al centro dei viaggi del ministro degli Esteri Lavrov e dei colloqui a Sochi tra Vladimir Putin e il presidente del Senegal Macky Sall, in rappresentanza dell’Unione Africana. E il Continente nero ha deluso le speranze occidentali su un blocco unitario contro Mosca. Com’era prevedibile, spiega Gilles Yabi, direttore del centro di ricerche Wathi di Dakar. «È legittimo – spiega – che i Paesi Africani pensino innanzitutto ai propri interessi». Ma l’economia conta fino ad un certo punto. Putin ha potuto far leva sulla costante presenza russa nella politica africana, dagli anni Sessanta, ai tempi delle lotte anticoloniali, fino agli sviluppi più recenti, vedi la penetrazione in Mali e repubblica Centroafricana delle milizie della compagnia Wagner, vicina al Cremlino, ed il ruolo di Mosca nella politica libica. Prezioso avamposto delle milizie di Putin tra il Mediterraneo e l’Africa sub sahariana, la Wagner guidata da Evgenij Progozhin, conosciuto anche come il «cuoco di Putin» per l’esclusiva del catering delle cene al Cremlino (oltre che titolare di una fabbrica di «fake news» a San Pietroburgo), è arrivata in Repubblica Centroafricana nel 2018 a sostegno del traballante presidente locale. In poco tempo sono diventati padroni del Paese e delle sue ricchezze minerarie di oro e diamanti.
MALI, LA MINACIA INCOMBE SU LAMPEDUSA
Il Mali è un altro buon esempio della penetrazione russa, colpevolmente sottovalutata dall’Occidente. Nel 1994, Mosca ha siglato con Bamako il primo accordo di cooperazione per la difesa. Il secondo è stato firmato nel 2019. Tra questo anno ed il 2020 si sono verificati due colpi di Stato. L’ultimo ha portato una giunta militare vicina alla Russia al potere, dando così luogo a un braccio di ferro con Parigi e diversi Paesi europei, Italia compresa. La Francia, presente in Mali dal 2013, non è riuscita a sgominare la presenza dei gruppi jihadisti presenti nel nord del Paese e a stabilizzare il Sahel, una regione fondamentale per il controllo dei flussi migratori. La missione cui ha partecipato anche un contingente italiano, si è scontrata con l’ostilità della giunta golpista, sempre più vicina a Mosca, la quale ha inviato aiuti militari e un contingente del gruppo Wagner per stabilizzare il Paese, sostituendo le truppe europee.
Il Mali è molto utile per comprendere la centralità dell’Africa rispetto agli attriti tra Europa e Stati Uniti, da un lato, Russia e Cina dall’altro. In Mali, come si diceva, si è giocato un braccio di ferro volto ad ottenere un’influenza parziale sul Sahel, la nuova frontiera della Jihad islamica, più attiva qui che in Medio Oriente. È lo snodo cruciale per esercitare un’influenza sui flussi migratori da Sud verso le spiagge del meridione italiano o della Spagna, un’ipoteca in grado di esercitare una forte pressione nei confronti dell’Unione Europea. Si tratta, nel Sahel, di stati sensibili alle destabilizzazioni ed in cui il blocco delle esportazioni di grano e di mais dai porti ucraini potrebbe portare a delle carestie. La strategia del Cremlino, consapevole dell’influenza che esercita sulla Libia, guarda quindi alla possibilità di usare la sua presenza in Africa e la crisi alimentare per generare instabilità e aumentare i flussi migratori. Mosca otterrebbe così non solo uno strumento di pressione nei confronti dell’Europa, ma potrebbe anche fornire argomenti a quei partiti che sono storicamente vicini al Cremlino.
LO STRAPOTERE DI PECHINO
Una qualsiasi panoramica sull’Africa non può però prescindere da una considerazione: lo strapotere assoluto della Cina, confermato dai dati dell’interscambio commerciale e dalla mole degli investimenti diretti. Secondo l’«Amministrazione generale delle dogane di Pechino», il commercio bilaterale totale nel 2021 ha raggiunto i 254,3 miliardi di dollari, in crescita del 35,3% su base annua. L’Africa ha esportato 105,9 miliardi di dollari di merci in Cina, un valore in crescita del 43,7% anno su anno. La Cina, dunque, è il principale partner commerciale dell’Africa da dodici anni. A ciò si aggiungono gli investimenti infrastrutturali. Le banche di sviluppo cinesi hanno prestato più del doppio rispetto a quelle di Stati Uniti, Germania, Giappone e Francia messe insieme. Se si considera il periodo 2007-2020, la China Exim bank e la China development bank hanno erogato finanziamenti per 23 miliardi di dollari, mentre tutte le altre principali istituzioni finanziarie per lo sviluppo messe insieme hanno erogato solo 9,1 miliardi di dollari.
DENARO CON CLAUSOLE CAPESTRO. E L’INDA DEI CONTADINI
La Cina non presta denaro gratis, ma si garantisce nella restituzione dei denari prestati stipulando clausole spesso capestro. Un esempio significativo da questo punto di vista è Gibuti, dove ha sede la prima base permanente all’estero della Cina. Pechino ha investito 15 miliardi di dollari per lo sviluppo del principale porto e delle infrastrutture collegate. L’82% del debito estero è detenuto da Pechino e in caso di inadempienza, Gibuti potrebbe cedere ai cinesi il controllo del porto strategico di Doraleh, all’ingresso del Mar Rosso e del Canale di Suez.
Un altro esempio. Il porto di Mombasa (Kenya), tra i più frequentati dell’Africa orientale, è stato utilizzato come garanzia per il prestito di 3,2 miliardi di dollari utilizzati per la costruzione della linea ferroviaria di 470 chilometri tra Mombasa e Nairobi. Se il Kenya non salda il debito, la Exim Bank of China ne assumerà il controllo. Cresce intanto la pressione militare. La Cina già dispone della base di Gibuti, ma, secondo gli Usa, sono in corso contatti con altri 12 Paesi per creare strutture logistiche per supportare le forze navali, aeree e di terra.
L’INFORMAZIONE IN MANO ALL’AGENZIA XINHUA
Ancor più impressionante è il movimento migratorio verso l’Africa: la Cina oltre ad esportare in Africa beni esporta manodopera agricola proveniente dalle sue zone rurali. Negli ultimi cinque anni ha investito 5 miliardi di dollari nell’agricoltura in Africa. L’intenzione di Pechino è quella di delocalizzare la produzione di cibo. Tutto ciò sta accadendo in Zambia, Uganda, Tanzania e Zimbabwe. Pechino, infine, ha lanciato la sua sfida nel mondo dell’informazione. L’agenzia cinese Xinhua ha più di 30 uffici di corrispondenza in tutto il Continente. Si può dire che il continente africano che conosciamo oggi e di cui abbiamo notizia è in buona parte ciò che la Cina desidera si conosca.
IL GIOCO DELLE POTENZE
Il grande gioco delle potenze investe così un Continente potenzialmente ricco ma su cui incombono emergenze drammatiche. il Fondo Monetario Internazionale ne ha individuate tre: il prezzo del cibo, il prezzo dei prodotti petroliferi, il peggioramento del debito. In particolare:
- L’85% del grano consumato è d’importazione, non di rado principalmente dalla Russia e dall’Ucraina. In Kenya, ad esempio, il 33% del grano importato proviene da questi due Paesi, mentre nel caso della Tanzania questa cifra sale al 70%. Dall’inizio della guerra si è scatenata la corsa dei prezzi, con conseguenze gravissime per tutte le famiglie africane che destinano al cibo il 40% delle proprie entrate. Col progredire della guerra la situazione è destinata solo a peggiorare anche per l’aumento dei fertilizzanti, di cui Russia e Ucraina sono fra i maggiori produttori, sia con l’aumento dei carburanti per i macchinari. Un insieme di elementi che riducono sin d’ora, e considerevolmente, il livello di sicurezza alimentare dei Paesi africani, minacciando in particolare i poveri delle aree urbane.
- Il Fmi ha calcolato che ai Paesi africani importatori di petrolio l’aumento della bolletta energetica comporterà nel 2022 un maggiore esborso collettivo stimato in 19 miliardi di dollari. E sebbene sia vero che i produttori di petrolio esistenti nell’area subsahariana beneficeranno degli aumenti, l’effetto sarà solo parziale perché per assurdo molti di loro pur producendo petrolio debbono importare benzina a causa del fatto che non dispongono di impianti di raffinazione. Valga come esempio la Nigeria che pur essendo il primo produttore africano di petrolio, importa tutta la benzina che le serve. L’Opec certifica che nel 2020 la Nigeria ha speso 71,2 miliardi di dollari per l’importazione di prodotti petroliferi raffinati, mentre dalla vendita di petrolio grezzo ha incassato 27,7 miliardi di dollari. Un saldo negativo di oltre 43 miliardi di dollari.
- L’aumento del prezzo del cibo, dei fertilizzanti, dei prodotti energetici, non farà altro che peggiorare il debito commerciale dei Paesi africani contribuendo alla lievitazione del loro indebitamento. Gli ultimi dati disponibili riferiti al 2020 dicono che il debito estero complessivo dell’Africa subsahariana ammonta a 702 miliardi di dollari, per il 65% a carico dei governi. E considerato che il biennio 2020-2021 è stato un periodo orribile per tutti a causa del Covid, il Fmi teme che gli choc provocati dalla guerra all’Ucraina possano mettere definitivamente al tappeto molti governi africani che durante il Covid hanno visto accrescere i propri deficit a causa di una riduzione del gettito fiscale e un aumento delle spese pubbliche, soprattutto di carattere sanitario. Metà dei Paesi a basso reddito dell’area subsahariana sono già ad alto rischio di bancarotta. E ora il rischio si fa più concreto, visto e considerato che il mancato rilancio economico dovuto all’aumento dei prezzi mondiali limiterà ulteriormente i gettiti fiscali, mentre le spese pubbliche sono destinate a crescere ancora per due ragioni principali. Da una parte per sostenere i cittadini alle prese con l’aumento dei prezzi di beni di prima necessità, dall’altra per tamponare la spesa per interessi che i tassi in salita stanno facendo correre.
ENERGIA, IN BALLO 100 MILIARDI DI INVESTIMENTI
È questa la cornice in cui l’Europa, Italia in testa, gioca la sua partita per fare dell’Africa, oggi frontiera meridionale fragile, la sua grande occasione di sviluppo, a partire dall’alleanza per lo sfruttamento delle materie prime, purché in un’ottica win-win, come chiedono sempre più spesso i governi. Lo scoppio del conflitto ucraino, l’embargo dell’Unione Europea sul petrolio russo e, soprattutto, i limiti la riduzione e lo stop minacciato sulle forniture di gas da Mosca, hanno accelerato la corsa verso le risorse dell’Africa in scia all’avanzata di quei gruppi, Eni in testa, che da tempo avevano avviato un asse privilegiato con il Continente (Eni già oggi ricava più di metà del suo petrolio e destina più del 50 per cento dei propri investimenti a quest’area del mondo). L a strategia sta dando i suoi frutti: oltre all’accordo con l’Algeria, ormai il primo fornitore di gas del Bel Paese (più di 30 miliardi di metri cubi) figurano gli accordi con Angola e Congo, dove Eni ha relazioni d’affari consolidate e peculiari, cui presto seguiranno Gabon e Mozambico. «Lo scenario energetico è cambiato in maniera irreversibile per i prossimi anni, anzi decenni. E l’Africa avrà la sua grande occasione», ha detto Luca Bertelli, responsabile del settore esplorazioni del cane a sei zampe, braccio destro di Claudio Descalzi, 41 anni di Eni alle spalle. Secondo gli studi del centro di ricerche Rystad l’Africa ha enormi potenzialità nel gas. Tanto da poter raddoppiare la produzione da 260 ad oltre 500 milioni di metri cubi entro il 2030. Stime troppo ottimistiche per l’Agenzia internazionale dell’Energia che sostiene che il picco, comunque inferiore ai 300 milioni di metri cubi, verrà toccato in ogni caso già nel 2024. E dunque entro la fine del decennio l’Africa assicurerà almeno un quinto dei flussi di gas necessari all’Europa, anche attraverso i nuovi gasdotti, a partire da quello che collegherà Nigeria ed Algeria attraverso il Niger. Ma la prudenza quando si parla di Africa è sempre d’obbligo: quest’anno verranno estratti non più di 6 milioni di barili, assai meno dei 10 milioni del 2010 nonostante le potenzialità di nuovi mercati (Namibia e Tanzania che potrebbero presto garantire mezzo milione di barili in più).
PETROLIO, LE INCOGNITE DEL DOPO UCRAINA
Il prezzo del petrolio, passata l’emergenza Ucraina, non promette scintille. Anzi, sul mondo incombe il giudizio dell’Aie che solo12 mesi fa consigliava di non investire più nelle energie fossili. Di fronte a questa prospettiva sia le Big Oil occidentali che gli stati interessati si mostrano cauti di fronte alla prospettiva di grandi investimenti in gas e petrolio che tra non molti anni, vista la crescita delle rinnovabili, potrebbero rivelarsi un pessimo collocamento. Di qui la vera sfida: combinare gli sforzi nell’esplorazione dei nuovi giacimenti con lo sviluppo delle infrastrutture per le nuove energie a partire dallo sfruttamento dell’idrogeno verde. Questa appare la vera prova che può rilanciare il ruolo dell’Europa in Africa: investire oggi nel gas ma con un occhio già rivolto al futuro post-oil. È quanto si propone tra altre cose l’Eni, che ha avviato in diversi Paesi iniziative per lo sviluppo della filiera dei biocarburanti prodotti da materie prime sviluppate in terreni marginali, molto degradati (per esempio deserti) con già ottimi risultati in Kenya. Il futuro dunque sembra arrivato, ora non resta che buttarcisi e decidere che ruolo avere.

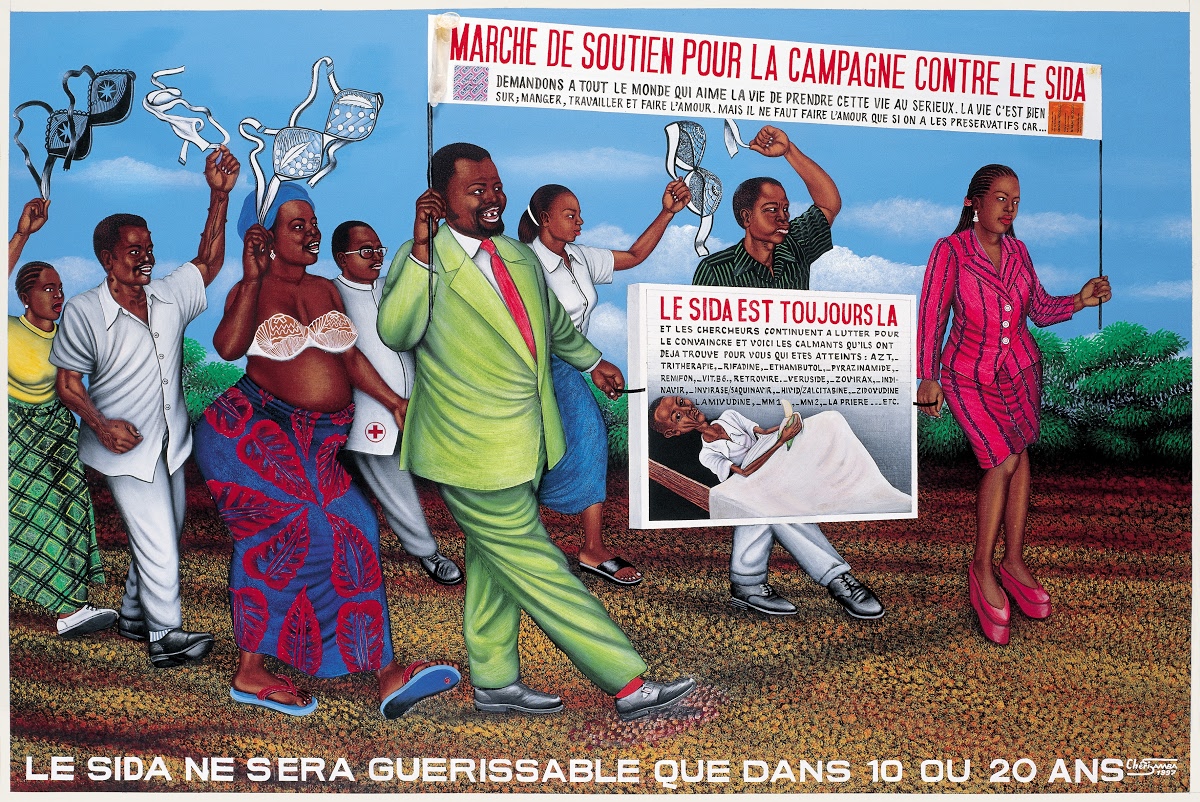




_upR9F.jpg)
_Dd4VV.jpeg)
