Questa settimana la Repubblica Democratica del Congo ha deciso di dare il via ad un’asta per l’assegnazione dei diritti di estrazione delle riserve petrolifere del Paese, il secondo per dimensioni in Africa, il sesto al mondo per il patrimonio forestale. La notizia ha scatenato le proteste degli ambientalisti: il bacino del Congo è una delle più preziose ricerche ambientali del Paese. Ebbene queste proteste mi sembrano ipocrite ed inefficaci. La guerra in Ucraina ha spinto l’Occidente a riaprire miniere di carbone e a sollecitare il Medio Oriente perché aumenti la produzione di petrolio. Perché i Paesi più poveri, che tra l’altro pagano più caro cibo ed energia, dovrebbero rinunciare all’occasione di sfruttare l’aumento dei prezzi come fanno i petrolieri del Medio Oriente o di Houston?
Dal punto di vista etico le accuse sono al tempo stesso assurde ed inefficaci. Assurde perché i Paesi poveri, come la Repubblica Democratica del Congo, non solo sono i meno colpevoli per i livelli attuali di CO2 nell’atmosfera ma non hanno i mezzi finanziari per adattarsi al riscaldamento globale. I loro leader sono in genere consapevoli dei rischi dell’ambiente: il presidente del Congo, Felix Tsikehedi ha detto già un anno fa che l’Africa rischia di perdere il 15% del pil prima del 2030 a causa della crisi climatica. Per questo, ha chiesto un contributo di 5 miliardi di dollari per i prossimi cinque anni per affrontare l’emergenza. Non ha ricevuto nulla, salvo promesse. C’è da stupirsi se ha perso la pazienza? Il Congo, del resto, è solo il primo tra i Paesi più poveri che decide di far da solo, in assenza di un intervento concreto delle nazioni più ricche, responsabili di gran parte dell’inquinamento. Un politico indiano, ad esempio, mi ha detto che il Paese, investito in primavera da un’ondata di caldo estremo, sarà presto costretto a riaprire le miniere di carbone per consentire alle centrali elettriche di funzionare anche in condizioni estreme.
L’indignazione, poi, è fuori luogo. Sia le democrazie che le dittature devono rispondere alle esigenze immediate delle popolazioni prima che affrontare le esigenze del cambiamento climatico. E non è possibile imporre uno stop dall’esterno: anche se le compagnie occidentali si astenessero dalla gara, i Cinesi sarebbero ben lieti di aumentare la loro presenza nella regione.
Insomma, la cosa migliore è che il mondo paghi il Congo perché eviti lo sfruttamento delle sue risorse petrolifere. Sul piano morale, se volete, è solo una modesta compensazione per le sofferenze imposte dal colonialismo. Dal punto di vista pratico è la soluzione più efficace. Il problema non è solo finanziario. Vanno elaborate caso per caso le soluzioni più efficaci sulla base del modello adottato a Glasgow per il Sud Africa: un contributo (8,5 miliardi di dollari) a fronte della chiusura delle miniere di carbone. Per il Congo, la soluzione non può essere limitata al petrolio ed al gas. L’intervento deve riguardare il bacino del fiume Congo, la grande ricchezza in parte inesplorata. Qui sorge una vecchia centrale idroelettrica che andrebbe sostituita da un nuovo impianto necessario per portare i servizi essenziali alla popolazione. Ma, salvo i cinesi, nessuno si è fatto avanti per finanziare l’investimento che rischia di saltare nel caso si proceda alla deforestazione per favorire l’estrazione del greggio.
Perché la finanza verde, così prodiga di promesse, non s’impegna a sostenere questo investimento? I capitali non mancano. Sia la UE che gli Stati Uniti spendono cifre imponenti per «catturare» la CO2 immessa nell’atmosfera. Proteggere uno dei serbatoi naturali più preziosi costerebbero molto meno, con risultati più immediati ed efficaci.
Certo, l’obiettivo di un mondo ad emissioni zero è affascinante ed accattivante sul piano politico. Ma non dimentichiamo che dobbiamo fare presto. Entro il 2030 le economie emergenti dovranno prendere le decisioni strategiche più importanti per il loro sviluppo. È adesso che l’Indonesia deve rinunciare o meno al carbone, il Congo al suo petrolio. È il momento delle scelte, non delle prediche.


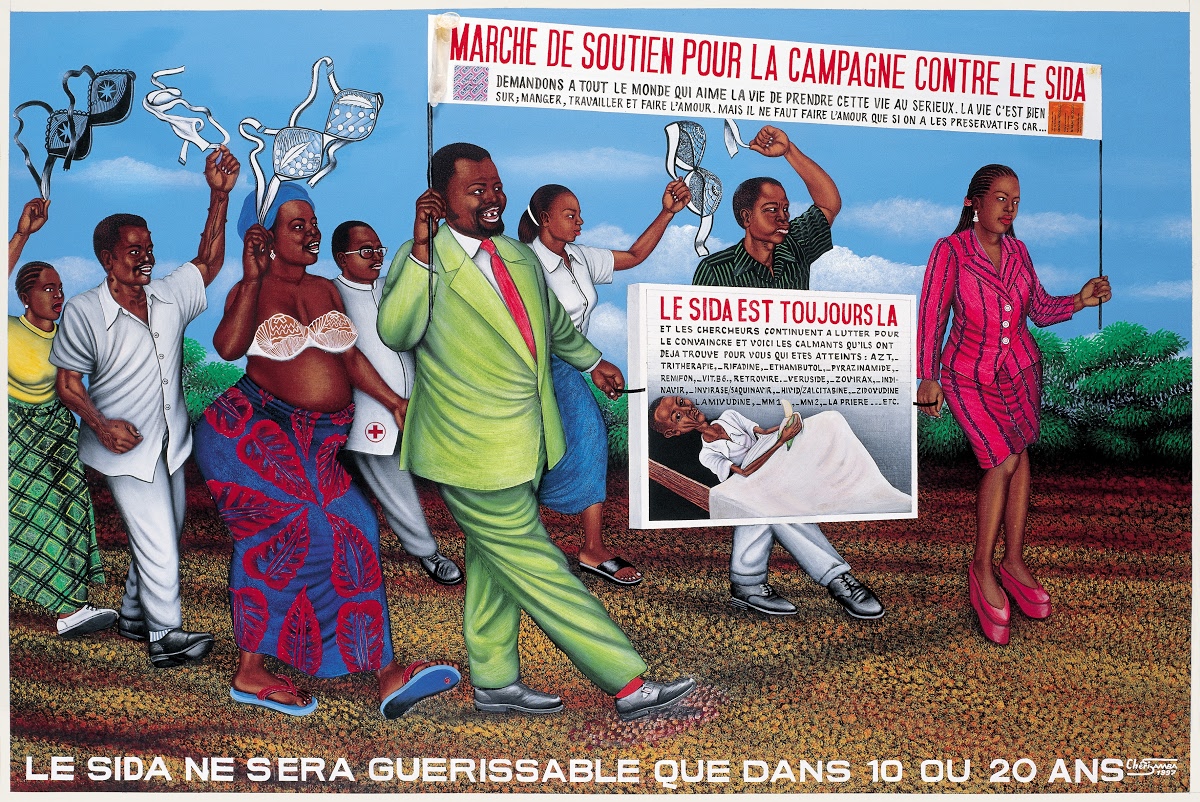
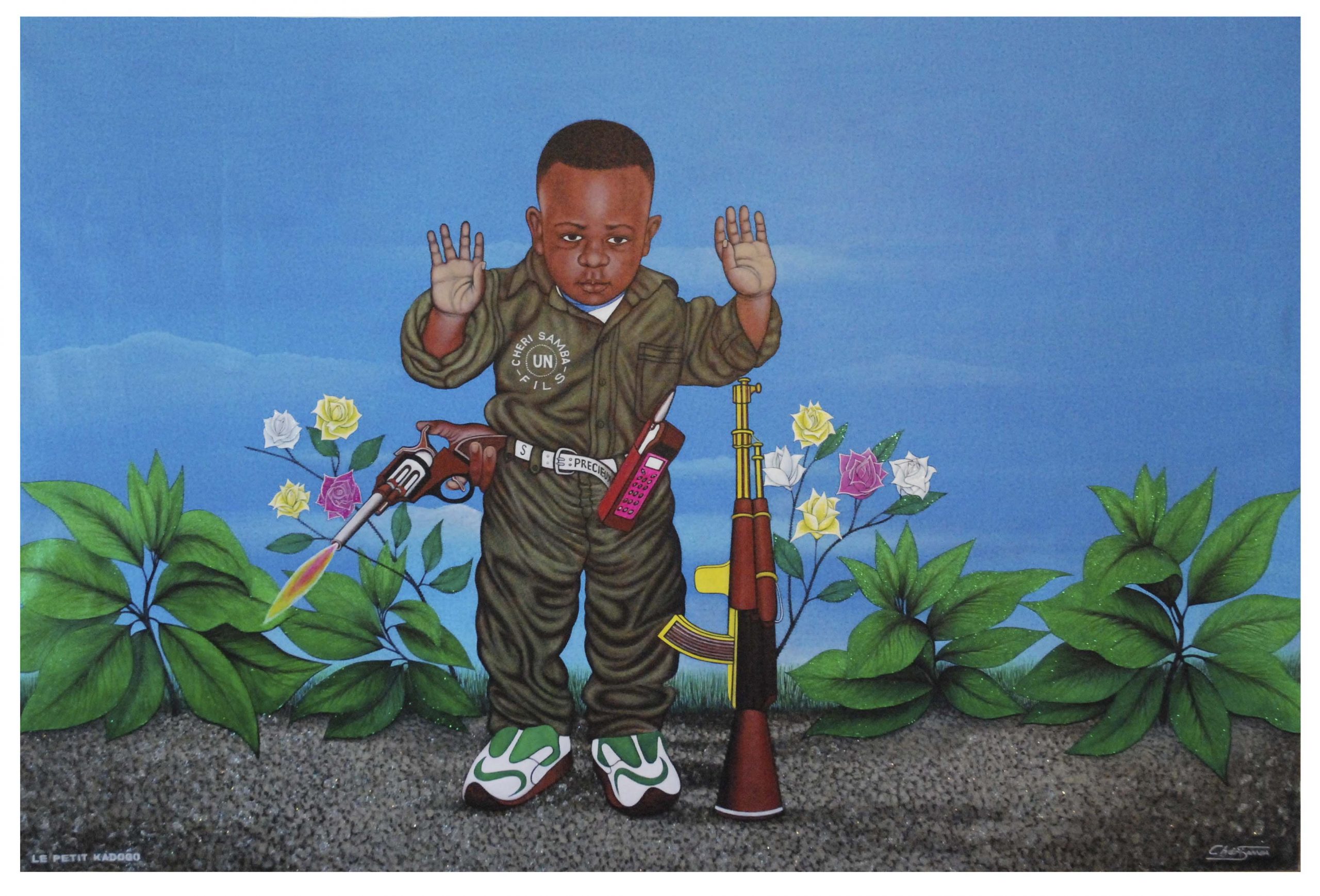



_upR9F.jpg)
_Dd4VV.jpeg)
