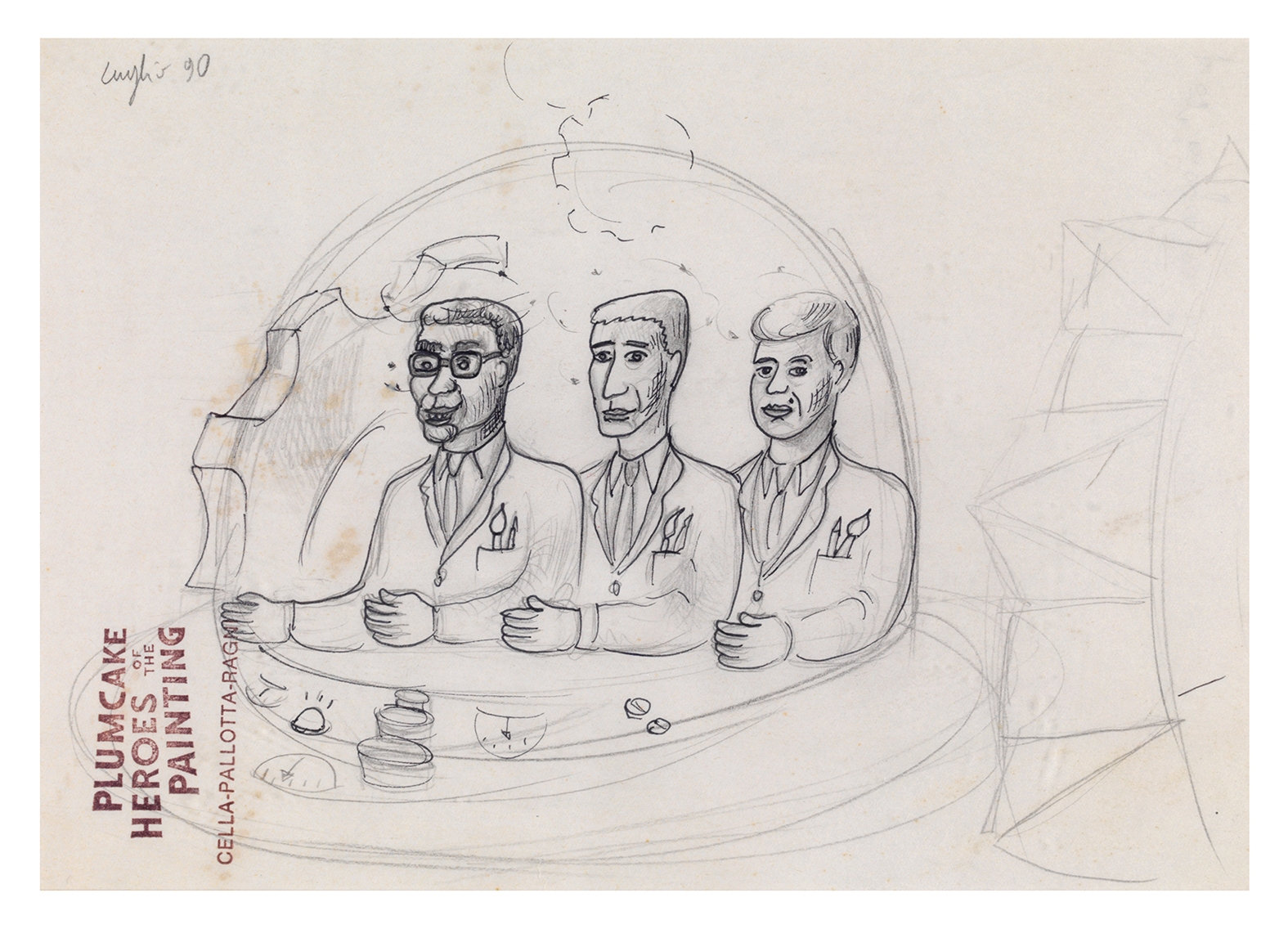L’impresa più grande di Megan Rapinoe nel 2019 non è stata vincere i Mondiali di calcio femminili, né conquistare il titolo di capocannoniere con 6 gol – di cui 5 arrivati nella fase a eliminazione diretta, quando contano più – e nemmeno ricevere il Pallone d’Oro insieme a Lionel Messi. Nell’anno appena concluso, la capitana della nazionale americana con i capelli color lavanda – un omaggio alla comunità Lgbt – è riuscita infatti a portare sul palcoscenico internazionale le sue battaglie per i diritti civili, per i diritti gay e per l’equità dei compensi fra uomini e donne, divenendo un personaggio globale durante il Mondiale francese. Negli Stati Uniti la sua forza politica era però emersa già da tempo. A gennaio, per esempio, aveva dichiarato in un’intervista che, in caso di vittoria, non sarebbe andata «alla cazzo di Casa Bianca» a ricevere le congratulazioni del presidente Donald Trump, come da tradizione nello sport americano. All’epoca non c’erano state conseguenze ma, quando il cammino delle ragazze a stelle e strisce si è trasformato in una marcia trionfale, il video della sua intervista è riemerso facendo infuriare il già irascibile comandante in capo americano. Che, per tutta risposta, l’ha invitata via Twitter a finire il lavoro, prima di parlare. Ovvero vincere il Mondiale.
Rapinoe non si è fatta pregare, né intimorire. Insieme alle sue compagne ha vinto il torneo il 7 luglio e tre giorni dopo è tornata in patria, presentandosi particolarmente ispirata – e visibilmente ubriaca – alla parata di New York: è salita sul palco con indosso gli occhiali da sole e una t-shirt celebrativa, ha allargato le braccia in una posa elastica e si è lanciata in un discorso travolgente. «Dobbiamo essere migliori. Dobbiamo amare di più. Odiare di meno. Dobbiamo ascoltare di più, e parlare di meno. Dobbiamo sapere che è responsabilità di ognuno di noi — ogni singola persona che è qua, ogni singola persona che non c’è, ogni singola persona che non vuole essere qua, ogni singola persona che è d’accordo e non è d’accordo — è nostra responsabilità rendere questo mondo un posto migliore», ha affermato davanti alle scale del municipio newyorkese.
«C’è stata tanta tensione in questi ultimi anni: ne sono stata vittima e ne sono stata responsabile con la nostra lotta contro la federazione (per l’equità dei salari, ndr): mi dispiace per alcune delle cose che ho detto. Non tutte», ha concluso fra le risate. «Ora è il momento di tornare uniti, e di portare il confronto a un altro livello. Dobbiamo collaborare e c’è bisogno di tutti. Questo è il mio compito per tutti noi: fate ciò che potete, fate ciò che dovete fare, liberatevi. Siate qualcosa di più, siate migliori, siate più grandi di quanto non siete mai stati prima».
A 34 anni, Megan Rapinoe non è una giovane promesse né la più forte delle giocatrici americane, ma con il suo attivismo politico si è presa tutta la scena nel momento in cui il calcio femminile ha raggiunto il massimo della popolarità. Franklin Foer, sull’Atlantic, l’ha definita il «Muhammad Ali di questa generazione»: come lui, Rapinoe è spavalda e ha un umorismo scaltro – ha scritto Foer, grande appassionato di calcio – «ma soprattutto è diventata un eroe della resistenza. Con il suo esempio ha spiegato al mondo come giocare a calcio e come dissentire. Il suo impegno politico, la sua persona pubblica e il suo stile di gioco sono una cosa sola: in ognuna di queste cose è intrepidamente aperta, oltraggiosamente gioiosa e sfrontatamente vera verso se stessa. A renderla un’attivista così potente è la totale assenza di calcoli». Per Rapinoe il seguitissimo mondiale francese – solo negli Stati Uniti 14 milioni di spettatori hanno seguito in televisione la finale – è stato dunque una piattaforma fenomenale per rendere pop le sue battaglie. «Non puoi vincere un mondiale senza avere dei gay in squadra», aveva detto durante il torneo, non curandosi del fatto che il mondo dello sport sia restio a parlare di omosessualità.
«Essendo un’americana gay, so cosa significa guardare la bandiera e sapere che non protegge le mie libertà», aveva dichiarato tempo prima, per spiegare la sua decisione di inginocchiarsi durante l’inno nazionale che in America precede ogni incontro sportivo, prima che la federazione la obbligasse a smettere. Da allora, però, non ha più cantato lo Star Spangled Banner, né ha portato la mano al cuore. Il discorso pronunciato in quell’assolata mattinata newyorkese è stato quindi il culmine di un percorso cominciato in silenzio, sull’esempio di Colin Kaepernick, il giocatore di football che nel 2016 aveva deciso di inginocchiarsi durante l’esecuzione dell’inno per protestare contro il razzismo sistemico degli Stati Uniti – quello delle istituzioni che discriminano i neri – e che, con un semplice gesto, aveva dato l’ultimo colpo alla linea sempre più sottile che separava lo sport e la politica. Era stato proprio lui a ispirarne l’attivismo, come Rapinoe non ha mancato di ricordare quando a novembre le è stato assegnato da Glamour il premio di donna dell’anno. «Non credo che sarei qui, se non fosse stato per lui: ha dimostrato coraggio e audacia, senza paura delle conseguenze», ha spiegato la calciatrice americana. «Mi gratificano l’attenzione e il successo personale, in gran parte dovuti all’attivismo fuori dal campo, ma Colin Kaepernick è ancora fuori dalla NFL». In effetti, Kaepernick ha smesso di giocare a football il 26 agosto 2016, nel giorno in cui si è inginocchiato per la prima volta. Aveva 28 anni, non era mai stato un fuoriclasse, ma in sei stagioni con indosso la maglia numero 7 dei San Francisco 49ers era anche riuscito a raggiungere un Super Bowl.
«Non cerco approvazione, devo battermi per le persone oppresse», disse dopo quella gara contro i Green Bay Packers. Il suo esempio è stato seguito da numerosi colleghi – a cominciare dal compagno Eric Reid e dalla stessa Rapinoe, il primo sportivo bianco a imitarne il gesto – mentre altri lo hanno criticato, tutti seguendo le linee della feroce polarizzazione politica che in questi anni ha spaccato a metà gli Stati Uniti, mai così divisi e arrabbiati.
Quando nel settembre 2017 Trump disse che i proprietari delle franchigie NFL dovevano licenziare coloro che lo imitavano, Kaepernick era ormai senza squadra da quasi un anno – ha giocato la sua ultima partita il 1° gennaio 2017 contro i Seattle Seahawks – e poco dopo, insieme a Reid ha fatto vertenza alla lega: i proprietari, sostenevano, si erano accordati per tenerli fuori. Questi ultimi, invece, ribattevano che Kaepernick e Reid avessero fatto perdere spettatori a un campionato seguito per lo più da un pubblico conservatore. Il caso è stato chiuso con un accordo privato, ma nel frattempo Kaepernick è diventato un simbolo dell’attivismo americano anche grazie a una pubblicità della Nike uscita nel 2018: un primo piano in bianco e nero e, sotto gli occhi malinconici del quarterback, la frase Believe in something. Even if it means sacrificing everything. «Credi in qualcosa, anche se significa sacrificare tutto».
Le proteste di Kaepernick e Rapinoe non sono però isolate, anche perché negli Stati Uniti l’elezione di Trump nel 2016 ha acceso un fervente attivismo «da entrambe le parti» (per usare parole sue). Ci sono stati il tweet a favore di Hong Kong del general manager degli Houston Rockets Daryl Morey, che in ottobre ha scatenato una controversia diplomatica e ha portato la Cina ad oscurare le partite NBA, oppure il boicottaggio delle squadre che hanno rifiutato l’invito alla Casa Bianca per festeggiare i propri trionfi, come fatto dalla nazionale femminile ma anche dai Golden State Warriors, dai cestisti della University of North Carolina e dai Philadelphia Eagles di football. Citando proprio Kaepernick o la battaglia delle calciatrici americane, in estate il professore di sociologia della University of Southern California Ben Carrington ha spiegato al Washington Post che «il confine che molti provano a tirare fra sport e politica ormai è completamente offuscato». Anzi, ha puntualizzato, «quel confine è sempre stato artificiale». Guardando alla Storia, in effetti, sport e politica si sono incrociati spesso. Nel 1967 ad esempio Muhammad Ali si rifiutò di partire per il Vietnam e fu arrestato per renitenza alla leva: si opponeva al conflitto e, oltre al titolo mondiale, perse anche la possibilità di combattere per tre anni. Nel 1978 Tommie Smith e John Carlos alzarono un pugno chiuso avvolto in un guanto nero sul podio dei 200 metri alle Olimpiadi di Città del Messico per protestare contro la discriminazione razziale e per sostenere il Potere Nero. Nel 1986 l’Argentina si aggiudicò la rivincita della guerra delle Falkland sconfiggendo ai quarti del Mondiale – sempre in Messico – l’Inghilterra grazie a due mitologici gol di Diego Armando Maradona che valsero ben più di una partita.
In Italia, nel pieno degli Anni di piombo, un calciatore arrivò a scrivere un libro politico: era il 1976 quando il centrocampista del Perugia Paolo Sollier pubblicò Calci, sputi e colpi di testa, con cui raccontava la propria militanza in Avanguardia operaia. Ex dipendente della Fiat a Mirafiori, Sollier era in effetti più noto per la partecipazione politica che per le sue prestazioni muscolari, a cominciare dall’iconografico pugno chiuso che rivolgeva ai tifosi della Curva Nord perugina. Il suo era un messaggio politico rivolto ai tifosi, come lo erano quelli di Cristiano Lucarelli e Paolo Di Canio nei primi anni Duemila: il primo giurava amore ai sostenitori del Livorno col pugno chiuso dopo aver rinunciato «al miliardo», come scrisse nella sua autobiografia raccontando la decisione di lasciare un remunerativo contratto con il Torino per tornare a casa; il secondo incitava quelli laziali col braccio teso, che lo rese (ancora di più) un simbolo per la sua tifoseria. Se questi erano però gesti sporadici, nel tumultuoso decennio appena concluso sport e politica hanno cominciato a sovrapporsi con regolarità, anche a causa di una situazione geopolitica globale che ha trasformato lo sport in una piattaforma fondamentale per la diffusione di messaggi politici e in un importante strumento di soft power. Il cestista turco dei Boston Celtics Enes Kanter, ad esempio, si è ritrovato senza passaporto e ha una richiesta di estradizione pendente da un anno per essersi schierato contro il presidente Recep Tayyp Erdogan e a favore del suo oppositore Fethullah Gülen, l’accademico accusato di aver organizzato il golpe del 15 luglio 2016: in patria le sue partite sono censurate, non può viaggiare all’estero con la sua squadra per evitare il rischio di essere arrestato (come suo padre, professore di genetica) e, soprattutto, è stato ripudiato – non si sa quanto volontariamente – dal resto della sua famiglia.
«Quello che cerco di fare è molto più grande della mia famiglia, che è solo una rispetto alle migliaia che hanno una storia peggiore della mia. Per questo voglio creare consapevolezza di quello che succede là fuori», ha spiegato il 27enne al sito Vox, chiarendo il suo doppio ruolo di giocatore professionista di basket e di attivista per la democrazia. «Penso che la NBAN mi dia una grande piattaforma, ed è per questo che cerco di essere una voce per tutti gli innocenti che non ne hanno».
Lo stesso è capitato all’ex centravanti di Inter, Torino, Parma e Galatasaray Hakan Şükür, un idolo nazionale accusato di aver appoggiato Gülen e costretto, a 48 anni, a guadagnarsi da vivere come autista di Uber in esilio nei sobborghi di Washington. Dall’altro lato della barricata c’è il calciatore tedesco di origini turche Mesut Özil, che a maggio 2018 si è fatto fotografare con Erdogan, proprio mentre il presidente riempiva le prigioni di oppositori: migliaia di politici, attivisti, giornalisti e scrittori, fra gli altri, sono ormai in cella da anni. Nonostante il fantasista dell’Arsenal abbia sostenuto che non avesse fini politici, in Germania quello scatto non gli è stato perdonato e ha contribuito ad allontanare il giocatore dal proprio Paese e ad avvicinarlo alla terra dei suoi nonni (partiti da Zonguldak, nel nord della Turchia). Il 31enne ha finito per ritirarsi dalla nazionale accusando i tedeschi di razzismo, poi, lo scorso giugno, si è sposato a Istanbul con Miss Turchia 2014, non ha invitato gli ex compagni con cui ha vinto un Mondiale nel 2014 e ha scelto come testimone di nozze proprio il presidente. Lo stesso sultano a cui, in ottobre, la nazionale turca ha rivolo un saluto militare dal campo nel pieno dell’operazione militare contro i curdi nel Nordest della Siria: prima per celebrare la vittoria contro l’Albania arrivata all’ultimo minuto, poi per festeggiare il gol del pareggio di Kaan Ayhan contro la Francia qualche giorno dopo. Il loro allenatore Senol Günes disse che quel saluto altro non era che un gesto d’incoraggiamento per i soldati impegnati in Siria, ma ci credettero in pochi: il ministro dello Sport francese Roxana Maracineanu chiese alla Uefa di intervenire e numerosi politici si riversarono su Twitter pretendendo l’annullamento della partita. Poi, a dicembre, lo stesso Özil è stato letteralmente cancellato dalla Cina dopo un tweet contro le persecuzioni degli uiguiri, la minoranza musulmana nel Nord-ovest della repubblica popolare: è sparito dai videogiochi, dai siti internet e le partite dell’Arsenal non vengono più trasmesse in tv.
«Il calcio è politica, che gli piaccia o no», ha scritto nella sua newsletter di fine decennio Rory Smith, fenomenale corrispondente per il calcio europeo del New York Times, parlando dell’ultima disavventura di Özil ma anche di Jürgen Klopp, l’allenatore tedesco del Liverpool che non ha mai nascosto le proprie idee di sinistra e anti-Brexit. Anche il suo acerrimo rivale Pep Guardiola – allenatore del Manchester City – si è schierato politicamente, intervenendo più volte sulla questione catalana. «Ho amici in carcere solo per aver chiesto di votare, condannati a nove anni di prigione», ha affermato a ottobre alla vigilia di una partita contro il Crystal Palace. «Continuerò a difendere i diritti umani contro il razzismo, il machismo e ogni discriminazione», ha aggiunto l’allenatore, che ha sostenuto l’indipendenza dalla Spagna come Gerard Pique, Xavi, Bojan Krkić e Marc Bartra – tutti convocati per l’amichevole della nazionale catalana contro il Venezuela del 25 marzo – e altri giocatori della comunità autonoma.
La conferma che fra sport e politica non esista più un confine è arrivata dalla Major League Soccer che, nonostante abbia provato a restare neutrale, si è dovuta piegare all’uragano Trump. La sua elezione ha portato alla nascita della «Resistenza», un movimento grassroots di sinistra che è sfociato anche nello sport: in campo – come dimostrato da Kaepernick e Rapinoe – e sugli spalti. Il presidente è stato fischiato negli impianti di calcio, football, baseball, basket e persino wrestling di quasi tutto il Paese ma, soprattutto, è riuscito nell’impresa di unire – lui, comandante divisivo – i tifosi dei Portland Timbers e dei Seattle Sounders: acerrime rivali nel derby della Cascadia, le due tifoserie sono state richiamate dalla lega calcistica americana per aver esposto bandiere e stendardi con le Tre Frecce, un tempo simbolo del Fronte di ferro tedesco che si batteva contro il nazismo, oggi usato dal movimento antifa di estrema sinistra per protestare contro l’aumento dei reati d’odio e, implicitamente, proprio contro Trump. Secondo la MLS, i tifosi di Portland e Seattle avrebbero potuto mostrare il simbolo sulle magliette, ma non su bandiere troppo visibili all’interno dello stadio.
È stato a quel punto che le Tre Frecce sono comparse non solo nel Northwest progressista, ma negli stadi di tutto il Paese: da Washington a Orlando, passando per Cincinnati a Oklahoma City. Poi, quando le due squadre si sono affrontate il 23 agosto, i tifosi hanno messo in scena una protesta congiunta, organizzata dagli Emerald City Supporters e dai Gorilla Fc, gruppi ultras di Seattle, e dalla Timbers Army di Portland: 33 minuti di silenzio, come l’anno in cui il Fronte di ferro fu messo al bando dal nazismo, poi l’intero stadio è esploso cantando (la versione inglese di) Bella Ciao.
Foto di Brecht Bug © - Creative Commons Image