George Punga, 15 anni o forse meno, è un créseur. Ovvero è uno delle migliaia (meglio, decine di migliaia) di ragazzi congolesi che si guadagnano da vivere scavando nel sottosuolo di Kolwezi, la capitale del cobalto nel cuore del Congo. Uno di quelli che, scrive Diane Searcey del New York Times in un recente reportage: «Riempiono tutte le mattine la strada per Kolwezi di camioncini o altri mezzi di ogni tipo. Dentro ci sono centinaia di ragazzi in sandali o a piedi nudi decisi ad ogni sacrificio, pronti ad infilarsi in tunnel sporchi e pericolosi pur di assicurarsi un gruzzolo che può cambiare la loro vita: basta una pala per tentare l’avventura». Ma talvolta non è nemmeno necessario calarsi giù in miniera per assicurarsi il prezioso minerale, confida alla reporter il mostro Punga, ragazzo di strada già maestro nell’arte di arrangiarsi. «George – racconta Diane - mi ha portato a Lumunbashi, ai piedi di un’alta montagna nera e compatta di rifiuti, scarti di lavorazione di una vecchia miniera di rame abbandonata anni fa. Ma questi rifiuti altro non sono che cobalto purissimo, minerale un tempo trascurato, oggi prezioso per perché il cobalto impedisce alle batterie a ioni per le auto elettriche di prender fuoco». Di qui l’aumento dei prezzi e quell’euforia febbrile che, da sempre, accompagna la «corsa all’oro»: «Ai piedi della montagna ho assistito ad una scena surreale: gente che scavava mentre un’orchestra suonava e tanti ballavano in una sorta di festa pagana. A celebrare quello che il boom del cobalto potrebbe fare per il Congo», come ipotizzano i banchieri invitati a Kinshasa, dicembre 2021, dal presidente Tshisekedi alla presentazione di un progetto per «sviluppare una catena del valore attorno ad una industria delle batterie». Perché no? Uno studio di Bloomberg certifica che il Congo è sulla carta il Paese più competitivo al mondo per quest’industria, vista la vicinanza delle miniere, l’abbondanza di manodopera e gli spazi a disposizione in una terra dove non esistono i vincoli ambientali in vigore in Europa.
Perché non sognare di assegnare al Congo, cassaforte di cobalto e litio (altra materia prima indispensabile) una parte degli ottomila miliardi di dollari che verranno generati dalla produzione delle batterie nei prossimi vent’anni?
Tante ragioni lasciano pensare che le cose andranno diversamente: l’assenza di infrastrutture, la mancanza di capitali, la fragilità dello Stato, vittima di guerre e di corruzione alimentate dal di fuori. Il Congo ancor oggi sembra condannato ad essere come sempre terreno di scontro tra le superpotenze: da una parte la Cina, che controlla la maggior parte delle miniere del Congo (16 su 21) dallo scorso gennaio divenuto il 45° partner della Via della Seta, dall’altra l’Europa e gli Usa che tentano di recuperare il terreno perduto negli ultimi anni. Almeno dal 2016 quando Washington, ancora scettica sul futuro dell’auro elettrica, non si è opposta all’acquisto da parte di China Molybdenum del controllo di Tenke Fungurume, una gigantesca miniera di rame e cobalto venduta dall’americana Freeport per 2,65 miliardi di dollari. Oggi il governo del Congo cerca di recuperare il controllo di Tenke citando in giudizio i proprietari cinesi per il mancato rispetto degli investimenti che, secondo il contratto, andavano effettuati. Il tribunale, nell’attesa della sentenza, ha affidato per sei mesi la gestione della miniera ad un ex funzionario di Gecamines, l’ente minerario pubblico. Ma sembra difficile che Pechino molli la presa.
«Solo la Cina ha capito l’importanza del cobalto. E così ha preso il controllo delle riserve» ha commentato Ivan Glasenberg, già direttore generale di Glencore, il colosso anglo-svizzero delle commodities. «Se le compagnie cinesi smettessero di esportare le loro batterie- ha aggiunto - la produzione di auto elettriche si fermerebbe in tutto il mondo». E’, della stessa opinione Carlos Tavares, il numero uno di Stellantis che ha messo in luce la vulnerabilità delle forniture per far marciare il sistema: le materie prime chiave sono saldamente nelle mani dei gruppi di Pechino che da vent’anni fanno shopping nei Grandi Laghi, stabilendo legami finanziari e costruendo infrastrutture. Nella convinzione che, come ha scritto Simon Moores sulla rivista dell’Oxford Institute for Energy Studies «coloro che controlleranno le catene del valore legate alle materie prime avranno il controllo sull’equilibrio di potenza industriale per il resto di questo ciclo tecnologico, che potrebbe durare fino all’inizio del XXII secolo».
Poche altre aree del pianeta sono tanto importanti sul piano strategico per il nostro modo di vivere futuro. Perché, in quanto a materie prime, il Congo sta all’auto elettrica come l’Arabia Saudita al petrolio: primo produttore mondiale di cobalto, quarto per le riserve di rame, altro materiale chiave sia per l’auto elettrica che per le infrastrutture delle energie rinnovabili, ai primi posti per le riserve di litio e così via. Una sorta di «scandalo geologico» che vanta anche giacimenti di uranio (da qui arrivò il minerale per le bombe di Hiroshima e Nagasaki) manganese oltre ai tre quarti delle riserve mondiali di coltan (colombo-tantalite) indispensabile anche per la produzione di pc, telefoni portatili. E tanto altro ancora, dai gioielli al petrolio dell’aera di Virunga. Un immenso tesoro che ha generato più dolori che ricchezza al Paese di cui Franz Fanon disse «se l’Africa fosse una pistola, il Congo sarebbe il suo grilletto». Un grilletto premuto in pratica senza interruzioni dalla Conferenza di Berlino di fine ‘800 fino ad oggi, in un clima di violenza endemica ove operano centinaia di formazioni irregolari di cui si parla solo in casi eccezionali, quali l’agguato che è costato la vita all’ambasciatore Attanasio, il carabiniere Iacovacci ed il loro autista.
La pressione del grilletto.
Nessun Paese ha vissuto più guerre, devastazioni ed atrocità varie a partire dall’attribuzione a tavolino del possesso a titolo personale attribuito a re Leopoldo II del Belgio, che diede il via all’impresa coloniale più sanguinaria della storia, costata oltre undici milioni di vittime. La «pressione del grilletto» è proseguita dopo l’indipendenza provocando mille rivoli di sangue culminati nel genocidio della guerra civile in Ruanda che si è presto riflesso nella parte nordorientale della Repubblica Democratica del Congo, scatenando una serie di conflitti che, scrive il sudafricano Mail and Guardian, ha provocato altri sei milioni di morti e due milioni di sfollati, ostaggio di centinaia di milizie mercenarie o dei ribelli del gruppo M23 sostenuto dal Ruanda. Assume un sinistro valore simbolico il gesto del Belgio: Bruxelles ha fatto omaggio al Congo del dente d’oro strappato da un parà prima dell’esecuzione a Patrice Lumumba, il martire della guerra di indipendenza giustiziato nel 1960. Ma l’importanza della posta in gioco è tale che i concorrenti al grande gioco sono pronti a passare oltre a crimini ed ingiustizie.
«C’è più cobalto allo stato puro nelle discariche di Kolwezi che nei giacimenti di altri Paesi. E si tratta di cobalto puro, di eccellente qualità»
si legge nelle cronache da Kinshasa del New York Times sulla moderna cosa all’oro. «Tutto quello che ho visto in un albergo a sette stelle della capitale sapeva di cobalto: ragazzi in smoking, donne elegantissime nei loro tubini neri e nei loro stiletti con scarpe tacco dodici che risuonavano sul pavimento. Nella lobby ci sono sette lampadari monumentali. E la gente sorseggiava espresso con pasticceria secca all’italiana e muesli per colazione guardando quadri di folclore africano da mille dollari in su in attesa di qualche carico di cobalto dalla provenienza incerta». Mica troppo, per la verità.
Ogni giorno buona parte del mezzo milione di abitanti di Kolwezi (erano diecimila solo dieci anni fa) lavora all’estrazione del cobalto sepolto nelle rocce. Una parte nelle miniere industriali, i più come «scavatori artigianali», in alcuni casi autorizzati, il più delle volte clandestini che si intrufolano di notte nelle miniere o scavano per proprio conto, sfidando il rischio di crolli o altri pericoli. Così li descrive un rapporto delle Nazioni Unite: «A tre anni i bambini sanno distinguere il minerale dalle semplici pietre. Non passa molto tempo prima che comincino a trascinare i sacchi dei créseurs adulti. Da adolescenti fanno turni pericolosi nei pozzi. Le donne lavano i minerali che, spesso, sono pieni di metalli tossici, talvolta lievemente radioattivi. Ma non c’è pericolo che tenga di fronte alla prospettiva di partecipare alla festa: i soldati inviati nel 2019 per riportare l’ordine in città, di notte lasciavano il fucile in caserma per trasformarsi in Créseurs». Erano scavatori bambini le quaranta vittime di una recente frana in miniera. «Ma il mattino dopo la tragedia – dice un funzionario -i minatori artigianali si sono intrufolati di nuovo dentro il tunnel ed hanno ripreso a scavare». In cambio di poche centinata di dollari che, a quelle latitudini, possono rappresentare una fortuna.


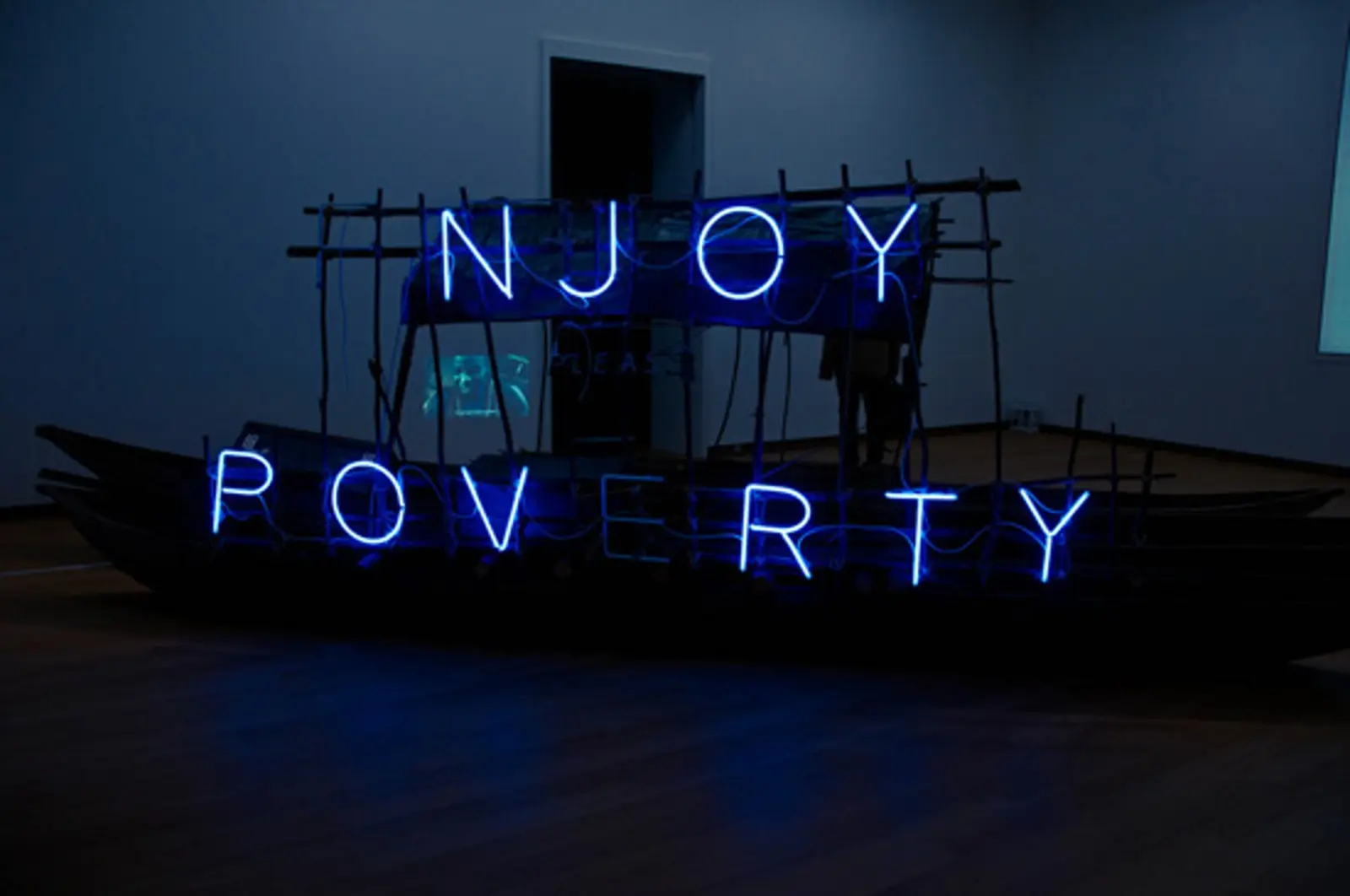



_upR9F.jpg)
_Dd4VV.jpeg)
